Religione Romana e Islam: convergenza o divergenza?
di Claudio Mutti - Enrico Galoppini - 14/02/2016
Fonte: Il Discrimine
Prof. Mutti, è nota l’avversione degli studiosi accademici, così come quella degli “esclusivisti” di tutte le religioni, a considerare la fondamentale “unità trascendente delle religioni”, corroborata dagli studi dei vari esponenti del cosiddetto “tradizionalismo”. Gli elementi addotti da questi ultimi, tratti dalle tradizioni religiose più diverse, non sono derubricabili come le invenzioni di ambienti interessati a creare una sorta di ideologia (come sostengono i loro detrattori), anche perché nessuno di loro ha mai dichiarato che per partecipare alle influenze spirituali di cui ogni tradizione è veicolo ci si possa esimere dall’aderire, come credo e pratica, ad una specifica “via”, seppure con tutti gli adattamenti dovuti alle condizioni ‘ambientali’ ed individuali nelle quali ciascuno si trova. È così o sbaglio?
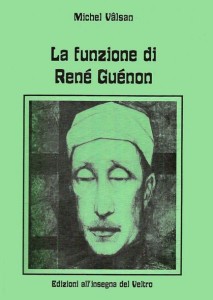 Nessun esponente dell’ortodossia tradizionale ha mai sostenuto che sia possibile beneficiare delle influenze spirituali insite in una forma della tradizione senza accettarne la rispettiva dottrina e senza praticarne i riti. Nell’articolo intitolato Necessità dell’exoterismo tradizionale (diventato un capitolo di Iniziazione e realizzazione spirituale) René Guénon osserva che, prima di costruire un edificio, bisogna gettarne le fondamenta, le quali dovranno sorreggere tutta quanta la struttura, comprese le parti più alte; le fondamenta resteranno sempre, anche quando l’edificio sarà terminato. Con questa immagine, Guénon vuol significare che l’adesione ad un exoterismo tradizionale costituisce una condizione ineludibile per avere accesso all’esoterismo corrispondente e che il ricollegamento iniziatico, una volta ottenuto, non dispensa affatto l’iniziato dalla pratica exoterica. Perciò il cosiddetto “pensiero tradizionale” (che alcuni con un orribile neologismo d’origine anglosassone chiamano “perennialismo”) non utilizza gli elementi provenienti dalle diverse forme tradizionali al fine di costruire una propria sincretica dottrina, bensì per mettere in luce, attraverso le analogie sostanziali e significative riscontrabili fra gli elementi suddetti, la comune provenienza delle varie forme tradizionali da un’unica fonte, e quindi la loro essenziale unità.
Nessun esponente dell’ortodossia tradizionale ha mai sostenuto che sia possibile beneficiare delle influenze spirituali insite in una forma della tradizione senza accettarne la rispettiva dottrina e senza praticarne i riti. Nell’articolo intitolato Necessità dell’exoterismo tradizionale (diventato un capitolo di Iniziazione e realizzazione spirituale) René Guénon osserva che, prima di costruire un edificio, bisogna gettarne le fondamenta, le quali dovranno sorreggere tutta quanta la struttura, comprese le parti più alte; le fondamenta resteranno sempre, anche quando l’edificio sarà terminato. Con questa immagine, Guénon vuol significare che l’adesione ad un exoterismo tradizionale costituisce una condizione ineludibile per avere accesso all’esoterismo corrispondente e che il ricollegamento iniziatico, una volta ottenuto, non dispensa affatto l’iniziato dalla pratica exoterica. Perciò il cosiddetto “pensiero tradizionale” (che alcuni con un orribile neologismo d’origine anglosassone chiamano “perennialismo”) non utilizza gli elementi provenienti dalle diverse forme tradizionali al fine di costruire una propria sincretica dottrina, bensì per mettere in luce, attraverso le analogie sostanziali e significative riscontrabili fra gli elementi suddetti, la comune provenienza delle varie forme tradizionali da un’unica fonte, e quindi la loro essenziale unità.
Se gli studi di Guénon, Coomaraswamy, Schuon, Burckhardt, Vâlsan (ed altri che ci vorrà ricordare) sono ricchi di stimoli che inducono a riflettere sulle analogie tra le tradizioni viventi dell’Eurasia e perciò sulla loro sostanziale unità, manca quasi del tutto una comparazione tra quelle tradizioni ancora vive ed operanti e la religione romana antica, anche se pure su quest’ultima hanno fornito spunti interessanti (vedasi R. Guénon, Simboli della scienza sacra). Perché questa lacuna? Si tratta forse di un’omissione volontaria per non mettere in crisi un “sistema” (sempre facendo eco alle obiezioni dei detrattori)? Oppure questi autori non avevano un’adeguata conoscenza della religione romana?
 Benché gli autori da Lei menzionati abbiano fornito una messe abbondante di prove circa la famosa “unità trascendente delle religioni”, sono rare le occasioni in cui qualcuno di loro si è occupato della religione romana antica e della sua essenziale convergenza con altre tradizioni religiose presenti nel continente eurasiatico. È vero che circa la religione romana esistono preziose considerazioni di Guénon nei Simboli della Scienza sacra (ma anche nelle sue recensioni di alcuni studi di Arturo Reghini e di Károly Kerényi); è vero che temi attinenti all’antichità romana sono stati affrontati da qualche autore di formazione guénoniana (penso al Vasile Lovinescu della Colonna Traiana); nondimeno resta il fatto che nessuno di loro si è mai impegnato in uno studio specifico che inquadri nella tradizione universale la religione di Roma o anche solo un suo aspetto particolare. Ciò probabilmente si spiega col fatto che questi autori hanno preferito utilizzare i dati disponibili presso forme tradizionali ancora in vita, perché più sicuri e più facilmente verificabili.
Benché gli autori da Lei menzionati abbiano fornito una messe abbondante di prove circa la famosa “unità trascendente delle religioni”, sono rare le occasioni in cui qualcuno di loro si è occupato della religione romana antica e della sua essenziale convergenza con altre tradizioni religiose presenti nel continente eurasiatico. È vero che circa la religione romana esistono preziose considerazioni di Guénon nei Simboli della Scienza sacra (ma anche nelle sue recensioni di alcuni studi di Arturo Reghini e di Károly Kerényi); è vero che temi attinenti all’antichità romana sono stati affrontati da qualche autore di formazione guénoniana (penso al Vasile Lovinescu della Colonna Traiana); nondimeno resta il fatto che nessuno di loro si è mai impegnato in uno studio specifico che inquadri nella tradizione universale la religione di Roma o anche solo un suo aspetto particolare. Ciò probabilmente si spiega col fatto che questi autori hanno preferito utilizzare i dati disponibili presso forme tradizionali ancora in vita, perché più sicuri e più facilmente verificabili.
Passiamo all’individuazione dei punti di contatto tra la Religione romana e l’Islam, il quale, com’è noto, si autorappresenta come il compimento dell’intero ciclo di Rivelazioni che la presente umanità ha ricevuto dal Signore di tutti gli uomini, e pertanto come sintesi di tutte, nonché, adattata alla presente fase, come ritorno all’origine, a quella Tradizione Primordiale postulata da tutti i “tradizionalisti”. Neppure Evola o De Giorgio, che pure hanno indagato a fondo la Romanità, ci hanno illuminato al riguardo. Specialmente il secondo, che aveva una diretta conoscenza della tradizione islamica, avrebbe potuto lasciarci pagine su cui meditare… Può avere avuto un peso il fatto che la Religione romana, almeno apparentemente, non conterebbe più “adepti” e pertanto una comparazione tra quella tradizione, “morta”, e le altre, “vive”, sarebbe stata priva di significato?
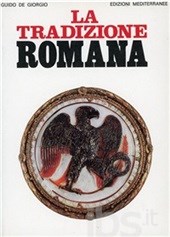 Per quanto riguarda Julius Evola, nel capitolo di Rivolta contro il mondo moderno dedicato a La grande e la piccola guerra santa (che troverà un seguito nella celebre conferenza sulla “dottrina aria di lotta e vittoria” e in una cospicua serie di articoli sulla “metafisica della guerra”) l’autore assegna una funzione paradigmatica alla dottrina islamica del duplice “sforzo” (al-gihâd al-akbar e al-gihâd al-asghar), presentandola come esemplare in rapporto alla concezione tradizionale dell’azione quale via di realizzazione spirituale. In questo contesto Evola indica la perfetta corrispondenza della mors triumphalis con l’ingresso in Paradiso promesso dal Corano a “coloro che vengono uccisi sulla via di Dio”. Quanto a De Giorgio, egli ritiene opportuno “esprimersi islamicamente e con un termine arabo che aderisce perfettamente al concetto” allorché indica in Roma la qibla dell’Europa; viene così stabilita un’implicita analogia tra Roma e Mecca, che però non trova sviluppo nell’opera di questo scrittore. Anche in questo caso, vale probabilmente la spiegazione già ipotizzata circa la preferenza data dai tradizionalisti allo studio delle tradizioni viventi.
Per quanto riguarda Julius Evola, nel capitolo di Rivolta contro il mondo moderno dedicato a La grande e la piccola guerra santa (che troverà un seguito nella celebre conferenza sulla “dottrina aria di lotta e vittoria” e in una cospicua serie di articoli sulla “metafisica della guerra”) l’autore assegna una funzione paradigmatica alla dottrina islamica del duplice “sforzo” (al-gihâd al-akbar e al-gihâd al-asghar), presentandola come esemplare in rapporto alla concezione tradizionale dell’azione quale via di realizzazione spirituale. In questo contesto Evola indica la perfetta corrispondenza della mors triumphalis con l’ingresso in Paradiso promesso dal Corano a “coloro che vengono uccisi sulla via di Dio”. Quanto a De Giorgio, egli ritiene opportuno “esprimersi islamicamente e con un termine arabo che aderisce perfettamente al concetto” allorché indica in Roma la qibla dell’Europa; viene così stabilita un’implicita analogia tra Roma e Mecca, che però non trova sviluppo nell’opera di questo scrittore. Anche in questo caso, vale probabilmente la spiegazione già ipotizzata circa la preferenza data dai tradizionalisti allo studio delle tradizioni viventi.
Studiosi come Eliade e Dumézil, pur non appartenendo al filone del “tradizionalismo”, ci hanno comunque fornito elementi importanti per comprendere il “sacro” anche da una prospettiva “tradizionalista”. Questo per dire che non è necessario mantenersi esclusivamente entro l’alveo del “tradizionalismo” per ricavare spunti di riflessione suscettibili di essere rielaborati per ricavarne una sostanziale continuità tra la Religione Romana e l’Islam. A quali autori possiamo fare riferimento, e a quali opere, per ricavare utili spunti di riflessione e perciò di raffronto?
 Due autori che hanno abbozzato qualche raffronto tra aspetti particolari dell’Islam e della religione romana sono lo spagnolo Antonio Medrano e il francese Yves Albert Dauge. Secondo Medrano (Islam ed Europa, Quaderni del Veltro, 1978) la dottrina islamica dello Stato e l’idea della “guerra santa” possono rappresentare preziosi punti di riferimento in un’azione di ricostruzione tradizionale dell’Europa, in quanto, egli sostiene, l’Islam riattualizza la nostra eredità più antica. In questa ottica, Medrano ritiene che con l’istituzione della khilâfa (la “luogotenenza”, la “reggenza” esercitata in nome e per conto di Dio) riemerga “dal fondo inaccessibile della metastoria” il principio dell’imperium e che l’idea del gihâd riproponga la possibilità di un’azione guerriera culminante nella mors triumphalis. Quanto a Yves Albert Dauge, il suo “essai d’ésotérisme comparé” (Virgile. Maître de Sagesse, Arché 1984) offre diversi spunti per mettere a fuoco la parziale affinità esistente fra tradizione romana e tradizione islamica. Ad esempio, dal confronto di un hadîth con un passo di Cicerone (De haruspicum responso 19) ed un verso di Virgilio (Aen. XII, 839) Dauge deduce che è comune alla romanità ed all’Islam il concetto di una “razza” (nel senso evoliano di “razza dello spirito”) fondata sul valore della pietas (at-taqwah secondo il lessico coranico) e che questa fondamentale virtù costituisce, in entrambe le tradizioni, il criterio atto a stabilire la superiorità di una comunità rispetto alle altre.
Due autori che hanno abbozzato qualche raffronto tra aspetti particolari dell’Islam e della religione romana sono lo spagnolo Antonio Medrano e il francese Yves Albert Dauge. Secondo Medrano (Islam ed Europa, Quaderni del Veltro, 1978) la dottrina islamica dello Stato e l’idea della “guerra santa” possono rappresentare preziosi punti di riferimento in un’azione di ricostruzione tradizionale dell’Europa, in quanto, egli sostiene, l’Islam riattualizza la nostra eredità più antica. In questa ottica, Medrano ritiene che con l’istituzione della khilâfa (la “luogotenenza”, la “reggenza” esercitata in nome e per conto di Dio) riemerga “dal fondo inaccessibile della metastoria” il principio dell’imperium e che l’idea del gihâd riproponga la possibilità di un’azione guerriera culminante nella mors triumphalis. Quanto a Yves Albert Dauge, il suo “essai d’ésotérisme comparé” (Virgile. Maître de Sagesse, Arché 1984) offre diversi spunti per mettere a fuoco la parziale affinità esistente fra tradizione romana e tradizione islamica. Ad esempio, dal confronto di un hadîth con un passo di Cicerone (De haruspicum responso 19) ed un verso di Virgilio (Aen. XII, 839) Dauge deduce che è comune alla romanità ed all’Islam il concetto di una “razza” (nel senso evoliano di “razza dello spirito”) fondata sul valore della pietas (at-taqwah secondo il lessico coranico) e che questa fondamentale virtù costituisce, in entrambe le tradizioni, il criterio atto a stabilire la superiorità di una comunità rispetto alle altre.
Alla luce delle Sue pluridecennali e multidisciplinari ricerche, ma anche della Sua adesione alla Tradizione islamica, quali sono le analogie che ha ravvisato tra la concezione del divino nella Religione Romana e quella dell’Islam ortodosso?
 Il formale “politeismo” della religione romana, con la sua moltitudine di “persone” divine, ci rinvia a quella molteplicità di aspetti e di qualità della Divinità che l’Islam rappresenta invece mediante i “nomi bellissimi” di Allah (al-asmâ’ al-husnà). Compreso ciò, si vedrà che alla figura di Giove quale “rex deorum hominumque” corrispondono i nomi divini al-Malik e Mâlik al-mulk; a Giano, dio degl’inizi, corrisponderà il nome al-Mubdi‘; ad Apollo, in virtù dell’interpretazione etimologica suggerita nel De E apud Delphos da Plutarco, al-Ahad. Altre divinità trovano totale o parziale riscontro in figure di angeli o di profeti: è il caso di Mercurio, che in quanto messaggero svolge una funzione simile a quella di Gabriele, mentre per via del suo nome greco, Hermes, è stato identificato col profeta Idris, patrono delle scienze ermetiche. Anche il puer dell’enigmatica IV ecloga virgiliana, incaricato dal Cielo di instaurare una nuova età aurea nel mondo, si ripresenta nell’escatologia islamica: il Mahdi atteso al termine del presente ciclo di umanità, infatti, secondo la versione sciita può manifestarsi al fedele in preghiera per lo più nelle sembianze di un fanciullo.
Il formale “politeismo” della religione romana, con la sua moltitudine di “persone” divine, ci rinvia a quella molteplicità di aspetti e di qualità della Divinità che l’Islam rappresenta invece mediante i “nomi bellissimi” di Allah (al-asmâ’ al-husnà). Compreso ciò, si vedrà che alla figura di Giove quale “rex deorum hominumque” corrispondono i nomi divini al-Malik e Mâlik al-mulk; a Giano, dio degl’inizi, corrisponderà il nome al-Mubdi‘; ad Apollo, in virtù dell’interpretazione etimologica suggerita nel De E apud Delphos da Plutarco, al-Ahad. Altre divinità trovano totale o parziale riscontro in figure di angeli o di profeti: è il caso di Mercurio, che in quanto messaggero svolge una funzione simile a quella di Gabriele, mentre per via del suo nome greco, Hermes, è stato identificato col profeta Idris, patrono delle scienze ermetiche. Anche il puer dell’enigmatica IV ecloga virgiliana, incaricato dal Cielo di instaurare una nuova età aurea nel mondo, si ripresenta nell’escatologia islamica: il Mahdi atteso al termine del presente ciclo di umanità, infatti, secondo la versione sciita può manifestarsi al fedele in preghiera per lo più nelle sembianze di un fanciullo.
Vi sono, dal punto di vista “essenziale”, anche degli elementi significativi nel culto di entrambe le tradizioni?
 È interessante notare che i nomi Muhammad ed Aeneas, portati dai personaggi centrali delle due tradizioni, possiedono il medesimo significato: “lodevole, degno di lode”. A questa omonimia essenziale esistente tra il Messaggero di Allah e il figlio della dea Venere si aggiungono altre interessanti analogie, che evidenziano due vite quasi parallele: entrambi sono costretti a fuggire dalla città natale, entrambi sono protagonisti di vicende belliche, entrambi sono vittoriosi, entrambi visitano i mondi ultraterreni ecc. Inoltre, i due eroi fondatori epifanizzano quel principio che René Guénon, adattando un termine desunto dalla terminologia islamica (al-insân al-kâmil, cioè “l’uomo perfetto”), chiama “Uomo Universale”. Fra gli altri elementi comuni alle due forme tradizionali mi limito a citarne un paio, che, benché meno rilevanti, rivestono tuttavia un importante significato. Il primo è l’aniconismo, che nella Roma dei primordi era dovuto (secondo quanto scrive Dumézil in Les dieux des Indo-Européens) al “sentimento di ineguaglianza che avrebbe separato la rappresentazione e l’essere rappresentato” e che nella civiltà islamica procede da una visione analoga: “e non c’è uno uguale a Lui” (“wa lam yakun lahu kufuwan ahad“, Cor. CXII, 4). Il secondo elemento è un gesto rituale che significa la totale dedizione del fedele alla Divinità: la prosternazione. Eseguita regolarmente nel corso della salât, questa postura trova puntuale riscontro nell’atto di adorazione attribuito da Ovidio a Deucalione e Pirra: “Come giunsero ai gradini del tempio, si prosternarono entrambi – proni al suolo” (“Ut templi tetigere gradus, procumbit uterque – pronus humi“, Met. I, 375-376).
È interessante notare che i nomi Muhammad ed Aeneas, portati dai personaggi centrali delle due tradizioni, possiedono il medesimo significato: “lodevole, degno di lode”. A questa omonimia essenziale esistente tra il Messaggero di Allah e il figlio della dea Venere si aggiungono altre interessanti analogie, che evidenziano due vite quasi parallele: entrambi sono costretti a fuggire dalla città natale, entrambi sono protagonisti di vicende belliche, entrambi sono vittoriosi, entrambi visitano i mondi ultraterreni ecc. Inoltre, i due eroi fondatori epifanizzano quel principio che René Guénon, adattando un termine desunto dalla terminologia islamica (al-insân al-kâmil, cioè “l’uomo perfetto”), chiama “Uomo Universale”. Fra gli altri elementi comuni alle due forme tradizionali mi limito a citarne un paio, che, benché meno rilevanti, rivestono tuttavia un importante significato. Il primo è l’aniconismo, che nella Roma dei primordi era dovuto (secondo quanto scrive Dumézil in Les dieux des Indo-Européens) al “sentimento di ineguaglianza che avrebbe separato la rappresentazione e l’essere rappresentato” e che nella civiltà islamica procede da una visione analoga: “e non c’è uno uguale a Lui” (“wa lam yakun lahu kufuwan ahad“, Cor. CXII, 4). Il secondo elemento è un gesto rituale che significa la totale dedizione del fedele alla Divinità: la prosternazione. Eseguita regolarmente nel corso della salât, questa postura trova puntuale riscontro nell’atto di adorazione attribuito da Ovidio a Deucalione e Pirra: “Come giunsero ai gradini del tempio, si prosternarono entrambi – proni al suolo” (“Ut templi tetigere gradus, procumbit uterque – pronus humi“, Met. I, 375-376).
E per quanto riguarda la centralità della Legge a Roma e nell’Islam, che cosa possiamo dire?
 Nella civiltà romana il latino fas (da una radice indoeuropea che significa “parlare”) indica la Parola divina, che la legge umana deve recepire. Perciò il diritto, riflesso della volontà divina nella coscienza degli uomini, non può essere altro che diritto divino. La concezione islamica è esattamente identica: il diritto (al-fiqh) costituisce l’aspetto pratico della dottrina contenuta nel Corano e nella Sunna del Messaggero di Dio, cosicché risulta piuttosto arduo stabilire una distinzione tra ciò che è “giuridico” e ciò che è “religioso”. Non è un caso che i testi di giurisprudenza islamica (quelli in cui troviamo le norme della famigerata sharî‘a) comincino coi capitoli relativi alle abluzioni, alle preghiere canoniche, al digiuno, al pellegrinaggio ed alle altre pratiche rituali.
Nella civiltà romana il latino fas (da una radice indoeuropea che significa “parlare”) indica la Parola divina, che la legge umana deve recepire. Perciò il diritto, riflesso della volontà divina nella coscienza degli uomini, non può essere altro che diritto divino. La concezione islamica è esattamente identica: il diritto (al-fiqh) costituisce l’aspetto pratico della dottrina contenuta nel Corano e nella Sunna del Messaggero di Dio, cosicché risulta piuttosto arduo stabilire una distinzione tra ciò che è “giuridico” e ciò che è “religioso”. Non è un caso che i testi di giurisprudenza islamica (quelli in cui troviamo le norme della famigerata sharî‘a) comincino coi capitoli relativi alle abluzioni, alle preghiere canoniche, al digiuno, al pellegrinaggio ed alle altre pratiche rituali.
Ci può chiarire eventuali analogie tra la funzione dell’Imperatore (Pontefice Massimo), da un lato, e del Califfo, dall’altra?
Il pontifex maximus, che presiedeva un’accolta di esperti del diritto sacro incaricata di conservare le tradizioni religiose, era la suprema autorità della religione romana. Per quattro secoli (dal 12 a.C., anno in cui Augusto venne insignito di questo grado, fino al 375 d.C., quando Graziano lo depose) la carica di pontefice massimo fu rivestita dall’Imperatore, il quale riunì nella propria persona gli attributi supremi del sacerdozio e dello Stato. Ciò confermò ulteriormente quell’unità di autorità religiosa e di potere politico che era caratteristica dell’antica Roma fin dai suoi primordi, ad onta degl’ignoranti che pretenderebbero di attribuire alla civiltà romana un grottesco carattere di laicità. Risulta perciò evidente l’intima analogia della figura dell’Imperatore romano con quella del Califfo islamico, vicario (khalîfat) del Profeta nella guida della comunità musulmana. D’altronde proprio Lei ha fatto notare, in un saggio apparso una decina d’anni fa su “Eurasia”, la compresenza del ruolo “regale” (imâra) e di quello “sacerdotale” (imâma) nella funzione del Califfo, ricordando che questi, in quanto garante dell’applicazione della legge divina e sottoposto ad essa, dirige il rito dell’adorazione comunitaria e guida il Pellegrinaggio alla “Casa di Dio”, ma è anche il comandante in capo delle spedizioni militari.
A Suo parere, perché a livello accademico – e conseguentemente nella vulgata più o meno “colta” – persiste l’uso di classificare alcune tradizioni come “monoteiste” ed altre come “politeiste”?
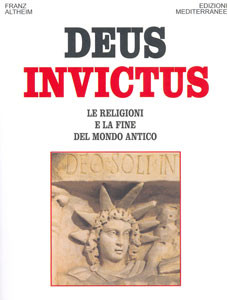 Che una forma tradizionale autentica sia propriamente politeistica, ossia che ammetta una pluralità di princìpi considerati del tutto indipendenti, è semplicemente impossibile, poiché ogni vera tradizione afferma innanzitutto l’unità del Principio Supremo, dal quale tutto deriva e dal quale tutto dipende. Laddove esiste politeismo, vi è incomprensione della realtà riguardante gli attributi divini, che vengono erroneamente considerati come entità a sé stanti. Invece il pensiero filosofico antico, dopo aver esordito nella ricerca di un’arché una ed unica, culmina nell’individuazione di una causa causarum, chiamata Sommo Bene da Platone, Motore Immobile da Aristotele, Lógos dagli Stoici. Per quanto concerne il mondo romano, nel Somnium Scipionis Cicerone definisce questa Causa prima come “il Dio sovrano, che regge tutto il mondo” (Princeps deus, qui omnem mundum regit). Più tardi, nel quadro di quel “monoteismo solare” che con Aureliano diventa religione ufficiale dell’Impero romano, la figura di Apollo viene identificata con Helios, il cui nome latino, Sol, riecheggia significativamente l’aggettivo solus, “unico”. A parere di Franz Altheim, questo “monoteismo solare” non fu privo di relazione col monoteismo islamico. “Il messaggio di Muhammad – leggiamo in Der unbesiegte Gott – era incentrato sul concetto di unità ed escludeva che la divinità potesse avere un ‘compagno’, ricalcando così le orme dei precursori e conterranei neoplatonici e monofisiti. L’impeto religioso del Profeta riuscì quindi a far emergere con accresciuta forza ciò che altri prima di lui avevano sentito e a cui avevano anelato”.
Che una forma tradizionale autentica sia propriamente politeistica, ossia che ammetta una pluralità di princìpi considerati del tutto indipendenti, è semplicemente impossibile, poiché ogni vera tradizione afferma innanzitutto l’unità del Principio Supremo, dal quale tutto deriva e dal quale tutto dipende. Laddove esiste politeismo, vi è incomprensione della realtà riguardante gli attributi divini, che vengono erroneamente considerati come entità a sé stanti. Invece il pensiero filosofico antico, dopo aver esordito nella ricerca di un’arché una ed unica, culmina nell’individuazione di una causa causarum, chiamata Sommo Bene da Platone, Motore Immobile da Aristotele, Lógos dagli Stoici. Per quanto concerne il mondo romano, nel Somnium Scipionis Cicerone definisce questa Causa prima come “il Dio sovrano, che regge tutto il mondo” (Princeps deus, qui omnem mundum regit). Più tardi, nel quadro di quel “monoteismo solare” che con Aureliano diventa religione ufficiale dell’Impero romano, la figura di Apollo viene identificata con Helios, il cui nome latino, Sol, riecheggia significativamente l’aggettivo solus, “unico”. A parere di Franz Altheim, questo “monoteismo solare” non fu privo di relazione col monoteismo islamico. “Il messaggio di Muhammad – leggiamo in Der unbesiegte Gott – era incentrato sul concetto di unità ed escludeva che la divinità potesse avere un ‘compagno’, ricalcando così le orme dei precursori e conterranei neoplatonici e monofisiti. L’impeto religioso del Profeta riuscì quindi a far emergere con accresciuta forza ciò che altri prima di lui avevano sentito e a cui avevano anelato”.
È completamente fondata l’idea che lo spirito di Roma sia stato compiutamente rivivificato dal Cattolicesimo? Quest’ultima domanda non ha alcun intento polemico contro il Cattolicesimo, sia chiaro, ma vorrei capire se proprio l’insistenza sulla dicotomia monoteismo/politeismo sia servita anche ad inserire l’Islam nel filone per così dire “abramitico”, che originerebbe pertanto da una radice cosiddetta “ebraica”, col risultato che per tal via la Religione Romana e l’Islam finirebbero per non avere più punti di contatto.
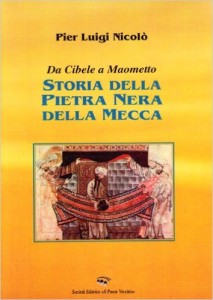 Nella prospettiva greco-romana ed in quella islamica la figura di Abramo si presenta nella medesima luce. Flavio Claudio Giuliano, imperatore e teologo, scrive che Abramo, Isacco e Giacobbe erano “caldei, quindi di stirpe sacra e versata nella teurgia (…) e venerarono un Dio che fu sempre benevolo verso di [lui] e verso coloro che lo venerano come lo venerava Abramo” (Contra Galilaeos 354B). La posizione del Corano è coincidente: “Abramo non era né giudeo né cristiano, ma era puro monoteista sottomesso a Dio e non era degli associatori” (“mâ kâna Ibrâhîmu yahûdiyyan wa lâ nasrâniyyan wa lâkin kâna hanîfan musliman wa mâ kâna min al-mushrikîn“, Cor. III, 67). Il luogo comune della “famiglia abramica” rivela qui tutta la sua debolezza. In ogni caso, inserire l’Islam in questa “famiglia” equivale a limitare gravemente l’originalità, l’autonomia e l’universalità dell’Islam stesso, rendendolo subalterno rispetto ad altre forme religiose e restringendolo entro ristretti limiti razziali e regionali.
Nella prospettiva greco-romana ed in quella islamica la figura di Abramo si presenta nella medesima luce. Flavio Claudio Giuliano, imperatore e teologo, scrive che Abramo, Isacco e Giacobbe erano “caldei, quindi di stirpe sacra e versata nella teurgia (…) e venerarono un Dio che fu sempre benevolo verso di [lui] e verso coloro che lo venerano come lo venerava Abramo” (Contra Galilaeos 354B). La posizione del Corano è coincidente: “Abramo non era né giudeo né cristiano, ma era puro monoteista sottomesso a Dio e non era degli associatori” (“mâ kâna Ibrâhîmu yahûdiyyan wa lâ nasrâniyyan wa lâkin kâna hanîfan musliman wa mâ kâna min al-mushrikîn“, Cor. III, 67). Il luogo comune della “famiglia abramica” rivela qui tutta la sua debolezza. In ogni caso, inserire l’Islam in questa “famiglia” equivale a limitare gravemente l’originalità, l’autonomia e l’universalità dell’Islam stesso, rendendolo subalterno rispetto ad altre forme religiose e restringendolo entro ristretti limiti razziali e regionali.
(intervista a cura di Enrico Galoppini)





