Cavalieri d'America: i "valori dell'Occidente"
di Franco Cardini - 01/06/2022
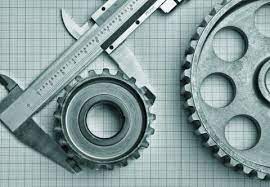
Fonte: Franco Cardini
Forse non tutti lo sanno, ma gli Stati Uniti sono uno dei paesi al mondo nei quali la letteratura cavalleresca medievale e i suoi succedanei di ogni tipo hanno il massimo successo. Dagli studi accademici alle pubblicazioni scientifiche, ma anche dalla letteratura popolare ai “giochi di ruolo” la passione per le gesta dei paladini di Artù dilaga: del resto, la Disney Co. ne è uno dei maggiori veicoli a livello mondiale. E il fenomeno sta tracimando da oltre due secoli in tutte le possibili direzioni: dall’architettura neoromanica e neogotica ai “ristoranti medievali” dove si fanno anche i tornei, dal cinema alla TV, dal “teutonismo” come fenomeno antropologico-giuridico e antropologico-militare (l’Accademia di West Point) alle infinite derivazioni del tolkienismo ai continui revivals del mito del Santo Graal.
Argomenti di questo genere sono ormai da tempo anche oggetto di seri studi specialistici. Il fenomeno del “medievalismo” è accuratamente indagato da ottimi specialisti: basti pensare, in Italia, ai lavori di Maria Giuseppina Muzzarelli, di Francesca Roversi Monaco, di Tommaso di Carpegna Falconieri e di moltissimi altri.
Questa passione collettiva è radicata in aspetti non trascurabili della stessa “mentalità collettiva” (e ci rendiamo conto della problematicità di questa espressione). Nello “spirito americano”, nel “manifesto destino” degli Stati Uniti, la componente cavalleresca ha un rilievo del tutto speciale. Pensiamo al mito del Lontano Occidente, ricalcato su quello antico e diffuso dell’Antico Oriente. E “Lontano Occidente”, com’è ben noto, si traduce in inglese con l’espressione Far West. Il “mito della Frontiera” rigurgita di elementi cavallereschi, sia pure semplicizzati e stereotipati: l’Avventura anzitutto, dimensione com’è noto basilare della Weltanschauung arturiana; la ricerca della ricchezza e dell’amore, appiattimento banale ma fascinoso dei fini ultimi dell’Avventura stessa; la difesa dei deboli e degli oppressi, anche se spesso non correttamente identificati; il parallelo odio contro tutte le personificazioni del Male, a cominciare dai “Pellerossa”. La destra ha elaborato e sviluppato al riguardo una decisa categoria etico-antropologica, incarnata dai cosiddetti Libertarians che anni fa riempivano le fila dei neoconservative impegnati contro l’Islam e che sembrano aver trovato oggi una loro nuova Isola Felice nella lotta contro tutto quello che sa di russo.
Nella “cultura libertarian” (da non confondersi con liberal: fra i due concetti esiste una fitta rete di elementi di affinità e di opposizione che li rende complementari ed opposti al tempo stesso) il mito della Frontiera ha un ruolo fondamentale: la libertà dell’eroe western, che al di sopra di sé ha solo il cielo stellato e Dio e dentro di sé una legge morale intima infallibile e indiscutibile, è autoreferenzialmente riconosciuta da chi vi s’identifica come una libertà cavalleresca. Col risultato paradossale che l’individualismo assoluto, questo caratteristico fondamento primario della Modernità occidentale, viene identificato con la figura archetipica del cavaliere medievale che è invece l’uomo della dedizione a Dio e al prossimo, miles pacificus nella definizione agostiniana passata ai rituali di addobbamento.
D’altronde un uomo libero non è tale se non è armato, se non è un guerriero. Si tratta di un principio di base del diritto germanico, ben riconoscibile in tutte le leges barbariche la raccolta delle quali occupa vari volumi dei Monumenta Germaniae Historica, i leggendari M.G.H. D’altronde un cavaliere non è solo un guerriero: è molto di più. Il guerriero è libertà e ferocia; il cavaliere è spirito di servizio, disposizione al martirio.
Ed ecco uno degli elementi di base che oggi osta al riconoscimento della “cultura europea” come “cultura occidentale”, anzi del carattere sinonimico delle due espressioni, che ha viceversa conosciuto un’allarmante diffusione mediatica. La giovane America (ormai non più giovanissima) dei self-made men, degli illimitati diritti individuali, del “diritto alla ricerca della felicità” di ciascuno conseguita – forse – da pochissimi a scapito di troppi, quella che ha fondato la “prima democrazia del mondo” la quale coincide con il paese della più profonda disuguaglianza e della più tragica ingiustizia sociale è divenuta il modello trainante di un mondo strettamente connesso a quello dei paesi del Commonwealth e della sua stessa antica Madrepatria, l’Inghilterra, dalla quale provenivano i Pilgrim Fathers calvinisti per i quali la ricchezza era il segno del favore divino e la povertà quello della Sua maledizione: quelli che bruciavano le streghe e consideravano i native Americans dei barbari preda di Satana. Su queste premesse si conquistò la frontiera sempre più spinta vero ovest: sulle canne delle Colt ch’erano le spade dei Nuovi Cavalieri e sulle rotaie dei treni coast to coast.
La nostra vecchia Europa è stata profondamente invasa, negli ultimi tre quarti di secolo, da quest’Occidente iperindividualista e predatore: ma, attraverso la sua antica storia di guerre e di sofferenze, ha saputo costruire un’altra Weltanschauung. Anch’essa si è resa responsabile di aver seminato conversione al cristianesimo e democrazia parlamentare raccogliendo però, nel mondo, i ricchi frutti dello sfruttamento coloniale e delle ingiustizie del capitalismo: mantenendo però nel contempo fede anche a una dimensione di progressiva giustizia sociale e di costante solidarismo. Ecco perché nella felice America chi non ha una carta di credito in ordine non ha accesso agli ospedali mentre l’umiliata e decaduta Europa, pur equivocamente rappresentata da un’Unione Europea ormai fallimentare, continua a far di tutto per tenere in piedi uno straccio di quel welfare state alla base del quale c’è anche il contributo di pensiero di studiosi e di statisti americani. Noialtri europei abbiamo assicurazioni obbligatorie ma ci è difficile poter tenere legittimamente in casa un’arma; gli americani possono comprarsi interi arsenali da guerra, ma se si ammalano e non hanno abbastanza soldi in banca sono fottuti. Ecco la differenza, punto d’arrivo di altre più profonde e significative differenze. Ed è il caso di dirlo: Vive la difference!
Ecco perché, parafrasando il vecchio Kipling, West is West, Europe is Europe. L’America è la patria d’infiniti diritti riconosciuti a tutti ma conseguiti e goduti da pochissimi; l’Europa è la patria di popoli che non hanno ancora del tutto dimenticato che a qualunque diritto corrisponde un dovere, e che soprattutto sul piano sociale i doveri vengono prima dei diritti. E le radici di Europa e di Occidente possono ben essere anche le stesse: ma l’albero si riconosce dai suoi frutti. Ecco perché, da oltre due secoli almeno – ma a causa di un processo avviato circa mezzo millennio fa, con il decollo della globalizzazione –, noialtri europei non possiamo più dirci occidentali.
Qualcuno ha detto e scritto, su organi mediatici della “destra”, che io sono “antiatlantista” e “antiamericano” e che all’“Euramerica” preferisco l’“Eurasia”. Sia chiaro che non sono un eurasiatista, ammesso che un eurasiatismo come valore politico esista. Certo, all’Euramerica e al suo cane da guardia, la NATO, preferisco l’Eurasia: ma proprio in quanto ostinatamente credo alla possibilità che l’Europa ritrovi le sue autentiche radici e che sappia costruire in futuro una solida compagine indipendente dai blocchi che si vanno configurando e fra loro mediatrice in funzione di una politica di pace. Nel loro sistema di costruzione dell’America come grande potenza nel contesto dei blocchi contrapposti, gli USA non ci lasciano sufficiente autonomia: né, pertanto, ci lasciano scelta. Se non vogliamo restar subalterni (e uso un eufemismo) bisogna stare dall’altra parte nella prospettiva di rimanere autonomi e sovrani: sarà poi loro compito rimediare agli errori fatti e recuperare la nostra fiducia, ma per questo momento non c’è spazio. In questo momento sostengo pertanto la necessità che l’Occidente à tête americaine non consegua il disegno della Casa Bianca e/o del Pentagono di stravincere sul mondo eurasiatico reimponendo un’egemonia ch’è storicamente tramontata in modo irreversibile e attuando le strategie e le tattiche del totalitarismo liberista, il più subdolo ma non il meno infame dei totalitarismi (e ce lo sa dimostrando nell’Europa d’oggi: tentando di fare strame di qualunque libertà di pensiero degradandone sistematicamente le espressioni a forme di fake news, facendo il deserto su qualunque differenza di giudizio e chiamando tale deserto “democrazia”). Certo che, al limite, una tirannia lontana è un male minore rispetto a una tirannia vicina e incombente. Ma il fatto che il totalitarismo occidentale sia quello del “pensiero unico” e della negazione di troppi diritti sostanziali dei più (a cominciare non dalla ricchezza, bensì dalla dignità civile e sociale) nel nome del diritto di sfruttamento da parte delle lobbies conferisce alla “tirannia vicina” che ci minaccia un carattere particolarmente odioso: e il fatto che essa, almeno per il momento, possa permettersi il lusso di forme di “libertà” nella sostanza irrilevanti se non addirittura socialmente illusorie e pericolose anche perché utilizzate come anestetico morale di massa la rende ancora più infame.
Federico Rampini, ch’è un giornalista di rara intelligenza ed efficacia, ha di recente pubblicato un “best seller annunziato” – 70.000 copie vendute ancor prima dell’uscita, annunzia l’Editore: potenza dei media, specie se Zio Sam veglia sulla buona riuscita di qualcosa… – dal titolo Suicidio occidentale (Mondadori) il cui sottotitolo, illuminante, recita: “Perché è sbagliato processare la nostra storia e cancellare i nostri valori”. Si tratta di un libro da leggere con la massima attenzione, cercando nelle sue pagine l’esposizione (o la non-spiegazione) dei tre grandi temi che il suo titolo propone usando l’aggettivo “occidentale” e le espressioni “nostra storia” e “nostri valori”.
Occidente: che cosa significa, quali sono i suoi confini cronologici, geografici, antropologici, culturali? È un valore immobile, metastorico, o dinamico, soggetto quindi ai mutamenti? E quanto vi ha inciso, nella seconda ipotesi, la Modernità quale trionfo dell’individualismo e del primato di economia-finanza e di tecnologia su altri valori, a cominciare da quelli religiosi ed etici?
Nostra storia: nostra di chi? Valutata alla luce di quali parametri, di quali giudizi? E poi, chi siamo noi? Quali sono i confini e i contorni etnici, culturali, etici, geostorici del nostro “essere noi stessi”? Da che momento in poi possiamo considerarci “noi” trascurando o superando dinamiche e addirittura soluzioni di continuità? Siamo tutti gli stessi, tutti concordi, tutti uguali?
Nostri valori: nostri di chi? Quali sono? Fino a che punto sono universalmente condivisi? Sono davvero perfettamente condivisibili? Sono perfetti o suscettibili di perfettibilità? Li enunziamo con chiarezza, li pratichiamo con coerenza e fedeltà? O sono più spesso alibi per quella che Nietzsche definiva “Volontà di Potenza” o, per altri versi, papa Francesco definisce “cultura dell’indifferenza” e “dello scarto”? E Rampini, questi valori, li riconosce e li accetta in blocco oppure opera delle selezioni, delle esclusioni?
Muniti di questo companion per affrontare una lettura che oggi si presenta come ineludibile, cerchiamo di renderci conto di quali siano questi valori in ordine a una questione civile ed etica fondamentale: la violenza, che da noi in Europa sia pure in modo e in grado diverso abbiamo deciso di negare ai singoli cittadini espropriandone il diritto – nel nome del bene comune – per trasferirlo al monopolio della società costituita in quanto tale, quindi dello stato.
“Da noi” in Europa, da Lisbona e Mosca e da Oslo ad Atene con molte diversità, articolazioni e sfumature, la “violenza privata” è stata messa con chiarezza da circa due secoli e mezzo al bando in tutte le sue forme (comprese la “vendetta” e la “difesa privata” entro certi limiti): nel nome dello stato di diritto, che garantisce a tutti la libertà ma perciò stesso la limita per mezzo di leggi miranti alla sicurezza pubblica e alla garanzia contro la possibilità che un eccesso di libertà esercitato da qualcuno (in forza per esempio della sua superiorità civile o economica) si risolva con un danno di libertà altrui. Da noi, salvo precise eccezioni quali forze armate o forze dell’ordine, il disarmo è regola generale cui possono essere esentati solo pochi cittadini in possesso di requisiti speciali.
“Altrove” nell’Occidente, non è così: questo, che potrebbe essere valutato – e senza dubbio con ragione – un grave limite alla libertà individuale, viene respinto. Le armi private sono considerate beni lecitamente commerciabili. I risultati di tutto ciò, associati con evidenza ad altri fattori, hanno determinato autentiche tragedie: ultima in ordine di tempo quella di Uvalde in Texas della quale in questo numero dei MC parla David Nieri. Subito dopo la tragedia gli affiliati della NRA (National Rifle Association), ricchissimo e potentissimo sodalizio che contribuisce costruire l’imponente fatturato delle industria che producono armi e che è soggetto privilegiato nella stessa scelta del presidente degli USA con il suo massiccio intervento finanziario e mediatico in sede elettorale, si sono riuniti a Houston, dove in un applaudito intervento di venerdì 27 scorso Donald Trump ha difeso anzi esaltato tanto i costruttori quanto i possessori di armi, entrambi “paladini della libertà”. Al pari della spada al fianco degli aristocratici d’ancien régime, l’arme sarebbe per molti cittadini americani – solo conservative?… – simbolo di libertà di chi la porta e garanzia di sicurezza per la società civile tutta, dal momento che tale è lo spirito secondo il quale la costituzione degli USA consente ai cittadini di armarsi privatamente.
Ma la realtà è ben diversa da queste rosee intenzioni. L’articolo di Nieri lo documenta con puntualità impressionante (Minima Cardiniana 380/4 | I valori dell’Occidente (francocardini.it)).
Si delinea qui un confine preciso tra la società civile della nostra Europa e quella del “nostro” Occidente, che tale per fortuna non è o non è ancora del tutto. Noi europei preponiamo la libertà e la sicurezza comunitarie alla libertà e alla possibilità d’arbitrio dei singoli. La nostra libertà è concettualmente infinita, ma strutturalmente e fenomenologicamente si arresta là dove comincia la libertà altrui.
Allo stesso modo ci comportiamo in modo differente per quanto concerne altre forme di libertà: sia quella “di”, sia quelle “da”. Nella nostra vecchia Europa siamo sensibili da molto tempo nei confronti della libertà di parola, di stampa, di pensiero, di associazione: e ciascuna di queste libertà è definita nei suoi limiti in quanto non deve nuocere alla libertà di nessuno dei nostri concittadini. Ma i risultati conseguiti fino ad oggi dalla “libertà di” sono comunque sempre soggetti a minacce (nelle ultime settimane, troppi sono stati minacciati da attentati alla loro libertà d’opinione da parte di censori che ai sensi della legge hanno loro impedito di diffondere notizie ch’essi giudicavano fake news); mentre a nostro avviso è ancora troppo carente – a livello europeo e, a maggior ragione, in tutto il mondo – la lotta contro le “libertà da”: dalla fame, dalla miseria, dalla malattia, dalla paura. Una corretta società civile deve lottare per il conseguimento della liberazione da questi mali; così come deve difendere il suo passato, ma ha pieno diritto di denunziarne quegli aspetti che hanno condotto, oggi, al pubblico instaurarsi di un regime solidamente fondato sulla giustizia sociale. Il ricorrere allo “strumento dell’oblio”, cioè per esempio alla cancel culture, non è né civicamente, né culturalmente, né moralmente corretto: ma la condanna storica di modelli che hanno condotto al manifestarsi o all’instaurarsi di sistemi politici fondati sull’ingiustizia e sull’ingiusto privilegio, questo sì. Non si giustificano le violenze e i soprusi commessi nel nome della conversione dei popoli alla fede cristiana o di quella che grottescamente venne a suo tempo definita “esportazione della democrazia”; non si nega il diritto alla libertà, al rispetto delle tradizioni, all’autodeterminazione, nel nome di quelli che a nostro avviso sono soluzioni migliori e “più civili”. Anche perché di solito non lo sono. L’aggressione del 2001 all’Afghanistan controllato dai fondamentalisti di al-Qaeda ha condotto a una “esportazione della democrazia” che ha finito con una prospettiva di occupazione straniera e di un progressivo deterioramento che ha sfociato un ventennio più tardi all’instaurazione di un regime fondamentalista ancora peggiore di quello sradicato.


