Eschimesi: il messaggio di un popolo schiavizzato
di Michel Onfray - 15/09/2016
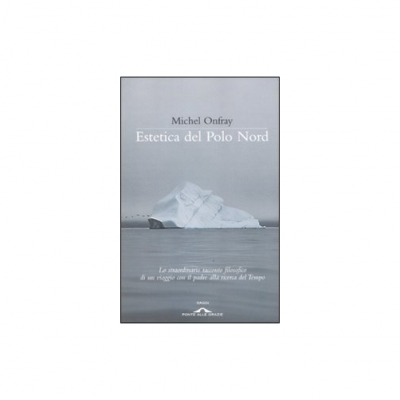
Fonte: letterainternazionale
Tutto ha inizio in un campo di Normandia, una trentina d’anni fa: giornata d’autunno, sole giallo e ancora caldo, allodole a profusione che salgono in cielo, cantano, gridano a squarciagola e poi ricadono come pietre, un padre e suo figlio che piantano patate. Non ho ancora dieci anni, mio padre è agricoltore. A casa, la povertà fabbrica giorni difficili, le patate assicurano la permanenza di una cucina che mia madre s’ingegna con successo a variare. Nel cielo, quel giorno, passa un aereo, seguito da una scia bianca.
Sogno di un bambino, impossibile e improbabile: domando a mio padre dove andrebbe se gli venisse offerto un viaggio in aereo… Risposta: “Al Polo Nord”. Mio padre lavorava a quel tempo come un forsennato, nel silenzio e nell’abnegazione, accettando il suo destino senza brontolare, subendo la povertà come una fatalità contro cui non ci si ribella. Non ho mai visto uno stoico più convinto in quegli anni taciturni, austeri. Niente vacanze, mai, le ferie gli servivano ad andare a lavorare altrove: le barbabietole, per esempio, che tutta la famiglia raccoglieva accanto ai portoghesi venuti come stagionali; niente passeggiate, niente ristoranti, né cinema, né teatro; niente libri, niente ospiti. La mancanza di denaro condanna alla solitudine, all’isolamento e impedisce di godere del mondo intero.
Che fulmine a ciel sereno, quel desiderio manifestato da mio padre! Non gli ho mai sentito confessarne altri. Ma ne aveva, lui che sembrava aver messo una croce sopra alle sue fantasie, sapendo che è meglio, per non essere infelici, dimenticarle piuttosto che coltivarle? Desiderio di Polo Nord, voglia di neve, di freddo, di gelo, geografia di banchisa, austerità e inospitalità: non capivo la ragione… Mio padre nemmeno, d’altronde, che vedeva nell’eccesso di domande da parte mia uno dei tratti del mio carattere: “stai zitto, parli sempre, lavora, piuttosto”.
Anni dopo, sempre attivo nella congiura contro i silenzi, sempre loquace, ritrovai mio padre all’ospedale: gli avevano appena messo un doppio bypass coronarico. Consumammo in fretta gli argomenti di conversazione: il villaggio che invecchiava, gli anziani che morivano, la chiusura dei negozi, i cambiamenti nei ritmi della vita nell’ultimo mezzo secolo, la guerra, l’occupazione e poi la Liberazione. Poi tornai su quella giornata di allodole, di patate, di aereo che solcava il cielo. Lui non ricordava le circostanze, l’occasione, ma ritrovò senza difficoltà la risposta alla mia domanda. “Al Polo Nord”. Interrogato sulle ragione di quella destinazione, aggiunse: “Beh, non so perché…”.
Vedo mio padre invecchiare da quando sono bambino; temo gli effetti del tempo su di lui; conto gli anni, sbaglio le date e mi rallegro di un lapsus che ogni tanto mi fa invertire il giorno e l’anno della sua nascita – 29 gennaio 1921, trasformato da me in 21 gennaio 1929 – e augurargli buon compleanno alla data sbagliata. Così, quell’inversione fabbricata dal mio inconscio mi permette di regalargli otto anni di ringiovanimento. Per i suoi ottant’anni, mi misi in testa di offrirgli il Polo Nord, il suo Polo Nord.
L’appuntamento era per il 2001, per spegnere ottanta candeline al di là del Circolo Polare Artico. All’inizio di agosto, mio padre riempì la sua valigetta come uno scolaretto, andò in prefettura a richiedere il primo passaporto della sua vita: lasciare il suo villaggio natale per un paese fuori della Francia, sperimentare l’aereo, conoscere il fuso orario, allontanarsi da sua moglie come mai prima, e sopportare suo figlio per ben dieci giorni… Partì per fare ventimila chilometri come se dovesse andare nel suo orto, l’animo lieve, senza inquietudine, senza angoscia, sereno. Quattro aerei dopo, una pausa a Montréal, sbarcammo a Quiquitariuak, un villaggio inuit di 500 abitanti. Nuvola di polvere, atterraggio tra montagne e mare, tempo capriccioso, freddo pungente scendendo dall’aereo.
Ecco il Polo Nord di mio padre, il Grande Nord, al di là del Circolo Polare Artico. La sua prima reazione è di delusione… Infagottato nel suo abbigliamento polare, mi dice: “Non me lo immaginavo così. È come da noi!” Effettivamente, davanti alle baracche in muratura, le antenne paraboliche, l’elettricità e il passaggio di macchine o di quad che non andavano da nessuna parte, ci si poteva legittimamente chiedere per quale ragione avessimo attraversato il pianeta. E ci restavano dieci giorni da vivere in quel posto!
Pauloosie fu la nostra guida. Settantaquattro anni, il viso abbronzato, gli occhi a fessura, le pupille scure dissimulate, i capelli neri quasi a spazzola, il passo felino, elastico e pesante come quello del sublime orso bianco, molto probabilmente sciamano, ma anche pastore al bisogno, saggio del villaggio, autorità incontestata e riconosciuta, padre di una famiglia numerosa e attiva al suo fianco, lo chiamavano anche Atata – papà in lingua inuktitut, la sola che parlasse. Aveva conosciuto igloo e cani da slitta, caccia all’orso e pasti di tricheco, balene squartate nel villaggio e abiti in pelle d’animale. La cartolina che mio padre sognava… Fu lui dunque il pilota del nostro battello, quello che ci condusse per i paesaggi sublimi e ci sistemò in accampamenti sommari, austeri e rudi; che evocò l’orso, in una preghiera sciamanica di cui conservava il segreto, perché lo potessimo vedere il giorno dopo; e che ne trovò cinque o sei, offerti come omaggi magici durante il nostro soggiorno. Fu lui che ci fece gustare la foca cruda al riparo di un fiordo bordato d’oro dalla luce perpetua dell’estate; che condivise con noi il beluga fermentato – che poi non è nient’altro che balena putrida; la zuppa di caribù, la foca bollita; ci raccontò ancestrali storie eschimesi aiutandosi con ossa sparse in un gioco singolare. Ci fece vedere gli iceberg, gli hummock, le balene, banchi di foche groenlandesi…
Poi diede a mio padre l’occasione di comprendere che, se era stato deluso perché tra il suo desiderio e la realtà di quel viaggio c’era una bella differenza, ebbene un altro viaggio sarebbe stato possibile in quel luogo, in compagnia di Pauloosie: un viaggio più rude, più vero, più forte, un viaggio di certezze mirabili e di ricordi sulla pelle, un viaggio immortale e duraturo quanto i suoi testimoni. Dono regale, come sanno fare i Re e i Figli di Re.
La nebbia pesante caduta sull’accampamento all’alba si aprì su una scena memorabile. Pauloosie e i suoi due dipendenti – Jonas il taciturno dai buffi baffetti da foca, berretto e cuffia di walkman perennemente piantata sulle orecchie, e Livi, che traduceva dall’inuktitut all’inglese – erano riandati a dormire dopo aver sentito le previsioni meteo: purea di palline bianche, impossibilità di mettere il naso fuori, ritorno a letto. Da parte nostra, aspettavamo l’evolversi degli eventi. Buona occasione per riprendere dove l’avevo lasciato il De vita solitaria di Petrarca… Alain, il mio amico fotografo, prendeva esempio dagli inuit e dormiva nel kamak ghiacciato. Nel primo pomeriggio apparve Pauloosie. Caffè, chiacchiere, atmosfera dolce, calma, serena.
Quando seppe che mio padre era voluto andare lì per festeggiare gli ottant’anni con il figlio che gli offriva questo regalo, fece un gesto impercettibile, quasi per se stesso, senza rumore, senza movimento realmente visibile: piegò la testa e batté le sue grosse mani come per applaudire. Poi si mise a raccontare la sua vita: le qualità di cacciatore di un buon capovillaggio, l’onda creata dall’esplosione di un iceberg – sul battello, avevamo assistito all’affondamento di un iceberg – che sommerse da parecchi chilometri di distanza l’igloo in cui perse la vita un suo fratello, la caccia all’orso in un’epoca in cui si rischiava la vita, le piante allucinogene della Terra di Baffin – utili allo sciamano, ma nascoste alle giovani generazioni – i rapporti con gli americani e i canadesi che distrussero la loro civiltà rendendolo un popolo sedentario… Parlava la sua lingua e Livi traduceva. All’improvviso, nell’intervallo necessario alla traduzione, Pauloosie colpì il pugno sul tavolo. Poi, incredibilmente, impossibile a immaginare, quel saggio indiscusso del villaggio, quella volontà riconosciuta da tutti, quell’anziano che portava tutta la verità di una civiltà fedele alla memoria, si mise a piangere. Intorno al tavolo, tutti avevano un nodo alla gola.
Terrorizzato da ciò a cui assisteva, dondolandosi irrequieto sulla sedia, Livi traduceva: le autorità degli Stati Uniti e del Canada, nel 1962, avevano deportato quelle popolazioni, facendo loro intravvedere migliori condizioni di vita, avevano incendiato i villaggi, concentrato popolazioni che non si conoscevano in baracche in muratura – le famose baracche attuali. Pauloosie aveva vissuto quella tragedia, e sul suo conto erano state messe in giro calunnie sinistre che ne facevano un collaboratore dei colonizzatori. E piangeva ricordando il massacro dei suoi cani: quarant’anni dopo, quel colosso inuit fabbricato dal ghiaccio, dal vento, dal freddo, dalla rudezza, quel personaggio costruito dalla magia boreale, piangeva…
Mio padre comprese di colpo: quel viaggio intrapreso per vedere ciò che non aveva visto generava delusione e disappunto, certo; ma comprendeva anche che non se la poteva prendere se passava accanto a ciò che non esisteva più. Comprendeva che quel mondo sognato nell’ora dell’infanzia, desiderato in età adulta e raggiunto da vecchio era stato distrutto dagli americani e dai canadesi ansiosi di fare piazza pulita in vista di un eventuale conflitto atomico con i sovietici; scopriva nelle lacrime di quell’esquimese ferito nel profondo dell’anima la prova dell’eccellenza di quel viaggio che andava fatto – per sapere, comprendere e raccontare, una volta tornato in Francia, l’etnocidio di quella civiltà oggi scomparsa. Mio padre: “È un po’ come da noi, in Europa… L’uniformità, è questo che non va bene”, mi disse scuotendo la testa, ricomponendosi poi in un silenzio di compassione nei confronti di Pauloosie.
Per mio padre, il Polo Nord fu Pauloosie, la memoria e il verbo di Pauloosie, le sue confidenze e i suoi gesti, le sue complicità eloquenti e la sua vicinanza silenziosa.
In un accampamento dove c’erano soltanto zanzare fastidiose, freddo e umidità, mentre stavamo seduti su pietre o su ciocchi di legno, a mangiare il salmerino cavaliere pescato con la rete nell’acqua del fiordo e poi grigliato su un fuoco di legna, Pauloosie arrivò con una sedia. Spettacolo surreale, quella sedia in mezzo alla natura vasta, immensa, superba e austera: lui avanzava come un orso bianco, possente e deciso, la sedia che gli ciondolava dal braccio. Dinanzi a un pubblico stupefatto, posò a terra l’oggetto e invitò mio padre a sedersi. L’anziano venerato, ammirato, rispettato dai suoi rendeva pubblicamente omaggio al più anziano di lui… Ogni giorno, sul ponte del battello dove il freddo, il vento, la pioggia, la nebbia, gli spruzzi, il rollio e il beccheggio rendevano il viaggio penoso, Pauloosie invitava mio padre a raggiungerlo in cabina, al caldo, al riparo.
Un giorno, l’esquimese tirò fuori una piccola macchina fotografica usa e getta, poi gli disse di mettersi in posa. Scattò una foto. Silenzio, sorriso, complicità, silenzio di nuovo… Fuori, mentre noi lottavamo contro l’umidità, fradici, congelati, mio padre, all’asciutto, scaldato da una stufetta, compiva il suo viaggio a fianco del suo complice taciturno come lui. L’uomo della terra e quello dei ghiacci riconciliati nell’essenziale, al di là della barriere della lingua – quello che avevano da dirsi era troppo essenziale per passare per le parole.
Avemmo allora paesaggi sublimi, fiordi magnifici, orsi impressionanti, balene furtive, foche misteriose, cieli straordinari, scogliere irreali, colori stupefacenti, iceberg azzurri o verdi, ghiacciai minacciosi e immensi, pietre e deserti di pietre, piante rare e segrete, uccelli venuti da chissà dove che bucavano la nebbia e ripartivano verso l’invisibile, sangue bevuto, la faccia imbrattata da un pasto di foca cruda, le bocche piene del profumo di nocciola dei beluga fermentati, le parole pronunciate dallo sciamano, di notte, per chiamare l’orso bianco. Ci fu il Grande Nord, certo. Ma ci fu soprattutto l’incontro tra due silenziosi, due uomini ancora radicati, fabbricati dalla natura, essenziali, veri e solidi come gli elementi di cui fanno parte. Due esemplari in via di estinzione…
All’aeroporto per la partenza, aspettando che l’aereo bucasse la nebbia per ricondurci verso la civiltà, Pauloosie e mio padre si tenevano vicini, silenziosi, immobili; comunicavano con i loro mutismi, più che con le parole o i gesti. L’aereo atterrò, noi prendemmo posto, e decollò. Mio padre si girò, guardò il villaggio dall’oblò, prendemmo quota e vedemmo la banchisa spaccata, le nevi eterne, il movimento dei ghiacciai. Credo che nel silenzio che continuava mio padre scoprisse di non aver visto quello che era venuto a vedere, ma di aver visto soprattutto quello che non si sarebbe mai immaginato di trovare: il suo doppio boreale, il suo simile polare – un uomo costruito su verità essenziali, uno di quegli esseri con cui si fabbricano i modelli di serenità, di virtù, di forza e di incorruttibilità. Padri…
Un libro manca – che dico, un dizionario, una enciclopedia monumentale – che possa raccontare nel dettaglio con quale talento consumato le civiltà occidentali, bianche, cristiane e mercantili abbiano consumato gli etnocidi. Senza emozioni, senza lacrime, senza esitazioni e senza rimpianti, nel sangue, le armi in pugno, a colpi di sciabola, di schioppo, di impiccagioni, di ascia, di stupri e di altre delicatezze degne delle nostre culture raffinate, un numero considerevole di culture e di popoli sono finiti nel dimenticatoio. Il conquistatore, il missionario e il mercante, queste tre figure della negazione dell’Altro, hanno imposto i loro feticci su tutti i continenti. L’Ordine, il Cristo e il Denaro, le tre divinità malvagie, esigevano la sottomissione degli uomini e la rinuncia alle loro radiose soggettività. Pulsione di morte contro pulsione di vita, peccato originale contro innocenza del divenire, lavoro contro piacere, accumulazione di merci contro produzione di sussistenze, odio del corpo contro voluttà senza complessi, vita come punizione e non come occasione di giubilo: ecco ciò che i vincitori trascinavano nelle stive dei loro galeoni.
Tra i soprusi bianchi c’è, l’etnocidio del popolo inuit in America del Nord. La sedentarizzazione forzata di un popolo la cui essenza procedeva dal nomadismo, l’imposizione di un alfabeto creato di sana pianta dai missionari e imposto a una comunità che viveva di oralità e di trasmissione verbale: queste le violenze principali per distruggere una cultura. Ciò che il viaggio, l’accampamento, la caccia presupponevano di saperi è scomparso; ciò che la comunità, il racconto, il mito, la trasmissione della memoria dagli anziani ai giovani riuscivano a strutturare è morto.
Resi stanziali, colpiti nei loro scambi verbali, gli inuit si facevano ormai controllare, gestire, sorvegliare, dirigere, guidare, condurre. Accettando le case offerte dai nordamericani, ammettendo un alfabeto inuktitut, il popolo artico firmava la sua condanna a morte. Tanto che le arti associate a questa cultura – viaggiare in un cielo, decifrare una luce, interpretare la neve, leggere la superficie del mare, comprendere un volo di uccelli, scoprire le tracce di un animale, cogliere la lezione di una roccia, accedere all’intelligenza di un cane, assimilare le abitudini di un mammifero marino, conoscere il corpo della selvaggina per dirigere l’arpione o la freccia senza far soffrire, riciclare gli avanzi della caccia per la fabbricazione di utensili, di vestiti, di abitazioni (le finestre dell’igloo fatte d’intestino di foca), costruire un’abitazione di ghiaccio… – tutte queste tecniche e tutte queste arti sono perdute, disciolte come neve al sole.
Al posto di questi saperi antichi si scopre oggi solo desolazione: baracche prefabbricate in legno sormontate da antenne satellitari, ambienti surriscaldati in cui vociferano serial americani che durano intere giornate, una misura artificiale del tempo che ignora i cicli naturali, fucili, gatti delle nevi, benzina, veicoli quattro per quattro, cani diventati pazzi, pericolosi, indomabili e, per questa ragione, parcheggiati su un’isola senza uomini, alcool, droga, colla da sniffare, prodotti cosmetici avariati, stupri, delinquenza, pigrizia, alimenti conservati. La morte distillata nel quotidiano…
Qualche anima buona si è commossa e ha perfino (vagamente) condannato l’etnocidio di questo popolo ingannato, spogliato. La passione cristiana per la confessione, per il perdono, per la contrizione, ha generato un strana logica che, fingendo di ripagare le colpe bianche, continua ad assicurare la dominazione dei bianchi stessi. Sostenendo di voler cancellare il male coloniale passato, essa riformula un neocolonialismo contemporaneo.
Se le buone coscienze occidentali avanzano contrite, sono dedite al pentimento e propongono qualche forma di riparazione, al tempo stesso esse offrono veleni che, lungi dal curare, accrescono il male che trionfa senza incontrare resistenza. Come? Per esempio, accelerando il processo di acculturazione inuit sul modello delle civiltà bianche, soprattutto americane, e proponendo agli eschimesi di diventare caricature degli occidentali; l’assistenza economica integrale permette ai giovani di comprarsi berretti Nike, scarpe da ginnastica e capi di vestiario firmati, di avere il computer, internet, mentre i loro genitori sbavano davanti allo spettacolo televisivo del mondo consumistico senza alcuna speranza di poterne un giorno farne parte.
Lo stesso dicasi per la creazione del Nunavut, un’entità amministrativa che propina agli inuit un genere di micro-società a loro misura, ma che, di fatto, serve da mediazione al potere canadese. La sopravvivenza del popolo esquimese non passa dall’integrazione nel melting-pot nordamericano. Il processo è inconscio? Succede ai popoli come agli individui? La loro psiche ubbidisce alle stesse leggi, alle stesse regole? Probabilmente. Certo è che gli inuit possono legittimamente guardare il tecnico che installa il computer, il magistrato che fa giustizia in un tribunale falsamente locale ma in realtà americano, il funzionario che assicura l’esistenza amministrativa del Nunavut, il poliziotto – tutti rigorosamente bianchi, sempre, venuti da Montréal, dal Québec o da Ottawa – come i veri discendenti dei marinai, dei preti e dei mercanti che, due secoli fa, hanno affrettato la caduta della loro cultura e assicurato la morte della loro civiltà.
Che fare? Bisogna accontentarsi di prendere atto? Bisogna scegliere tra la rassegnazione, la rinuncia, il pessimismo, il disfattismo e l’acquiescenza beata a queste forme astute di neocolonialismo? O si può immaginare qualcosa di diverso? Io sostengo un’ipotesi alternativa che presuppone che la smettiamo di pensare le civiltà in termini di superiorità e di inferiorità – il vecchio male razzista – o il suo doppio, il male moderno e recente; che la piantiamo di studiare la soluzione del problema nei termini darwinisti di integrazione o di assimilazione – cioè a dire di scomparsa. Né assoggettati, né digeriti.
Le civiltà vincono se si fortificano le une con le altre. Gli amici di André Breton aprirono la strada in questo senso, già nel 1929 in Variétés, disegnando una carta del mondo che assegnava a ciascun paese un posto in proporzione al volume simbolico delle sue promesse culturali innovative. Su questo mappamondo surrealista, l’America del Nord non esiste affatto, ma l’Alaska, il Labrador, la Terra di Baffin, l’Artico, la Siberia sì e sono paesi ipertrofici; l’Africa e l’Oceania occupano un posto fondamentale; non l’Europa, se si esclude la Germania, l’Austria e Parigi, ridotta a un punto; l’Afghanistan, le Antille e tutte le geografie ricche di potenzialità liriche, poetiche, dionisiache occupano uno spazio considerevole.
Traendo spunto dallo spirito surrealista, facciamo a quelle culture qualcosa di diverso dall’elemosina di un riconoscimento etnologico o artistico nelle nostre istituzioni; offriamo loro uno statuto diverso da quello di popoli primigeni, attribuito con l’arroganza disinvolta di imbalsamatori che insistono a impartire lezioni dall’alto dei loro musei; pensiamole piuttosto come culture in grado di infonderci uno spirito nuovo e di arricchirci spiritualmente. In quale maniera? Ispirandoci alle loro forze e ai loro princìpi cardinali: stabilire una relazione non aggressiva con la natura, ritrovare il senso di un paganesimo sciamanico, e costruire un’intersoggettività contrappuntistica – tre lezioni in grado di permettere un’ecologia, una mistica e un’etica capaci di sconvolgere quei campi confiscati in Occidente dalla politica mondana dei politicanti, dall’esoterismo approssimativo new age e dalla morale moralizzatrice. L’anelito glaciale, soffiando sul vecchio mondo che porta sulle spalle la paccottiglia ereditata dalla Giudeo-Samaria, può vivificare la nostra epoca postmoderna, nichilista e depressa.
Prima lezione: produrre una cosmogonia degna dei presocratici, elaborare un pensiero autentico degli elementi, indurre una preoccupazione per il mondo e per il pianeta che non sia soltanto il prurito di cittadini sradicati, ma una visione di grande portata – ecco che cosa manca ai nostri tempi disorientati.
Nell’immaginario europeo, la cultura si schiera contro la natura mentre potrebbe funzionare con questa, in complicità, nel rispetto di ciò che essa insegna e delle certezze cui essa si inchina. Questa frattura degli uomini con la natura li indispone alla vita e alla morte, alla loro sessualità, alla loro vitalità, alla loro energia e alla loro libido. La civiltà si struttura falsamente contro la natura – peggio, essa si presenta ideologicamente come un’anti-natura. La rivoluzione industriale ha opposto il progresso delle città al conservatorismo delle campagne. E questi luoghi comuni riveriti come verità evidenti hanno condotto a una civiltà violenta, brutale, nevrotica e affascinata dalla catastrofe.
Quanto a loro, gli eschimesi sono nella natura. Non le si oppongono, ma in essa vivono in maniera simbiotica. Non entità separate, non frammenti, perché, al pari della pernice, dello scisto, del lichene, dell’acqua, della foca, dell’orso o della balena, l’esquimese si sa votato allo stesso destino del vento: di passaggio, mai veramente nato, neanche mai veramente morto, ma sempre chiamato a trasformarsi.
Gli uomini dell’Artico vivono da spinoziani senza aver mai letto Spinoza. Natura naturans e natura naturata propongono due modi di esprimere la stessa realtà, che può anche chiamarsi Dio – se dessero retta alle chiacchiere degli occidentali… Agli antipodi di un’ecologia mondana vissuta come uno snobismo da cittadini nel rimpianto delle infanzie perdute – le loro? – questa ecologia procede dal rapporto identico a quello che Empedocle, Democrito e Anassagora intrattenevano con il reale e con il cosmo: una relazione in cui l’individuo non si pone contro il mondo, con orgoglio e presunzione, ma in cui egli si considera cristallizzazione temporanea di quella stessa materia di cui sono fatti i fulmini, le stelle, i vulcani e le brume. Gli inuit pensano da contemporanei dei presocratici, quando filosofi, poeti, matematici, astronomi, artisti erano ancora indistinti.
Seconda lezione, indotta dalla prima: celebrare un paganesimo sciamanico per farla finita con i monoteismi intolleranti, violenti, castratori e fornitori di leggi che sviliscono, con i malesseri che pervadono la civiltà. Le religioni della salvezza forse salvano, ma in un’altra vita; in compenso, in questa, – la sola – esse condannano. Condannano a morire mentre viviamo, a vivere sempre sotto l’occhio di un Dio vendicativo, geloso, malvagio. I sacerdoti, loro ausiliari nella vita quotidiana, ci rendono la vita impossibile, con il pretesto di prepararci alla vita eterna che esiste solo nella mente degli stolti. La maschera da volpe e il tamburo in pelle di foca dello sciamano potrebbero sostituire benissimo i paramenti sacri, l’incensiere e l’acqua benedetta del prete che beve vino e dice che è sangue…
Lo sciamanesimo definisce la mistica pagana dell’uomo che non si è separato dalla natura e continua a volersi frammento della vitalità generale. Nelle grotte preistoriche europee o sui ghiacci antartici, il linguaggio che gli uomini rivolgono alla natura passa per il sonno ipnotico, presuppone l’ascolto delle forze che percorrono la terra, l’acqua e l’aria, caricando gli elementi di un’energia che solo le sensibilità più acute, più straziate, più eccezionali – gli artisti – sono capaci di immagazzinare e di restituire alla comunità sotto forma di legame sociale e di comunità incarnate.
Noi non abbiamo gli sciamani e crolliamo sotto gli opportunisti, i calcolatori, la gente che fa cifre e numeri, i matematici e gli informatici, i banchieri e i commercianti. Tutti sacrificano ad Apollo e voltano le spalle a Dioniso, dio sciamanico quanti altri mai, temperamento del pampino e della danza, dell’ebbrezza e del canto capace di associare i Greci e gli Iperborei in una stessa danza bacchica. La negazione pura e semplice di Dioniso fomenta i malesseri che saturano l’Europa.
Così come bisogna superare l’ecologia mondana, va anche sconfitta la morale della New Age che fagocita lo sciamanesimo nelle sue imprese irrazionali, settarie e folli: astrologia, neobuddismo, riciclaggio di induismo, vegetarismo, orientalismo da bottegai, junghismi di tutti i generi e altri collages utili ai guru che fanno fortuna sfruttando la miseria intellettuale, affettiva e sessuale di un numero di individui sempre crescente.
Terza lezione: prospettare una intersoggettività contrappuntistica e non agonica. Tendere a quell’ideale della ragione che vuole farla finita con la guerra di tutti contro tutti. Allo stesso modo, risolvere quell’aporia che vede l’individuo e il gruppo come forze antinomiche. Gli inuit non pensano l’individuo nella sua opposizione al gruppo, ma nel suo contributo alla totalità. In primo luogo, perché l’individualità fabbricata dal cristianesimo, laicizzata dal Rinascimento, poi resa popolare da Montaigne e da Cartesio, non esiste nelle società tradizionali. E anche perché il gruppo non è la società, lo Stato, il continente, o una delle tante entità politiche fasulle, ma la tribù che resta umanamente vitale.
Diversamente dai gruppi immensi creati dalla nostra postmodernità nella prospettiva prevedibile di un governo del mondo utile a controllare l’insieme del pianeta, gli inuit invitano a micro-società nelle quali l’etica e la politica si confondono ancora a meraviglia. La tribù, l’aggregato costituito sul principio della cooptazione, dell’adesione volontaria, del contratto, ecco la formula della resistenza ai meccanismi mostruosi del nostro tempo. Le micro-società elettive contro le macro-società anonime. In questa intersoggettività contrappuntistica, l’individuo non è il nemico del gruppo, né l’inverso.
L’antinomia posta dagli occidentali costringe a concepire l’individuo in maniera solipsistica, se non autistica, e comunque egocentrica, impossibile da conciliare con gli altri; allo stesso modo, essa costringe a vedere il gruppo come un insieme cieco che ingerisce e digerisce le singolarità. Gli inuit costituiscono gruppi ristretti abbastanza da non far perdere la testa alle loro monadi. Meglio: esse vi trovano la loro definizione, le une rendendo possibili le altre. L’individuo non si rivela, come in terra giudeocristiana, per la sua resistenza alla comunità, alla collettività, ma per la sua capacità di apportarle un’energia capace di strutturare l’insieme e di permettere la sua continuità. L’atomo non contraddice la materia, piuttosto la crea, la rende possibile grazie alle modalità delle sue relazioni con gli altri. Principio cosmico, naturale e genetico…
Le filiazioni eschimesi, per esempio, non procedono dal sangue: non si è figlio o figlia in virtù della genetica e dell’atto sessuale, ma rispetto a una lettura cosmogonica che integra la trasmigrazione delle anime, o quanto meno la permanenza e l’immortalità dell’anelito che anima ogni essere vivente – tutti gli spiriti comunicano. Quando il nonno muore, non può che fare ritorno, e talvolta riappare sotto forma di una bambina che ha tutte le parvenze della femminilità ma che in realtà è il nonno al quale il gruppo si rivolge chiamandola con il nome del defunto.
I popoli artici non sono né selvaggi da respingere né primitivi da indennizzare: l’etnocidio passa sia per la distruzione di massa organizzata di un popolo, dei suoi costumi, della sua lingua e delle sue tradizioni, che per il processo di imbalsamazione che suppone il museo, fosse anche di arte primitiva, e che scaturisce dalla (buona) volontà dei bianchi a stringersi un po’ per fare posto ai selvaggi autorizzati ad accedere alla loro cultura, accanto a Rembrandt, Leonardo e Michelangelo…
Aprire il Louvre alle maschere Yup’ik, o inaugurare un’istituzione parigina che le espone, manifesta ipocritamente o inconsciamente la permanenza di un complesso coloniale, nonostante le buone intenzioni dichiarate. L’unico omaggio che si possa rendere a un popolo non è quello di rinchiudere le sue tracce in un museo, né di dedicargli un culto (non parliamo del tragico culto mercantile), ma di rivendicare l’influenza, di confessare con gioia l’azione genetica dei suoi pensieri, delle sue visioni, delle sue affermazioni, di volarizzare il ruolo motore dei suoi riferimenti nella nostra concezione del mondo. Tra la fossa comune e il museo, esiste un luogo per l’omaggio effettivo, non verbale, ma efficace: chiediamo agli inuit ciò che abbiamo chiesto ai greci e ai romani: di portare un po’ della loro luce nei nostri tempi oscuri.
Traduzione di Biancamaria Bruno

