Esiste il Bene Assoluto, o solo un bene relativo?
di Francesco Lamendola - 11/12/2017
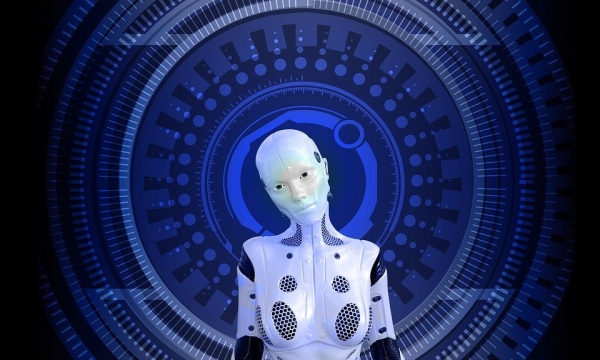
Fonte: Accademia nuova Italia
Si può definire il bene per via positiva?
Abbiamo già riflettuto, a suo tempo, su che cosa sia il bene (cfr. il nostro articolo Che cos’è il bene?, ripubblicato sul sito Nuova Italia. Accademia Adriatica di Filosofia); in questa sede, intendiamo porci il problema se esso sia definibile in via positiva, cioè indicandone la specifica natura, oppure solo per via negativa, ossia indicando ciò esso non è, e dunque giungendo, per esclusione, a riconoscerlo come un’essenza originaria che non sottostà ad alcuna limitazione concettuale ben definita, appunto perché rimanda alla sfera dell’assoluto.
Vi sono alcune correnti di pensiero che hanno quest’ultima posizione, in particolare quelle del panteismo, del monismo, dell’idealismo. Il loro comune denominatore è la convinzione che tutto il reale sia riducibile all’Uno, l’unità assoluta, originaria indistinta e indifferenziata, nel quale è presente ogni singola determinazione, così come il suo contrario: non vi sono più il soggetto e l’oggetto, ma il Tutto, che è sia soggetto che oggetto; e non vi è più nemmeno la tradizionale distinzione fra apparenza e realtà, poiché il Tutto, per definizione, include anche l’apparenza, che però, a quel punto, non è mera illusione, ma possiede anch’essa lo statuto della realtà, dato che l’Uno comprende ogni cosa e quindi anche l’apparire. L’idealismo, e in particolare, tutte le varie correnti neoidealiste, condividono questa posizione speculativa: l’Assoluto si contrappone a tutto ciò che è apparenza (anche se include l’apparenza) e, d’altra parte, può essere definito solo per via negativa, e ciò vale anche per il bene, che è uno dei suoi aspetti, tuttavia non separabile dagli altri, perché l’Uno comprende contemporaneamente tutte le determinazioni del reale.
Per sviluppare ulteriormente la nostra riflessione sul bene, prendiamo, quale base di partenza, un filosofo moderno che si è occupato di esso, Francis Herbert Bradley (1846-1924), professore a Oxford, fra i maggiori esponenti del neo hegelismo inglese alla svolta fra XIX e XX secolo, autore di saggi come Appearance and Reality (1893), Essays on Truth and Reality (19214), The Principles of Logic (1922). I passaggi-chiave della riflessione bradleiana sul problema del bene sono stato efficacemente esposti da Maria Teresa Antonelli nel volume La metafisica di F. H. Bradley (Milano, Fratelli Bocca Editori, 1952, pp. 160-164), dal quale riprendiamo la seguente pagina:
La relazione, in cui il bene si trova con la idea tramite il desiderio, rende innanzitutto inattuabile la riduzione del bene al piacevole. Il piacevole si trova semplicemente in connessione con il bene, in quanto “il bene è piacevole e ciò che è migliore è più piacevole”; ma la connessione non è essenziale, cioè tale da giustificare la tesi dell’edonismo, il quale fa scaturire il bene dal piacere e fa consistere tutta l’essenza del bene nel piacevole, ponendo per sé il piacere come fatto che costituisce finalità ultima. Così configurata, la tesi dell’edonismo risulta semplicemente contraddittoria, in quanto il piacere, che dovrebbe costituire l’essenza del bene, deve a sua volta qualificarsi, e dare una ragione di se medesimo, e non può porre la sua giustificazione se non nel fatto che esso denota e prova la presenza di un certo grado di perfezione: per questa via, per qualificarsi, il piacere rimanda ad un secondo termine oltre se stesso, quello della perfezione, il quale implica a sua volta la connessione con un fattore ideale. Il piacevole, che sembra determinazione ultima, si rivela così in verità come termine del tutto inqualificato che deve ricevere conferma da altri concetti.
Considerazioni analoghe valgono per l’interpretazione che fa del bene una “realizzazione del volere” o lo identifica con il desiderabile. Anche qui la sostanza della confutazione bradleiana consiste nel rimando all’idea: una cosa è bene non solo perché è voluta, ma perché è approvata, e l’approvazione implica un elemento ideale e ci disvela che il bene non è tale perché è ciò che è voluto, ma perché è ciò che deve essere voluto; onde il suo presentarsi non è dato dalla realizzazione del volere, ma piuttosto dal verificarsi dell’approvazione. A sua volta, analogamente, il desiderabile non si presenta come ciò che il desiderio rende desiderabile, ma piuttosto come ciò che deve essere desiderato, e non si denuncia dunque sempre come sufficiente a qualificare e ad esaurire il concetto di bene.
Dalla inidentificabilità del bene con i diversi elementi che coesistono con esso e sembrano specificarlo – mentre non si rivelano nella realtà se non come un semplice indice della sua presenza – il Bradley trae quella che può dirsi la sua definizione positiva del bene, che si denuncia atta a rilevare una interna e insanabile contraddittorietà del concetto in questione: identificato erroneamente ad ora ad ora con uno degli elementi che lo accompagnano, il bene si rivela come qualcosa che coesiste sempre con altri elementi, e dunque come qualcosa che prende vita in forma di attributo di qualcosa di diverso da esso. La bellezza, la verità, il piacere sono via via “forma” e “tipo” di bene, ma il bene non si trova definito da nessuno di questi elementi che lo specificano, e, d’altra parte, non riesce a denunciare che cosa esso sia per sé, se assunto avulso da questi termini specificati e specificanti; ed è per questo che il bene ci suggerisce come definizione più profonda il concetto che esso è alcunché che vive sempre congiunto con altri aspetti dell’universo. Il che significa, almeno secondo l’intenzione e l’illusione del sistema bradleiano, accettare, accogliendo il suggerimento di questa definizione, un capovolgimento della tesi comune: anziché presentarsi come una categoria valida in senso assoluto ed inglobare altri fattori, il bene si presenta come una categoria di riferimento ad alcunché, di appello a norme o tipi ideali, di conato verso una pienezza e un modello, e implica dunque una separazione di idea e realtà. Nella sua forma più generale e più comprensiva può dirsi che il bene sussista come l’immagine dello stadio ideale e completo di realizzazione di alcunché; e se il bene si realizza, se cioè si elimina la distinzione tra idea ed essere, si ha allora una completezza ed una attuazione, ma questo qualche cosa, che si dà come realizzazione e attuazione non è più il bene, ma alcunché che lo trascende: è una perfezione che non si giudica più come tale, in quanto non è più distinta dalla realtà; ed il bene come tale allora cade. Per questo “il bene non è perfetto, ma è semplicemente un aspetto unilaterale di perfezione; esso tende a trascendere se stesso, e se fosse completo cesserebbe completamente di essere bene”. Da questo punto di vista cade l’assolutezza del bene, nel senso che il bene si predica di tutto, ma, quando è presente, non è più presente come bene ma come termine di realizzazione di una più vasta perfezione.
Dalla non esistenza di una assolutezza del bene in sé segue come corollario la non esistenza di un Bene Assoluto: esistono solo – come sempre nello spettacolo della realtà bradleiana -, e come già per il vero, - livelli più alti o più bassi di bene, i quali non sono se non livelli di approssimazione maggiore o minore del reale al carattere dell’Assoluto. E giudicare allora del bene dalle apparenze è ancora come giudicare del vero e del reale: il criterio della validità di una esperienza come buona è dato, come sempre, dalla combinazione del carattere della estensione con quello della interna coerenza. Il perfetto (coerente) e il completo (comprensivo), il più ampio e il più pieno, sono le due qualifiche che decidono del livello di intensità del bene. E dal punto di vista di questo criterio si può asserire in senso traslato del Tutto la sua concordanza con la realizzazione del bene, mentre pur si nega la riduzione di esso alla categoria del Bene: si può dire cioè dell’Assoluto che esso è assolutamente buono, in quanto è il più ampio ed il più pieno, e ancora che esso è la sola Bontà, come il termine cui risale in senso definitivo il concetto di perfezione, mentre il Bene, per sé, diventa qualcosa che non è nulla, in quanto esso dovrebbe essere la perfezione, e la perfezione, d’altro canto, non si ha se non nella forma sell’Assoluto, che trascende il concetto limitato di Bene. Le due esigenze specifiche del Bene, pertanto, l’ampiezza e la pienezza, l’estensione e la coerenza, costituiscono il dramma di una interna contraddittorietà del bene, che l’Assoluto compone, ma solo a patto di superare il bene come tale e di concretarsi piuttosto in una superiore perfezione.
In verità, pensare il Bene come una categoria assoluta e ideale, priva di determinazioni concrete, e non definibile se non quando, di volta in volta, esso si manifesta nella realtà concreta, associandosi a delle qualità secondarie le quali, dall’osservatore esterno, vengono scambiate per ciò cui si accompagnano, e cioè, appunto, per il bene, mentre non lo sono – il piacere, il volere, la bellezza, eccetera – ha tutta l’apparenza di un ragionamento tautologico. Gli idealisti partono da un assunto: tutto è Idea, e l’Idea è l’Uno; poi vanno a verificare cosa siano il bene, il vero, il bello, eccetera, ma con la lettera minuscola, e trovano che essi non sono realtà sussistenti, non esistono allo stato “puro” allorché si tenta di coglierli, ma, proprio come l’istante, che fugge allorché si dice: Eccoti!, e già non è più quello, allo stesso modo anch’essi si lasciano cogliere solo nella misura in cui si mescolano ad altre qualità, ma allora non sono già più quello che erano, son qualcos’altro, qualcosa di diverso da ciò che erano e da ciò che parevano. È inevitabile: se si presuppone che l’Idea è assoluta ed eterna, mentre le cose concrete vanno e vengono, il bene, come gli altri valori etici, estetici, logici, non potrà che essere una copia sbiadita di quella; la quale resterà sempre intangibile e inafferrabile, librata nelle sue inaccessibili altezze.
Ma è proprio vero che il bene, quale noi lo troviamo nella realtà concreta, è sempre una scala di misura – più bene o meno bene – rispetto a qualcos’altro? Ed è proprio vero che la verifica di una cosa o di una situazione come “buona” consiste nel trovare in esse le due qualità dell’estensione e della coerenza? Con tutto rispetto, ci sembra che qui si potrebbe avanzare l’obiezione di Socrate ai sofisti (nel Gorgia), che, cioè, un calzolaio, per mostrare la sua eccellenza nella propria arte, dovrebbe andarsene in giro per la strada calzando ai piedi delle scarpe grandissime e numerosissime: cosa, evidentemente, assurda e grottesca. Che diavolo c’entrano l’estensione e la coerenza, con la perfezione di una cosa riguardo al bene? Possono aver a che fare con la sua perfezione in senso tecnico: una ghigliottina è perfetta quando la sua lama è taglientissima e il meccanismo che la fa cadere sulla testa dei condannati è perfettamente oliato ed efficiente. Ma la ghigliottina, ahimè, non ha nulla a che fare col bene; a meno che si consideri un bene l’eliminazione dei nemici. Bisognerebbe però vedere se quei nemici meritano tale sorte e se coloro che li mandano a morte sono davvero migliori, questione che eccede di molto il fatto tecnico della perfezione dello strumento adoperato; senza contare che bisognerebbe domandare al condannato, il cui collo poggia sulla semilunetta inferiore che forma una specie di collare, in attesa del calare della lama, se egli pensa che la ghigliottina sia un bene o no: il che ci riporta alla decisiva domanda: quando diciamo che una cosa è buona e che il suo avversarsi è un bene, intendiamo dire che è un bene per chi? A nostro parere, non si può dire che una cosa è buona solo perché abbraccia la maggiore gamma di realtà possibile, e perché gode della maggiore pienezza concepibile. Questo è un modo di pensare quantitativo, cioè materialista, che non si addice, oltretutto, a un idealista, e forse non si addice a nessuno, perché le qualità morali, come il bene, non hanno nulla che fare con l’estensione, anzi, è noto che i buoni sono meno numerosi degli altri, e che, all’interno del singolo individuo, il bene emerge e si realizza più raramente del male, o della mera ignavia. Inoltre, anche la coerenza è un indicato malfido, perché esso registra la “pienezza” del bene solo in senso esteriore e utilitario, mentre è noto che, talvolta, il vero bene dell’individuo non è ciò che lui desidera e spera, ma, forse, tutto il contrario, cioè che i suoi desideri non si realizzino e che i sui progetti falliscano; e magari sarà lui stesso, a distanza di tempo, a riconoscersi fortunato perché, quella volta, le circostanze gli erano state contrarie.
La separazione radicale fra idea e realtà è la caratteristica di ogni idealismo, ciò che mostra che ogni idealismo si risolve in una forma di dualismo. Ma se vi è un dualismo di idea e realtà, allora non è vero che tutto è Idea; può essere vero solo se le cose appartengono all’idea, se sono idee anch’esse: eppure, noi vediamo che le cose non sono idee, e gli stessi idealisti si premurano di asserire che le idee non si risolvono mai del tutto nelle cose. Ma quale statuto ontologico hanno le cose, allora? Evidentemente, quello di apparenze. Benissimo: ma allora le cose sono nell’idea solo in quanto apparenza di ciò che, di per sé, non è reale; vale a dire che, in quanto cose, svaniscono, e resta solo l’idea. L’idea è reale, non le cose. Ma allora, come mai gli idealisti, Bradley incluso, affermano che non esiste il Bene Assoluto, ma esistono solo dei livelli maggiori o minori di bene? Se il Bene Assoluto non c’è, di quali livelli stiamo parlando? È come parlare di un termometro senza il mercurio: come si fa a misurare il bene di una cosa, se il bene, in realtà, non esiste nella cosa concreta, né fuori di essa? Essi rispondono che il Bene Assoluto non c’è, ma che l’Assoluto è assolutamente buono, appunto perché comprende il massimo dell’estensione e della coerenza. Ma questo non è un sofisma? Se l’Assoluto è assolutamente buono, non deriva da ciò che esso è il Bene con la maiuscola, cioè il Bene Assoluto? D’altra parte, voler far derivare la sua perfezione, ossia il suo carattere di bene, dal fatto che esso è quanto di più esteso e di più coerente sia dato immaginare, ci pare un po’ poco. Qui non si fa questione di estensione e di coerenza: si fa questione di essere. Se il bene è, allora è il Bene Assoluto; se una cosa partecipa del bene, allora si tratta di un bene relativo. A questo punto sì, possiamo immaginare una partecipazione maggiore o minore delle cose all’idea, e dell’idea all’essere: ma non in quanto all’estensione e alla coerenza, bensì in quanto alla somiglianza, o meno, con il Bene. Una cosa è più o meno buona, se somiglia più o meno al Bene; se riflette, in qualche misura, la luce che viene dal bene. Ma il Bene esiste, non è un’idea astratta; se non esistesse, da dove verrebbe il bene, sia pure parziale e limitato, che noi riscontriamo trovarsi negli enti?
Il problema dell’idealismo è che esso pone l’Idea come origine di tutto il reale. Ora, Idea significa pensiero: quindi si torna al Motore Immobile di Aristotele: a un Dio che è Pensiero, ed esclusivamente Pensiero di se stesso. Che altro potrebbe pensare, se è lui il Pensiero, e tutta la realtà è pensiero e nient’altro che pensiero? Infatti, abbiamo visto che le cose concrete, in questa prospettiva, sono irreali, forse illusorie, comunque non permanenti. Ma l’essere, da dove viene? Dal pensiero, dicono gli idealisti. Impossibile: il pensiero dà ancora e sempre pensiero, e null’altro che pensiero; è l’essere che dà ogni altro esistente, anche il pensiero. Il pensiero viene dall’essere, non l’essere dal pensiero. L’idealismo capovolge i termini del rapporto fra causa ed effetto: e quante fumisterie, quanti ragionamenti contorti, incomprensibili, svolgono Fichte ed Hegel per rendere ragione di una cosa talmente contraddittoria; si dice che lo stesso Hegel ammettesse candidamente di non capire, spesso, il suo stesso pensiero, le cose che lui stesso aveva scritto, magari poche ore prima. Figuriamoci gli altri. La realtà ultima non può essere idea, per una ragione molto semplice: l’idea è sempre idea nella mente di qualcuno; il pensiero, è sempre il pensiero che viene pensato da un soggetto. Ma chi pensa l’Idea, se l’Idea è l’ente originario, se è l’Assoluto? Evidentemente, ciò è impossibile: nessuno può pensare il Pensiero, se il pensiero è l’origine del reale; altrimenti, cadremmo nella spirale di un regressus ad infinitum e non ne usciremmo più. Ciò dimostra che l’Idea non può essere il fondamento del reale, la causa prima: l’idea è pensiero, ed è il pensiero che procede dall’essere, non viceversa.
Un’ultima osservazione (ma, naturalmente, su questo tema si potrebbero scrivere delle intere enciclopedie). L’idealismo è agli antipodi del cristianesimo; semmai, va d’accordo con la gnosi. Nella visione cristiana, la causa prima non è il pensiero, perché Dio non è semplicemente pensiero: è Amore, Giustizia, Verità e Bellezza; e non si tratta di idee, ma di attributi della sua natura. Sono altrettanti aspetti della sua divinità, del suo essere; e i loro riflessi tralucono nelle creature finite, fatte a sua immagine: gli uomini. Ma Dio, Lui non è Idea, perché, se lo fosse, sarebbe l’idea di qualcun altro: il che è assurdo. Assurdo, tranne che per gli gnostici, i quali non si spaventano davanti a così lievi difficoltà e affermano, senza batter ciglio, che Dio è una creazione della nostra mente, e quindi è un Dio che diviene, un Dio che sarà, evolvendo insieme alla coscienza universale.
Giunti a questo punto, torniamo alla domanda: esiste il Bene Assoluto, o il bene è solo un concetto relativo, sparso, per così dire, in mezzo alle cose, mai però realmente afferrabile e definibile? Sì, esiste, come esistono il Giusto, il Vero, il Bello: sono tutti attributi dell’Essere, sono tutte facce del volto di Dio. A noi, menti finite, essi appaiono separati, o, in ogni caso, separabili; ma in Dio, no, sono una sola e perfetta unità. Dio è l’Essere nel senso forte della parola essere: il che significa che di Lui, a rigore, non potremmo dire nulla, se non che, appunto, è. Degli enti possiamo dire ciò che sono, perché sono finiti; ma dell’Essere infinito, a rigore, non potremmo. Se non che Lui stesso, nella sua infinita generosità, ha voluto farsi conoscere da noi, beninteso per quel poco che noi siamo in grado di ricevere della sua luce abbagliante, e per quel tanto che basti a soddisfare anche il nostro bisogno di comprensione razionale. Ma Dio è oltre la nostra ragione: con essa possiamo arrivare a comprendere la sua necessità logica; per andare oltre, ci viene in soccorso l’Incarnazione del Verbo. Ed è proprio qui che noi troviamo la risposta alle domande su cos’è il bene e come lo si può attuare.
