Joseph Roth e la marcia di Radetzky
di Roberto Pecchioli - 01/05/2018
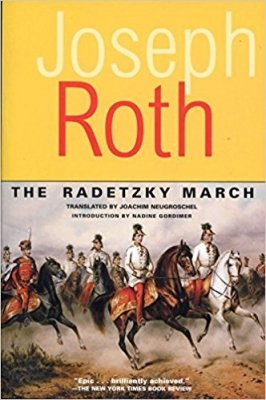
Fonte: Ereticamente
Una confessione: la suoneria dello smartphone dello scrivente è la musica della Marcia di Radetzky,nonostante il patriottismo italiano e pur sapendo che il primo Strauss la compose in onore del maresciallo che domò la rivolta di Milano del 1848. Quest’anno ricorre il centenario della fine del venerando impero degli Asburgo Lorena, data simbolo di una finis Austriae diventata finis Europae. Qualcuno forse ricorda l’incipit della Metamorfosi, il grande romanzo di un altro suddito asburgico, il praghese Franz Kafka: “Gregor Samsa, svegliandosi una mattina da sonni agitati, si trovò trasformato, nel suo letto, in un enorme insetto immondo.” Immaginiamo che non sia stato dissimile il sentimento provato da tanti sudditi del Re e Imperatore in quel drammatico finale del 1918, che sancì la morte di un’era durata secoli. L’impero con decine di nazionalità e lingue cedeva all’azione congiunta del nazionalismo ottocentesco e della modernità liberale.
Gli autori che rappresentarono il dolore lancinante per quella perdita furono numerosi, come Stefan Zweig (Il mondo di ieri) e Robert Musil, il cui Uomo senza qualità rappresenta una metafora dell’uomo di fine impero, fresco cittadino della nuova Europa. Famoso è l’inizio del grande romanzo-saggio, con la minuta descrizione atmosferica e meteorologica della giornata, isobare e isòtere, barometro e vapore acqueo. Un peana alla scienza vincente, giacché, scriveva Musil, sarebbe parso antiquato dire semplicemente che era una bella giornata d’agosto dell’anno 1913.
L’intellettuale che a nostro avviso meglio rappresenta il sentimento della fine di un’epoca, unito con una lancinante, dolorosa nostalgia che impedisce di vivere è Joseph Roth, l’autore del romanzo La marcia di Radetzky. Il giornalista e scrittore visse solo 45 anni, intensissimi, tra il 1894 e il 1939, ma attraversò da protagonista i cruciali anni che vanno dall’assassinio di Sarajevo che dette inizio nel 1914 alla macelleria della prima guerra mondiale – guerra civile europea, come capì Ernst Nolte – sino all’inizio della seconda, ultimo grido d’Europa. Ebreo della Galizia, regione di confine tra l’Ucraina e la Polonia, Roth, come molti giovani israeliti dell’impero, fu affascinato dal socialismo avanzante. Poté svolgere studi regolari a Leopoli, capitale della sua regione natale e nella stessa Vienna. Iniziò la sua carriera bolscevico e terminò monarchico, cattolico, reazionario.
La sua opera capitale ha una caratteristica forse unica nel panorama della letteratura mondiale: è la sola il cui protagonista non è un uomo, una famiglia, una tempo, una città o una nazione, ma un’istituzione, l’Impero, crollata senza speranza quattordici anni prima della pubblicazione nel 1932. La storia di tre generazioni della famiglia Trotta ricorda più l’affresco italiano del Mulino del Po di Riccardo Bacchelli, le vicissitudini degli Scacerni, proprietari di un mulino sul fiume, che I Buddenbrook di Mann, altro romanzo della crisi, imperniato sulla decadenza di una grande famiglia borghese. Nella Marcia di Roth vive e va in frantumi un’istituzione che attraversò i secoli.
Il primo Trotta è un giovane ufficialetto sloveno che salva per caso Francesco Giuseppe, l’imperatore nel corso della battaglia di Solferino del 1859, una della mattanze del secolo nazionalista. Gli viene attribuito un titolo nobiliare e entra nei libri di storia. Consapevole di non avere compiuto alcun eroismo, vorrebbe dire la verità, dedicarle la sua vita, ma tutti, a cominciare dall’imperatore, gli dicono: lascia perdere. Lascia perdere, e Roth sembra rinchiudere in quella frase, ripetuta tante volte nel corso dei secoli, allorché qualcuno cercava di cambiare quella strana costruzione medievale sopravvissuta al tempo, l’Imperiale Regio governo austriaco. La marcia di Radetzky resta uno dei grandi romanzi del XXsecolo, l’affresco amaro e melanconico, forse l’elogio funebre di una costruzione politica che tenne uniti popoli e regni mitteleuropei, finita in pezzi nell’inferno delle trincee del 1914-1918. La sua triste decomposizione avrebbe generato un infinito numero di guerre e calamità, l’ultima le guerre civili dei Balcani di fine XX secolo, le cui convulsioni ancora agitano l’Europa sud orientale.
Joseph Roth visse un destino personale simile. Un conoscente con cui parlavamo della sua figura lo confuse con un altro Roth, ebreo anch’egli, americano, vivente, il Philip del Lamento di Portnoy. Stupiti all’inizio, anzi francamente indispettiti, abbiamo poi concluso che tra i due corre un filo sottile rappresentato più che dalla comune matrice israelita, dall’essere i due poli opposti di una crisi. L’austriaco nemico dei tempi nuovi, nostalgico del passato, dell’ordine antico, l’americano immerso nelle ubbie psicanalitiche, nei tormenti e nelle volgarità della modernità compiuta che contempla il proprio ombelico. Il romanzo americano è il monologo di un uomo fallito, erotomane, nevrotico, morbosamente attaccato alle tradizioni ebraiche ed insieme loro nemico e spregiatore, rivolto allo psicoterapeuta, sacerdote laico di una malsana antireligione. Meglio il Roth “nostro”, almeno per chi voglia mantenere una visione del mondo alternativa alla decomposizione presente.
Il tema della perdita della Patria che si trasforma in male di vivere non fu qualcosa di immediato per il giovane galiziano volontario di guerra, brillante giornalista con qualche tendenza a mitizzare la sua biografia, diffondendo la storia di una prigionia mai documentata. Affascinato dalla rivoluzione sovietica, in cui vedeva la promessa di un’umanità nuova, il suo primo romanzo, La tela del ragno, fu una critica distruttiva del nascente nazionalismo tedesco. Divenne inviato di successo del Frankfuerter Zeitung, progenitore della Frankfuerter Allgemeine Zeitung, la FAZ icona liberal. Il suo viaggio professionale nell’Unione Sovietica del 1926 cambiò completamente le sue prospettive politiche ed esistenziali: “entrai in Russia da bolscevico convinto, ne esco da monarchico”, disse a Walter Benjamin.
In Russia si era scontrato con il socialismo reale, fatto di città ingrigite con gente sciatta e malvestita, senza poesia, senza passato, dominate dalla fretta, dove uomini e donne vivevano con la fronte corrugata. Un mondo senza vita privata, con l’esistenza obbligatoriamente scissa tra le assemblee e la fabbrica. Una società che aveva scacciato il lusso e la frivolezza, sì, ma dove i vituperati borghesi erano stati sostituiti da una casta dominante che Roth definì i proletari filistei. Nelle pagine del Viaggio in Russia descrive uno Stato che ha imposto per decreto un razionalismo banale di bisogni primari, una vita senza metafisica e una nuova morale sessuale che seppellisce l’erotismo e trasforma la donna “liberata” in un fattore sociale di produzione. Disorientato, Roth si volse dapprima infruttuosamente alle sue radici ebraiche.
Scriveva a Stefan Zweig: “Il mio giudaismo non mi è parso niente più che un attributo accidentale, qualcosa come i miei baffi biondi che avrebbero potuto essere neri.” Interessante nel cammino verso la maturità culturale è il romanzo Ebrei erranti del 1927, in cui il percorso degli israeliti dell’Europa orientale verso occidente è visto come un brutale cambiamento di vita imposto da un destino beffardo. Poco tempo dopo, affronterà un tema simile, che diventerà l’elemento ricorrente della sua opera, in Fuga senza fine, dedicato alle peripezie di un soldato austriaco di ritorno dalla prigionia in Siberia, che si trova immersoall’improvviso in una società del tutto trasformata. Il vecchio mondo è morto e Roth si sente profondamente orfano.
Nel 1932, l’anno della Marcia di Radetzky, si converte al cattolicesimo. Subito dopo la presa di potere di Hitler, Roth, travolto anche dalla tragedia della pazzia della moglie, torna brevemente in Austria e poi definitivamente, in Francia. Tra confuse vicende sentimentali, è minato dall’alcoolismo e corona la sua esperienza letteraria con il romanzo La cripta dei cappuccini, seguito ideale della Marcia di Radetzky e il famosissimo racconto dagli ampi tratti autobiografici La leggenda del santo bevitore, da cui verrà tratto un film di Ermanno Olmi nel 1988. Morì nel 1939 per una polmonite mal curata; al suo funerale, stravagante parata di cattolici, ebrei, monarchici legittimisti, letterati, parteciparono anche gli eredi Asburgo.
Joseph Roth, nel triste, interminabile epilogo della civiltà europea è autore imprescindibile in quanto testimone palpitante della nostra tragedia comune, l’immensa guerra civile della prima metà del Novecento, il cui esito fu la fine dell’Europa come centro del mondo. Oggi siamo all’estinzione culturale, biologica ed al rifiuto aperto dell’intero passato comune. Altri presero il comando: gli Stati Uniti, con la barbarie ottimista del denaro che tanto disgustava Roth; l’Unione Sovietica con la triste, brutale razionalità collettivista, crollata per maggiore gloria del capitalismo. Morì a pochi giorni dell’inizio della seconda guerra mondiale, lasciando un messaggio che è molto più di semplice nostalgia del passato. Nella tradizione, suggerisce Roth, questa anticaglia che abbiamo gettato dal davanzale, era nascosto un tesoro. Perderlo è stata una delle nostre calamità.
Nostalgici di ciò che non abbiamo vissuto, guardiamo con rimpianto al patrimonio morale, civile, culturale che ci ha lasciato l’Impero, ma anche ai suoi detriti, iltramonto di una visione della vita che fu un grande modello di sviluppo. La città di Trieste, porto dell’Austria Ungheria, è in declino dal 1918. La sua crisi è drammatica da settant’anni, dopo la perdita dell’Istria e dei traffici mitteleuropei, il cui centro fu il grande porto con i giganteschi magazzini, l’ardita ferrovia del veneziano Carlo Ghega che collegò alla metà dell’Ottocento Vienna con il suo emporio marittimo. L’altra città italiana simbolo del declino è Venezia, austriaca suo malgrado dal 1797 al 1866, emblema di un passato pietrificato, ridotta a fondale turistico per masse sudate ed incolte, incapaci di cogliere il senso di tanta bellezza. Il destino assegnato all’Italia intera.
Tutto questo è racchiuso nel dramma di un evento, la fine degli imperi centrali, che La Marcia di Radetzky esprime nel disgusto del secondo barone Trotta per il presente caotico ed incomprensibile. Ad un personaggio del romanzo, il conte Chojnicki, Roth mise in bocca parole profetiche: “il mondo in cui valeva ancora la pena di vivere era condannato al tramonto. Quello destinato a succedergli non meritava più un solo abitante rispettabile. Non aveva dunque senso essere costanti in amore, sposarsi e magari generare discendenti. “
Joseph Roth nel 1916 fece parte del cordone di soldati lungo il percorso del corteo funebre dell’imperatore Francesco Giuseppe, morto a 86 anni dopo ben 68 di regno. La morte del Kaiser diventa la metafora del tramonto dell’impero asburgico e la perdita dolorosa della Patria: un’Itaca smarrita a cui non si può più tornare. Significative sono le sue riflessioni sull’evento. “Lo choc derivante dalla consapevolezza che una giornata storica era appena trascorsa incontrò la tristezza conflittuale per il tramonto di una patria che aveva educato i suoi figli all’opposizione”. Sentimento di dolore quasi fisico, di cui ci sentiamo partecipi da italiani costretti a rimpiangere un’idea di nazione serbata nel cuore, un luogo dell’anima, più che la sua concretezza. Apolidi per scelta morale, persino estetica, abbiamo trasferito nel campo del mito e dell’utopia un ricordo dell’Italia che non c’è più, allo stesso modo di Roth.
Il nazismo avanzante gli fece pensare che solo la monarchia e la Chiesa cattolica avrebbero potuto animare la resistenza contro quella che chiamò “la peste bruna”, materialista, portatrice di una concezione zoologica dell’umanità. Tutto il contrario delle “vecchie province” nelle quali era dolce vivere. Roth iniziò a rappresentare se stesso come ufficiale austriaco naturaliter cattolico, sostenendo con forza la causa perduta dei legittimisti, sino a tentare disperatamente di convincere l’ultimo cancelliere austriaco prima dell’annessione al Reich a dimettersi a favore di Otto d’Asburgo. Strana, ambigua figura, peraltro, quella dell’ultimo pretendente al trono imperiale, approdato nel secondo dopoguerra all’amicizia con il famigerato conte Coudenhove-Kalergi, il promotore dell’Unione Paneuropea e del piano di progressiva distruzione dei popoli europei.
La Marcia di Radetzky trova compimento nel romanzo estremo di Roth, La Cripta dei Cappuccini, descrizione dell’inabissarsi di quel che resta dell’Austria felix. Quel mondo è condannato alla rovina e alla dispersione, che Roth descrive con uno stile asciutto, duro, in qualche momento cruento. L’ultimo dei baroni Trotta è travolto dalla sconfitta bellica. Prigioniero in Russia, riesce a tornare nell’amata Vienna. Si accorge che la città non è più la stessa; intimamente ferito dai cambiamenti, straniero a se stesso nella città simbolo di tutto ciò per cui è vissuto, finisce per capitolare. Decide di mandare suo figlio in una scuola privata che gli potrà dare un’educazione più consona al mondo nuovo. Per lui, ultimo rifugio dell’anima resta la cripta dei cappuccini, dove è sepolto l’imperatore, emblema di un passato glorioso che non tornerà più. Balza agli occhi la similitudine con le classi dirigenti europee, estranee alla civiltà di cui sono figlie, i cui rampolli vengono istruiti nelle università americane, educati a principi e disvalori opposti al “mondo di ieri”.
L’opera postuma di Roth è La leggenda del santo bevitore. Nei bagliori di lucidità creativa di un uomo vinto dall’alcool, l’esule, una volta di più, ricorre ad una autobiografia coperta. Il protagonista, Andrea, è un ubriacone approdato a Parigi dall’Europa Orientale dopo l’assassinio del marito della sua amante. Una sera riceve 200 franchi da uno sconosciuto intenzionato a convertirsi al cristianesimo, colpito dall’esperienza spirituale di Santa Teresa di Lisieux. L’impegno è di restituire quella somma, perché, nonostante la sua vita raminga di bevitore senza tetto, è “un uomo di parola”, “cattivo, sbronzo, ma in gamba”. E’ la consapevolezza dignitosa di sé, il lascito di quell’origine, l’Impero disfatto, che ha impresso un marchio di decoro e civiltà nell’indifferenza del nuovo che avanza. Andrea- Roth, finalmente, può consegnare alla memoria della santa quei 200 franchi, ma si sente male e muore in chiesa. Le sue ultime parole sono “voglia Dio concedere a noi, a noi bevitori, una morte tanto lieve e bella”.
I personaggi di Roth, il bevitore e l’ultimo Trotta, finiscono per trovare pace unicamente nel luogo simbolo del mondo antico, la Chiesa. Espropriati della Patria, estranei ad una civilizzazione nemica, resta loro il sogno del Trono, la tenace realtà dell’Altare. A noi profughi, esuli di un tempo incomprensibile, hanno strappato anche l’ultimo rifugio, non la fede, la chiesa divenuta un’associazione caritatevole indifferente alla civiltà che ha forgiato. La musica della marcia di Radetzky è la colonna sonora degli ultimi di ieri, il canto del cigno di una scintillante Europa travolta nelle trincee, abbattuta da un vento impetuoso che proprio Vienna ha generato. La psicanalisi di Freud, la secessione viennese e la nuova architettura nemica della decorazione, l’economia liberista della scuola cui dette nome la città, la musica atonale che ha spazzato la grande lezione dei classici, e poi, a impero appena seppellito, il freddo positivismo logico del Circolo di Vienna.
Nella cripta dei cappuccini, insieme al corpo dell’ultimo Re e Imperatore, è sepolta l’Europa, non soltanto la Mitteleuropa. Rivive fugacemente qualche ora all’anno, il primo gennaio, al concerto nella sala barocca degli Amici della Musica di Vienna,tra stucchi, specchi, dorature e la degustazione della torta Sacher. Non a caso, l’evento termina al suono gioioso e anacronistico della Marcia di Radetzky. Allegria di naufraghi o, con le parole di Joseph Roth, la rievocazione lieve e bella di una morte. Dopo il bis, cala la tela.

