Klaus Schawb e Thierry Malleret, “Covid 19: The great reset” (I parte)
di Alessandro Visalli - 22/03/2021
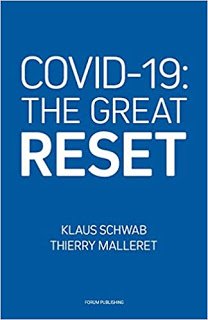
Fonte: Tempo fertile
Il prof Schwab è un ingegnere che ha anche un dottorato in economia alla famosa Università di Friburgo, in pratica la patria dell’ordoliberalesimo, con un master in Public Administration ad Harvard, fondatore del Word Economic Forum[1] ed autore di un libro di grande successo come “The Fourth Industrial Revolution” nel 2016. Si tratta, insomma, di una persona con un curriculum accademico indiscutibile, apprezzabilmente interdisciplinare, e di certissima derivazione ideologica-culturale. Uno dei papi del capitalismo contemporaneo, insomma.
Thierri Malleret è più giovane, sulle sue spalle sarà caduta la redazione di gran parte del libro. Si occupa di analisi predittiva (una remunerante specializzazione) e di Global Risk al Forum. Educato alla Sorbona in scienze sociali e specializzato ad Oxford in storia dell’economia (master) ed economia (dottorato). Si è mosso tra banche d’affari, think thank, impegni accademici e servizio presso il primo ministro francese.
Questo libro fa parte di una proliferante letteratura. Un tipo di letteratura divulgativa ed esortativa, molto generica e contemporaneamente molto larga nella visione, fatta per tradursi in presentazioni da convegno attraenti e stimolanti, dirette ad un pubblico di manager e imprenditori che hanno bisogno di sentirsi consapevoli, aggiornati e progressisti con poco sforzo. Una lettura da weekend sul bordo della piscina.
Una letteratura quindi di medio successo[2], diretta ad una élite mondiale ma anche a quel vasto mondo che aspira diventarlo. Ed una letteratura che ha diversi versanti, quello più aziendalista e quello più statalista, più liberal e più conservative, più basato sull’economia e più sulle scienze sociali e politiche. Un esempio di impostazione statalista, liberal e fondata sull’economico è quella di Mariana Mazzucato in testi come “Il valore di tutto”[3] (2018), o “Mission economy”[4] (2021). In questi due testi, di cui il primo costituisce la base teorica del secondo, l’economista inglese cerca di rimettere in questione la pretesa dell’economia finanziarizzata (e concentrata sul “shareholders value”) di contribuire allo sviluppo sociale in favore di una economia che metta insieme settore pubblico e privato intorno a “missioni” e sia concentrata sull’effettiva creazione di valore per tutti gli “Stakeholders”. Nella stessa direzione, ma con uno scopo più limitato, va il libro di Stephanie Kelton “Il mito del deficit”[5], che si sforza di affermare il punto di vista della Teoria Monetaria Moderna (MMT) e per questa via una “economia per il popolo” che riesca a superare i miti dei limiti alla spesa pubblica e del debito. Invece della politica monetaria la funzione della stabilizzazione macroeconomica è affidata, in questa prospettiva, alla spesa discrezionale per ottenere una economia migliore per tutti. La proposta di maggiore sostanza è di inserire una “funzione di guida automatica” attraverso una regola anticongiunturale di assunzione in pubblici servizi altamente decentralizzati e scelti dalle comunità.
Uno sguardo più concentrato sull’evoluzione delle tecniche, e rivolto a soluzioni meno radicali, se pure in direzione di maggiore regolazione (in particolare della Gig Economy) e protezione dell’occupazione e dei prevedibilmente tanti nuovi disoccupati, è presente nel libro di Richard Baldwin “Rivoluzione globotica”[6] del 2019.
Sguardi attenti all’economico, ma con una prospettiva piuttosto ampia e socialmente densa, sono quelli degli ultimi libri di Paul Collier “Il futuro del capitalismo”[7] (2018), e di Raghuram Rajan “Il terzo pilastro”[8] (2019), oppure, da una prospettiva più liberal, di Thomas Piketty “Capitale e ideologia”[9] (2020). Collier identifica “nuove ansie”, in modo non dissimile da tutti gli altri, e cerca di trovare soluzioni in una nuova etica da rifondare nel sistema economico e sociale. In modo non dissimile da Rajan e Fukuyama, l’autore riafferma la necessità di coesione e identità sociale ma ricerca un modo di riaverla compatibile con le condizioni di frammentazione e pluralismo della modernità. Paradossalmente la risposta non è né nella aerea identità mondiale (che si muterebbe in dispotismo) né nella obsoleta identità statale, ma in quella dei “luoghi”. Intorno a questo concetto si può anche ricostruire un’etica di impresa nel rapporto con il territorio e la creazione di una società inclusiva che rimetta sotto controllo i tre “divari” essenziali: di classe, geografico e globale. Anche l’ex banchiere centrale indiano ed ex professore di finanza alla Booth School of Economics di Chicago, Rajan, sostiene la necessità di ritrovare una via di mezzo (un “terzo pilastro”) tra Stato e mercati ed inquadra in un vasto discorso storico il diesquilibrio provocato dalla svolta neoliberale che porta all’affermazione del populismo. Senza dimenticare di allargare a Cina e India il suo sguardo torna a proporre quindi un “localismo inclusivo” che attribuisca potere alle comunità e le protegga con una “rete di sicurezza”. Le comunità da rivitalizzare dovranno essere basate sulla prossimità (come per Collier) e sia sul sostegno dello Stato come essere dotate di una sovranità responsabile non indifferente alle responsabilità internazionali. Anche qui per le imprese si tratta di passare dalla massimizzazione del profitto a quella del valore. Thomas Piketty, con la sua consueta generosità espositiva, ricostruisce a largo raggio i “regimi della disuguaglianza” nella storia dell’umanità fino a giungere a quella che chiama “la società dei proprietari” (anche detta “capitalismo”). Da questa nella fucina del XX secolo è emersa sia la soluzione socialdemocratica sia, in seguito, l’“ipercapitalismo”. Il testo, enormemente lungo e prolisso, si limita in ultima analisi a rilanciare il progetto federale europeo in senso sociale affinché si sottragga a quella che chiama la “trappola social-nativista”, e ad avviare il superamento del capitalismo attraverso gli istituti della “proprietà provvisoria” (per via fiscale) e della deliberazione aziendale.
Quindi si possono leggere, in una prospettiva più ampia e sensibile agli assetti geopolitici in mutamento, i nuovi libri di Branko Milanovic “Capitalismo contro capitalismo”[10] (2019) e di Francis Fukuyama “Identità”[11] (2018). Milanovic distingue le forme idealtipiche del “capitalismo liberal-meritocratico” e del “capitalismo politico”. Il primo liberale ed occidentale, il secondo orientale e illiberale (ovvero “comunista”). Nella prefazione la crisi post-Covid è identificata come causa di tre principali effetti: la recrudescenza dello scontro tra Usa e Cina (ovvero tra due “capitalismi” nella sua classificazione); la riduzione delle supply chain mondiali e quindi della ipermondializzazione; la rivalutazione del ruolo dello Stato nella vita economica. Da ultimo, Fukuyama, in un libro concentrato sul problema della crescita dei populisti, evidenzia il bisogno di thymos, riconoscimento, dignità, identità, dai quali non ci si può sottrarre.
L’impostazione che danno gli autori di “Covid-19 The Grand Reset” è compatibile con buona parte di questa letteratura, e non di rado la cita in alcuni passaggi chiave. Come la Mazzucato propongono di passare dalla cattura del valore per gli azionisti alla creazione per gli “Stakeholders”, come la Kelton superano l’ossessione per il deficit pubblico e la paura dell’inflazione, come Baldwin descrivono gli effetti della transizione tecnologica e la percepiscono anche come una minaccia davanti alla quale occorre far fronte con più protezione, con Collier e Rajan hanno in comune l’attenzione al territorio ed ai luoghi, come alle identità. Temono come Milanovic il protagonismo della Cina e la crescita dei populismi come Fukuyama.
Tuttavia, la soluzione che propongono è molto meno centrata sul protagonismo statuale rispetto alla Mazzuccato ed alla Kelton (con riferimento al piano di occupazione), è meno localista di Collier e Rajan e su questo molto più in sintonia con Piketty. Si tratta di una soluzione integralmente elitista e fondata sul protagonismo delle grandi aziende globali, alle quali chiedono un deciso cambio di prospettiva e quindi di farsi carico della responsabilità sociale verso le comunità, e dei relativi oneri. Si tratta, in un certo senso e sul piano retorico, di una svolta effettiva: la ripresa della generazione dei beni pubblici intenzionalmente guidata e della conseguente pianificazione. Ma guidata, e qui c’è tutta la differenza possibile, dai grandi attori di mercato. Ovvero, in altri termini, pensata per garantirne la centralità anche dopo il neoliberismo come lo abbiamo conosciuto.
Bisogna essere attenti, il capitalismo avrà anche un suo “spirito”, ma è capace di adattarsi a sempre nuovi ambienti, plurale e decentrato, metamorfico. Lontano dall’essere derivato e diretto dalla tecnica e dall’economico il sistema di regolazione è sempre essenzialmente fondato su una egemonia[12] e questa porta in esistenza delle distribuzioni e delle soggettività, nuove istituzioni, opportunità. La letteratura citata dunque cerca consapevolmente di rigenerare il capitalismo affinché all’ordine segua l’ordine, ed alla centralità dei soggetti creati dal sistema di regolazione neoliberale segua quella dei medesimi (al contempo cambiati). Se la crisi del modo di regolazione ‘fordista’, al calare del millennio, estremizzò e al tempo pervertì gli elementi di questo[13], allargandoli su scala mondiale attraverso una potente dinamica di integrazione subalterna (ponendo al centro nuovi assetti tecnologici e la creazione dell’ordine nel quale viviamo), qui si tratta di ripetere l’operazione. Estremizzare e pervertire, per superare/confermare l’ordine sociale esistente e saltare nel prossimo. Nel post “Il Proconsole imperiale”[14] avevo compiuto il breve divertissement di ricordare l’inno all’ordo renascendi di Rutilio Namaziano[15], scritto nel 417 d.c. In esso il senatore di origine romano-gallica esprime lo sforzo terminale di una illustre ed antica cultura politico-istituzionale di elaborare le strategie necessarie perché i privilegi e le prerogative siano salvate dal disfacimento. Per rilegittimarsi al governo, ricorda Rutilio ai suoi pari, bisogna esercitare una frenata potestas, una moderazione, e risuscitare in tal modo l’entusiasmo ed il consenso popolare intorno a sé, ovvero intorno alla virtus, al meritum, ai boni. Con il suo poemetto, in altre parole, cerca di richiamare tutti i membri dell’ordine, i vecchi come i nuovi, i vari lignaggi, ad una coscienza comune. Quella di essere, alla fine, la pars melior humani generis. L’unica che può indicare, in mezzo alle rovine di un mondo che finisce, la “legge della rinascita”. Ovvero il principio del risorgere dalle proprie stesse rovine.
Come sappiamo non funzionerà. Dopo sessanta anni, l’ultimo imperatore d’occidente sarà deposto.
In “Covid-19: the great reset”[16], i due autori tentano qualcosa che assomiglia al tentativo della casta senatoria nel tardo Impero Romano. Con la stessa buona fede e protervia propongono di essere incaricati dalla società, in quanto clarissimi e boni, di risolvere i problemi che essi stessi hanno provocato. Un tentativo condotto nella stessa linea del libro successivo, “Stakeholder Capitalism”, con Peter Vanham, in uscita in questi giorni[17]. E, peraltro sulla traccia dei suoi libri precedenti[18] ed in linea con il “Manifesto di Davos”[19].
L’operazione ideologica che è tentata in questi testi è di enorme ambizione, non va sottovalutata. Si tratta di raccogliere la sfida posta dall’evidente, e non nascosto, fallimento dell’economia neoliberale, eccessivamente concentrata sul breve termine, sull’arricchimento come rapina invece che come giusto effetto della creazione di valore, sull’esaltazione delle parti peggiori dell’uomo, sulla distruzione della natura entro e fuori di esso, per rovesciarlo in un successo dei medesimi attori. Una vera e propria rifondazione ideologica dall’alto che è espressamente proposta dalle élite per le élite di fronte al baratro del conflitto, della perdita di egemonia e di controllo del mondo e, forse, della rivoluzione (come arriva a dire, cercando di stimolare il senso di sopravvivenza del capitalismo). Si tratta di un tentativo di riaggregazione di classe, anche oltre e sopra le differenze e le fratture geopolitiche in via di allargamento. Una riaggregazione necessaria e decisiva per ricandidarsi alla gestione da una posizione più salda.
Ci vuole una straordinaria dose di pazienza per ascoltarli, ma ci proveremo.
Il libro è strutturato in alcuni “Macro reset” e “Micro reset”.
I “Macro Reset”, ovvero la risistemazione (che è contemporaneamente un azzeramento, ed una rimessa a posto) sono insieme economici, sociali, geopolitici, ambientali e tecnologici. Al contempo i “Micro Reset” riguardano alcune tendenze come l’accelerazione della digitalizzazione, la maggiore resilienza delle catene logistiche mondiali, le modifiche nel governo e un nuovo capitalismo orientato agli interessi (“Stakeholders capitalism”). Ma riguardano anche una rimessa a posto del sistema produttivo nel suo insieme, con un drastico processo di de-densificazione e cambiamenti importanti nell’ambiente. Infine, per gli autori ci sarà un cambiamento antropologico, niente di meno che la “ridefinizione dell’umanità”, e delle scelte morali. Cosa che porrà in questione le definizioni della sanità mentale e del benessere stesso. In definitiva saranno da cambiare interamente le nostre priorità.
Occorre fare due precisazioni prima di procedere con la lettura: in primo luogo tutta la ricostruzione è fondata sulla teoria della complessità, organicamente contraria alla ricerca di nessi e meccanismi causali gerarchicamente ordinati (di una spiegazione comprensiva). L’effetto è di una sorta di affastellarsi orizzontale di quadri interpretativi e di fenomeni. Dichiaratamente interdipendenti, e soggetti al primato della velocità. Chi volesse cercare l’esplicazione di una qualche legge di sviluppo, o di una teleologia resterebbe quindi deluso.
La seconda precisazione, necessaria per non leggere in modo sbagliato le previsioni contenute nel libro, è che sono, appunto, previsioni, non prescrizioni. Molte delle conseguenze più gravi e distruttive dell’evento pandemico sono semplicemente descritte, gli autori non necessariamente le giudicano positive o le desiderano. In effetti non si impegnano a farci comprendere fino a che punto le giudichino in ultima analisi positive (anche se in alcuni casi si può supporre sia così, perché ogni descrizione è sempre almeno in parte normativa), perché il loro punto è strettamente un altro: che fare?
Tenendo conto di ciò la crisi del Covid-19 è essenzialmente interpretata come un potentissimo acceleratore di dinamiche disparate, se pure intrecciate. Se si parte dalla risistemazione tecnologica l’enfasi passa sull’accelerazione delle trasformazioni digitali ed i cambiamenti nei consumi e nella regolazione. Invece, se si muove dall’azzeramento (certo creativo) economico il Covid-19 introduce elementi di incertezza (tra i quali la scelta tra salvare le vite e l’economia) nel nesso tra crescita economica e occupazione, politiche monetarie e fiscali, alternativa tra deflazione ed inflazione, destino del dollaro americano. Dalla risistemazione sociale si muove dall’attuale ineguaglianza verso un nuovo contratto sociale e la ripresa del “big goverment”. Sul piano geopolitico si tratta di muoversi nella crescita della rivalità tra Usa e Cina, oltre che la tendenza ad una nuova regionalizzazione. E per l’ambiente affrontare i rischi pandemici e dell’inquinamento, mettendo insieme per l’avvenire le politiche ambientali e quelle pandemiche.
Questa è la mappa del libro.
Insomma, in poco meno di 300 pagine il testo cerca di dare una sintetica immagine del mondo e del suo destino, alla portata di un weekend di un manager o politico medio. Si parte dalla qualifica di crisi senza paralleli[20] nella storia moderna attribuita alla dinamica mondiale attivata dal coronavirus, e dalla chiara enunciazione, fatta a giugno 2020, del fatto che la pandemia è intervenuta ad accelerare linee di faglia, fallimenti di cooperazione, che non torneranno mai più al loro posto. Il mondo di domani sarà quindi necessariamente e completamente diverso dal mondo di ieri. Avremo due ere, “prima del coronavirus” (BC) e “dopo il coronavirus” (AC). Quindi “The Great reset” è, con le parole degli autori, “un tentativo di identificare i cambiamenti futuri e di apportare un modesto contributo a delineare ciò che potrebbe assomigliare alla forma più desiderabile e sostenibile di questi”[21].
La proposta degli autori è di mettere a fuoco un framework concettuale semplificato che aiuti a riflettere in questa situazione di estrema tensione e disordine per creare senso in essa (“making sens of it”). L’obiettivo è dunque esplicitamente politico.
I cambiamenti sistemici che propongono di considerare drasticamente accelerati dalla crisi pandemica sono i seguenti, e tutti già in corso:
- La ritirata parziale dalla globalizzazione,
- La crescente separazione tra le economie di Usa e Cina,
- L’accelerazione dell’automazione,
- Le preoccupazioni per la crescente sorveglianza,
- Il nazionalismo e la paura per l’immigrazione,
- Il crescente potere della tecnologia.
Il punto è che queste accelerazioni potrebbero rendere possibili cose prima inconcepibili, come forme di politica monetaria (helicopter money e MMT), il cambiamento delle priorità sociali, radicali forme di tassazione e di welfare, drastici riallineamenti geopolitici. Potrebbero, anzi dovrebbero. Se non lo faranno si andrà incontro ad una fase di torbidi, di conflitti, forse di guerre e di rivoluzioni.
Vediamo meglio, però, la dimensione Macro della ‘risistemazione’.
Per cominciale viene esplicitato il framework ideologico: il mondo del XXI secolo è segnato essenzialmente dalla “interdipendenza”; prodotta dalla globalizzazione e dal progresso tecnologico essa viene definita testualmente come “reciproca dipendenza”, anzi, per essere proprio precisi, come una “dynamic of reciprocal dependence among the elements that compose a system”[22]. Dunque, il mondo è orizzontale, concettualmente attraversato da dipendenze, che, però, mettono tutti sullo stesso piano. Un “sistema” nel quale le parti non possono fare le une a meno delle altre. Quindi “iperconnesso”, “concatenato”. Insomma, nel quale sono “tutti nella stessa barca”.
Potrebbe sembrare ovvio e non problematico (se si sceglie di non far caso a che si tratta di una nave per la tratta degli schiavi, e la maggioranza dei passeggeri sono in catene).
È chiaro che se si segue pacificamente l’immagine della “stessa barca” e dei felici passeggeri di 193 “cabine separate”, allora i rischi diventano tutti interconnessi, sistemici, orizzontali, interdipendenti.
È in questa specifica mossa, posta all’avvio del libro e inavvertita quasi, che si radica l’invito di affidamento all’ordine capitalista, ed ai suoi migliori campioni, le grandi imprese raccolte a Davos (ed altrove). Come proponeva Quinto Aurelio Simmaco, ideologo nella stessa linea di Rutilio Namaziano e negli stessi anni, mentre l’impero si apprestava a cadere ed era pieno di ‘barbari’, i nobili clarissimi, membri dell’Ordo, erano “la luce del mondo” e per questo autorizzati a gestire il governo degli altri uomini. Non era dal potere politico (in quel caso imperiale, nel nostro nazionale) che derivava la virtus, ma dall’investitura dei pari e dalla tradizione stessa. Ma, qui l’astuzia della costruzione ideologica: non si tratta di avere solo il diritto a governare (come vuole in fondo il neoliberismo rozzo nel quale siamo stati fino ad ora) ma anche il dovere. L’intero discorso di Schwab si muove su questa antica traccia: la virtus è un dono che non può restare infruttuoso. Nessun disimpegno è ammesso, c’è una identità profonda tra il bene collettivo e la responsabilità e capacità del sistema delle grandi imprese di conseguirlo. Lo “Stakeholders capitalism”, appunto. Saranno loro, direttamente, a doversi fare carico dei beni pubblici da distribuire, dei giochi da organizzare, della coesione, del controllo, e della pace.
Dicevamo che siamo su una nave negriera che, purtuttavia, viene descritta dai nostri come se fosse un transatlantico nel quale (è vero) ci sono cabine di prima e seconda classe, e talvolta dei disordini, ma anche una salda guida che deve solo riconoscersi come tale per far andare tutto al suo posto. Riconoscersi come guida significa, necessariamente, accoglierne la responsabilità. Ciò è tutto.
O meglio lo sarebbe, se non fosse che in questo modo della situazione nel quale il mondo è si perde l’essenza: si perdono le catene da rompere.
In fondo tutto dipende da pochi slittamenti di senso, da alcuni incroci nei quali si forma la coesione di senso del nuovo paradigma.
Uno di questi è che la dipendenza[23] di tanta parte del mondo da poca altra, e dei molti dai pochi, è riletta dagli autori come “interdipendenza”. A tal fine viene fatto uso del cosiddetto pensiero della complessità. Per Schwab ed il suo coautore il primo fattore di analisi è dunque prendere atto che la “interdipendenza” orizzontale invalida il pensiero a “silo”, capace solo di dividere i singoli problemi in compartimenti specialistici. Nell’esempio che fa il libro, i disastri infettivi hanno effetti diretti sui “fallimenti della governance globale”, sull’instabilità sociale, la disoccupazione, le crisi fiscali e le migrazioni involontarie. E ognuna di queste aree di crisi ne influenza altre nelle dimensioni economiche, societarie, geopolitiche, ambientali e tecnologiche.
Il secondo fattore caratterizzante è la “velocità”. La cui prima espressione è il 52% della popolazione mondiale oggi collegata ad internet, il miliardo e mezzo di smartphone, i 22 miliardi di device connessi con la Iot. Tutto, perciò, si muove più velocemente, incluse le infezioni, e come risultato tutti operiamo ormai in una “real-time society”, in una nuova cultura dell’immediatezza, ossessionata dalla velocità, che apparentemente fornisce tutto just-in-time. Una vera e propria dittatura dell’urgenza. Che (anche qui fa capolino l’ideologia) rende ancora più evidente lo scollamento con la lentezza della decisionalità pubblica. Secondo decisivo slittamento e cerniera.
Il terzo è la “complessità”. Ovvero “ciò che non capiamo o troviamo difficile capire”, ovvero (come voleva Simon), “un insieme fatto di un gran numero di parti in interazione in modo non semplice”. Parti nelle quali non ci sono collegamenti causali visibili tra gli elementi, e che sono quindi virtualmente impossibili da predire. Un esempio è ovviamente la pandemia stessa, che è un sistema adattivo complesso composto di molte differenti componenti o frammenti di informazione (in campi che vanno dalla biologia alla psicologia). Un sistema dunque difficilissimo da prevedere e nel quale ogni parte si interconnette con tutte le altre secondo una logica ricorsiva e quindi oscura. Un sistema molto più grande della somma delle sue parti. Dunque, il punto fondamentale è che “la complessità crea limiti alla nostra conoscenza e comprensione delle cose” fino a che potrebbe soverchiare la capacità dei decision maker di prendere decisioni ben informate. È per questo che, in profonda continuità con l’ispirazione più profonda della ideologia neoliberale, la soluzione dei problemi non è la ripresa del potere statuale, della democrazia popolare, o del primato delle leggi sugli interessi individuali, ma lo “Stakeholders capitalism”. Ovvero è la rinnovata centralità, ma nella responsabilità, dell’ordine delle imprese (grandi), rilette come primarie fornitrici di beni pubblici. Beni pubblici che queste possono creare e distribuire in fondo proprio perché decentrate, complesse, informate (ognuna dei suoi specifici stakeholders).
Abbiamo quindi una lettura della situazione informata all’obiettivo di essere semplice e desiderabile, che sceglie di leggere il mondo sotto la triplice lente di una interdipendenza orizzontale, della velocità e della complessità. Che lo pensa decentrato, libero, imperniato su un ordine di “boni” e di “clarissimi”, chiamati al governo dalla loro stessa “virtù”.
Ma vediamo ora quale è la situazione, quali i “Reset” (ristrutturazioni, messe al loro posto, azzeramenti).
I reset economici
Ci sono quindi le ristrutturazioni, risistemazioni, messe a posto e azzeramenti (tutto insieme) di tipo economico.
Secondo alcune analisi recenti gli effetti sulla crescita economica si faranno sentire per almeno 40 anni, e non andrà come le altre volte (nelle quali alla fine l’elevata mortalità cambiò i rapporti di forza in favore dei lavoratori), perché la tecnologia cambierà il mix. Inoltre, come ha detto Jin Qi (un importante scienziato cinese), questa epidemia tenderà a restare e coesistere per lungo tempo, diventando stagionale. Né ha veramente senso il presunto trade-off tra salute ed economia: comunque se non si risolve il problema le persone non torneranno alla loro vita precedente, dunque “il governo deve fare tutto quel che è necessario, spendendo tutto quel che costa negli interessi della nostra vita e salute collettiva per riportare l’economia alla sostenibilità”[24].
Nello svolgere la ricostruzione dei massivi impatti dell’epidemia (al giugno 2020), gli autori finiscono per concentrarsi anche sull’impatto della tecnologia sul mondo del lavoro. È chiaro che l’automazione è distruttiva, ma nel tempo incrementa la produttività e la ricchezza, che alla fine provoca una maggiore domanda di beni e servizi e quindi nuovi tipi di lavori che riassorbono la disoccupazione. È corretto, scrivono (si tratta in fondo della cara vecchia Legge di Say), ma in quanto tempo? Inoltre, la pandemia stessa, e le sue misure di distanziamento sociale, ha accelerato enormemente questi processi di distruzione. Processi che, di necessità, provocheranno centinaia di migliaia, o milioni, di lavori persi. L’analisi degli autori è sotto questo profilo ormai standard[25]: man mano che i consumatori preferiscono servizi automatizzati ai loro omologhi faccia-a-faccia quel che accadrà ai call center si estenderà. Il processo di automazione, che non è mai lineare, subirà un salto in corrispondenza della recessione economica, e sempre più imprese messe alle strette cercheranno di aumentare la produttività (intesa come rendimento per unità di capitale investito), sostituendo i lavoratori a bassa competenza con l’automazione. I lavoratori a bassa competenza impegnati in lavori di routine (nella manifattura come nei servizi, la ristorazione o la logistica) ne saranno dunque colpiti. Il mercato del lavoro si polarizzerà tra pochi lavoratori ad alte competenze e salari e tutti gli altri. Nel futuro più remoto, invece, potremmo assistere a ondate di nuova occupazione in modi e forme oggi non prevedibili.
Nell’era post-pandemia la nuova normalità economica potrebbe essere quindi caratterizzata da una crescita più bassa, con declino della popolazione in molti territori e nazioni. In queste condizioni per gli autori dobbiamo cogliere l’occasione di avere una “pausa di riflessione” e introdurre modifiche istituzionali e delle scelte politiche. Come avvenne dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando fu promossa la Conferenza di Bretton Woods e si espanse in Europa il Welfare State. A questo punto l’analisi si sposta decisamente verso la dimensione utopica. Si immagina che le “nuove norme sociali” possano superare l’ossessione della mera crescita quantitativa registrata dal Pil, in favore di una crescita fondata piuttosto su fattori intangibili come il rispetto per l’ambiente, la responsabilità sociale, l’empatia e generosità. In questo contesto i nuovi driver di crescita, in grado di riattivare il sistema economico in un “inclusivo e sostenibile dinamismo”, potrebbero essere, per gli autori, la green economy (energie green, ecoturismo, economia circolare), e le varie forme di economia sociale che crei lavori nei settori dei servizi alle persone, educazione e salute.
In una sezione del libro che non sembra affatto diversa da quanto proposto, come abbiamo visto, nel recente libro di una delle figure di punta della MMT, Stephanie Kelton, “Il mito del deficit”[26], Klaus Schwab ed il suo coautore dichiarano che nella fase post-pandemica saranno necessarie “decisive, massive e rapide” politiche fiscali e monetarie. Cosa che, del resto, è avvenuta immediatamente dopo l’avvio della emergenza sia con riferimento alle politiche monetarie (acquisti di titoli da parte delle Banche Centrali), sia a quelle fiscali (supporti alle imprese ed ai cittadini, e forme senza precedenti di versamenti diretti sul conto corrente di milioni di loro). La sostenibilità a breve termine di questa enorme espansione di spesa pubblica è stata garantita dall’intervento delle Banche Centrali al fine di contenere il costo degli interessi sul debito. È stata quindi abbattuta la barriera “artificiale” tra gli interventi delle Banche Centrali e quelli fiscali, e sono emerse anche ipotesi teoriche che sistematizzano questo approccio. Tra queste gli autori citano la MMT e la pratica dell’helicopter money[27]. Del resto in condizioni di interessi vicini allo zero le normali politiche monetarie sui tassi di interesse sono disattivate, quindi non restano che gli stimoli indiretti ai deficit fiscali intenzionali. In questi semplici termini (e semplicistici a diretta ammissione) secondo gli autori la MMT direbbe che il governo centrale può spendere emettendo debito che le Banche Centrali compreranno. Il deficit sarà quindi monetizzato e il governo potrà usare le risorse come vuole, senza preoccuparsi in prima battuta della copertura fiscale delle spese.
Il rischio è però che un governo che abbia in questo modo “l’albero dei soldi magico” possa stimolare involontariamente la partenza di un’inflazione fuori di controllo. In altre parole, il QE perpetuo potrebbe esserne una causa e l’helicopter money uno dei veicoli di trasmissione. La ragione addotta è che non ci sono limiti teorici a quanto denaro una Banca Centrale può creare, solo il limite dopo il quale la reflazione diventa inflazione. Potrebbe essere una minaccia, ma non è all’agenda oggi. Per ora abbiamo la prevalenza di impulsi deflazionari, creati potentemente e strutturalmente dalla tecnologia e dal tendenziale invecchiamento (entrambi per natura deflazionari) e dall’eccezionalmente alto tasso di disoccupazione. Tutte dinamiche che il clima post-pandemico esaspererà. Quindi nei prossimi anni ci dovremmo trovare in condizioni simili a quelli del Giappone negli ultimi venti anni: debolezza strutturale della domanda, inflazione molto bassa, e interessi ultra-bassi. Condizioni nelle quali, a dire il vero, il Giappone ha reagito con efficacia per gli autori.
Un altro fattore della situazione potrebbe essere il declino della centralità del dollaro, anche esso in corso da molto tempo. Cosa che potrebbe essere accelerata dalla tendenziale insostenibilità della spesa pubblica americana (le sole medicare, medicaid e social security ammontano, senza spese militari ed altri investimenti, al 112% delle tasse federali riscosse). Del resto a breve termine non ci sono alternative, non la moneta cinese, fino a che non liberalizzerà i controlli sui capitali, non l’euro, che è sempre sotto minaccia di dissoluzione, non un paniere di monete, ancora sperimentale.

