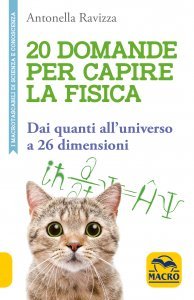L'evoluzione della fisica
di Guido Dalla Casa - 02/06/2024
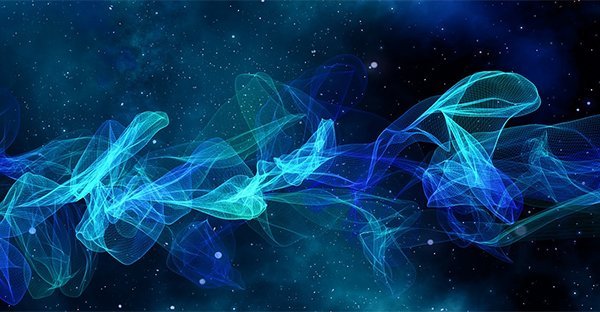
Fonte: Guido Dalla Casa
Premesse
La fisica che si studia a scuola è essenzialmente basata sulla meccanica, almeno inizialmente: infatti si comincia con il movimento, i tre principi della dinamica o leggi di Newton: inerzia, proporzionalità fra forza e accelerazione, principio di azione e reazione. Questa fisica, nata nel mondo moderno due o tre secoli fa, si basa su un assunto della filosofia di Cartesio, cioè che l’osservatore e l’osservato siano ben distinti e quindi che esista un mondo reale e oggettivo al di là di ogni osservazione. In altre parole, mente e materia sono ben distinte, la materia è “esistente in sé”.
Inoltre, l’astrazione newtoniana del “punto materiale” presuppone che il mondo osservato sia in definitiva riconducibile a tanti punti, o particelle piccolissime.
La teoria atomica ha rafforzato questa visione, persistente anche quando si sono ipotizzate particelle sempre più piccole (protoni, neutroni, elettroni, e così via).
Anche la termodinamica, con la teoria meccanica del calore, si è mantenuta entro questa visione del mondo, battezzata dal fisico Fritjof Capra (1939-vivente): paradigma cartesiano-newtoniano.
I primi tre decenni del Novecento
Dal 1900 al 1930, più o meno, sono avvenuti, partendo soprattutto dalla fisica, rivolgimenti del pensiero scientifico conseguenti a formulazioni teoriche, sempre confermate, che hanno falsificato il paradigma cartesiano-newtoniano: tale modifica è tuttora in corso e procede molto lentamente. Sono i famosi Trent’anni che sconvolsero la fisica, titolo di un felice libro divulgativo di George Gamow. L’inizio è dato dalla relatività speciale o ristretta, enunciata da Einstein nel 1905, quando la fisica meccanicista o classica ha cominciato a vacillare: spazio e tempo hanno perduto ogni connotazione assoluta, materia ed energia sono diventate la stessa cosa.
Due paradigmi
Ogni scienziato inserisce in genere le sue conoscenze in quello che oggi viene chiamato il suo paradigma, seguendo una felice definizione del filosofo Thomas Kuhn (La struttura delle rivoluzioni scientifiche, 1978).
Mettiamo quindi in evidenza i due paradigmi maggiormente presenti nella scienza, seguendo la definizione di Fritjof Capra (Il punto di svolta, 1984): il paradigma cartesiano-newtoniano e il paradigma sistemico-olistico.
Come sopra accennato, con il paradigma cartesiano-newtoniano tutte le conoscenze vengono inquadrate nell’ipotesi che l’universale sia una gigantesca macchina: in questo paradigma, di fatto tuttora in auge, ci illudiamo di separare i singoli problemi e risolverli uno per uno in modo lineare. Invece, nel paradigma sistemico-olistico non possiamo suddividere in parti l’universale: è necessario prendere in considerazione tutti gli effetti e le retroazioni fra i vari elementi e considerare il grado di complessità di un sistema, che non è divisibile in processi esaminabili singolarmente.
Nel primo periodo dall’inizio della fisica, il paradigma principale vigente può essere considerato il determinismo di Laplace (primi decenni dell’Ottocento). Non c’è alcuna libertà, per nessuno, anche se una parte della scienza dell’epoca accettava un pizzico di libertà, ma attribuito soltanto “all’uomo”. Questa idea, allora “di maggioranza” fra i fisici, ha percorso tutto l’Ottocento e, da qualche parte fra il popolo e una fetta della scienza “ufficiale”, persiste ancora oggi.
Nell’Ottocento si era ormai affermata la teoria atomica, dove gli atomi erano considerati indivisibili. Ma negli ultimi anni del secolo la scoperta della radioattività rese gli atomi non più indivisibili. Nel modello di Bohr-Rutherford, insegnato ancora oggi, l’atomo appariva come un sistema solare in miniatura, era fatto di “palline” ancora più piccole, ma la concezione di fondo restava ancora quella: esistevano le particelle elementari e il vuoto, attraverso il quale si propagavano le forze che le tenevano unite, o le distanziavano (molto simile a quella del filosofo greco Democrito).
Con la relatività speciale, enunciata da Einstein nel 1905, spazio e tempo perdono ogni connotazione assoluta, materia ed energia diventano la stessa cosa. Tutto questo nasce dal fatto che la velocità della luce non è un infinito, è molto grande ma è un numero finito, e anche un invariante. L’unificazione energia-materia è stata accettata, ma ci sono voluti “gli episodi” di Hiroshima e Nagasaki per convincere le masse. Con la relatività generale (1916), la gravità newtoniana diventa la curvatura dello spaziotempo, ma la divisione cartesiana fra mente e materia resta totale. C’è un osservatore che guarda un mondo materiale realmente esistente. In altre parole, il paradigma non è più newtoniano, ma ancora ben saldamente cartesiano.
Vagamente, c’è ancora la sensazione che la Natura si comporta come una macchina e non ha alcun genere di “aspetto mentale”, e che la mente sia un prodotto del cervello.
Mente e materia
La rivoluzione più grande è iniziata nel 1927, proprio nella Fisica, quando lo scienziato tedesco Werner Heisenberg, dopo alcune meditazioni nell’isola di Helgoland, sul mare del Nord, ha enunciato il suo principio di indeterminazione, che inizialmente riguardava la posizione e la quantità di moto di una particella: il principio è stato poi confermato da Niels Bohr (con l’interpretazione di Copenhagen) e da tutti gli esperimenti successivi. Non si tratta di limiti dei nostri strumenti o dei nostri sensi, ma della natura del mondo. Posizione e velocità non sono determinabili esattamente entrambe. Se vogliamo definirne una, l’altra è completamente indeterminata, e tutto questo proviene da considerazioni matematiche: se il prodotto delle due indeterminazioni è sempre maggiore di una costante mai nulla (che contiene come fattore la costante di Planck), quando una delle due tende a zero (precisione assoluta), l’altra tende all’infinito (indeterminazione totale). Solo l’osservazione, cioè un fenomeno mentale, “sceglie” la grandezza da conoscere. Ovunque, anche in tutte le grandezze delle espressioni matematiche, vi è un contenuto mentale. Il principio si applica ad altre coppie di grandezze, fra cui la coppia energia-tempo: se fissiamo un istante esatto, cioé vogliamo che l’indeterminazione del tempo sia nulla, la “particella” presenta una massa-energia totalmente indeterminata, il che significa che non è niente di definibile in alcun modo. Non si può separare il fenomeno dall’osservazione, non esiste alcuna realtà oggettiva, esistono solo relazioni, anche mentali.
Il dualismo mente-materia è scomparso: non si possono separare.
Queste “particelle” sono anche onde, l’Universale è fatto di vibrazioni e di frequenze.
Vuoto e pieno
L’indeterminazione applicata al binomio massa-tempo (o energia-tempo) portò a formulare il concetto di vuoto quantistico: non esiste alcuna particella né entità stabile, c’è solo una specie di vacuità creativa. Il dualismo vuoto-pieno è scomparso: “A” e “non-A” possono coesistere. Non esiste alcun “mattone fondamentale” della materia. Se si assume un istante preciso (indeterminazione del tempo nulla), la cosiddetta particella non ha alcuna massa-energia definibile in alcun modo: l’indeterminazione della massa tende all’infinito. Quindi viene messo in dubbio anche il significato della parola “esistere”. Il cosiddetto “vuoto” è “pieno” di miriadi di particelle che nascono e muoiono in continuazione, vivendo meno del tempo massimo loro concesso. Tutto si riconduce al vuoto quantistico, cioè a una danza di energie che continuamente nascono nell’Essere e svaniscono nel Nulla.
Il fisico austriaco Erwin Schroedinger era arrivato alle stesse conclusioni di Heisenberg, riuscendo a formulare l’equazione che porta il suo nome e che descrive l’andamento nel tempo di una probabilità. Ha inoltre enunciato il cosiddetto paradosso del gatto di Schroedinger: nel suo scatolone, il gatto è nella condizione di vivo/morto in quella ora fra la rottura/non rottura della fiala di cianuro e l’apertura dello scatolone da parte dell’”osservatore”.
Tertium datur: qualcosa può anche esistere/non esistere contemporaneamente. Tutto si risolve nel vuoto quantistico, che è vuoto/pieno, una Vacuità creativa: così se ne va la visione atomistica di Democrito e dell’Occidente. Possiamo prendere a prestito energia dal Vuoto, pur di restituirla entro il brevissimo tempo che ci è concesso.
Complessità e non-località
Nella seconda metà del Novecento lo studio dei sistemi portò a formulare le idee di sistema complesso e di essere collettivo. Un sistema che abbia un certo grado di complessità si evolve in modo da divenire completamente imprevedibile, anche in linea di principio: infatti si trova ben presto in qualche biforcazione-instabilità, o entra in uno stato caotico. La sua evoluzione non è prevedibile neanche in termini probabilistici. Nei punti di biforcazione il sistema sceglie di prendere una o un’altra via, in modo non determinabile da nessuna legge inerente al mondo energetico-materiale. Gli scienziati meccanicisti dicono che la via viene presa “a caso”, ma non sappiamo cosa questo significhi, né abbiamo alcun motivo per dire che si tratta di una scelta solo se il sistema in esame è il cervello umano. In altre parole, nei sistemi complessi si ha l’emergenza di fenomeni mentali.
In alcune espressioni matematiche della fisica quantistica si trova al denominatore una differenza di frequenze, quindi, se le due frequenze sono quasi-uguali, la frazione tende all’infinito, indipendentemente dalla distanza, che può essere grandissima: ne nascono fenomeni non-locali. Forse le vibrazioni e le frequenze sono più importanti delle forze abituali della fisica “ottocentesca”, le distanze non contano…
E l’entanglement? Le entità che sono state in contatto anche una sola volta, resteranno collegate a qualunque distanza verranno a trovarsi…e istantaneamente, a una velocità che tende all’infinito.
Conclusioni
La fisica di Newton persiste nelle scuole ma è superata su un piano “sottile” o filosofico. Di questo gli studenti non vengono neppure avvertiti, almeno inizialmente. Infatti quella fisica è utile su un piano pratico-applicativo, perché il mondo macroscopico segue ancora, in gran parte, “quella” fisica, e al sistema interessa formare qualcuno che impara a “fare”, ad essere un tecnico, non qualcuno che “pensa”.
In realtà, se – come abbiamo visto - non si può “spezzettare” nulla, e neppure fare “riduzioni al semplice”, né considerare le variabili come indipendenti, dato che le retroazioni sono numerosissime e intercollegate, riesce molto difficile in pratica trattare qualunque problema. Bisognerà comunque semplificare qualcosa, ma ogni sistema deve essere considerato come un sottosistema di quello totale, in realtà indivisibile. Comunque, sappiamo che nei sistemi complessi esiste sempre un limite temporale oltre il quale non è possibile fare alcuna previsione, neanche in linea teorica. Questo significa che, da un certo punto in poi, il sistema prende una via completamente imprevedibile sulla base dell’andamento precedente: in altre parole, si manifesta una scelta. Gli scienziati-filosofi materialisti-meccanicisti-cartesiani se la cavano attribuendo al caso l’andamento dopo la biforcazione, ma la parola caso è un’etichetta messa a tutto ciò che non sappiamo (o all’aspetto mentale?).
Qualche citazione
Qualunque cosa io dica, Vi prego di interpretarla come una domanda. (Niels Bohr)
L’unica legge è che non c’è nessuna legge. (John Archibald Wheeler)
In contrasto con la concezione meccanicistica cartesiana del mondo, la visione del mondo che emerge dalla fisica moderna può essere caratterizzata con parole come organica, olistica ed ecologica. Essa potrebbe essere designata anche come una visione sistemica, nel senso della teoria generale dei sistemi. L’universo non è visto più come una macchina composta da una moltitudine di oggetti, ma deve essere raffigurato come un tutto indivisibile, dinamico, le cui parti sono essenzialmente interconnesse e possono essere intese solo come strutture di un processo cosmico. (Fritjof Capra)
Oggi c’è una concordanza di vedute molto vasta – che tra i fisici raggiunge quasi l’unanimità – sul fatto che la corrente delle conoscenze si sta dirigendo verso una realtà non meccanica: l’Universo comincia ad assomigliare ad un grande Pensiero piuttosto che a una grande Macchina. (Arthur S. Eddington e James Jeans)
Il problema è la visione del mondo meccanicistica che, malgrado tutto, risulta purtroppo ancora imperante. Dalla nuova Fisica non emerge una visione del mondo come costituito da oggetti separati che interagiscono urtandosi più o meno forte, ma una visione del mondo, invece, che scopre come grazie alla “sintonia” e all’interrelazione, alla cooperazione, si possano “evocare”, quasi magicamente, correlazioni inusitate, potenzialità finora inimmaginabili. (Roberto Germano)