L’incantesimo del linguaggio
di Pier Paolo Dal Monte - 13/10/2020
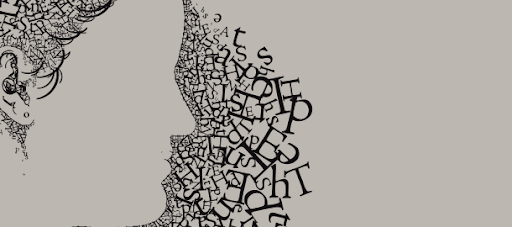
Fonte: Frontiere
L’uomo si comporta come se fosse lui il creatore e il padrone del linguaggio, mentre è questo, invece, che rimane signore dell’uomo.
Martin Heidegger
Mi sembra talvolta che niente sia così sporco come le parole esse sono ricoperte dalla bava disseccata di cento generazioni di mentitori professionisti.
René Daumal
Il linguaggio è un modo di organizzare il mondo secondo simboli sonori e grafici che vengono variamente combinati, secondo codici condivisi. La parola, la rappresentazione simbolica per eccellenza, è stata, la più importante “invenzione” dell’essere umano, come ben comprese Galileo:
Ma sopra tutte le invenzioni stupende, quale eminenza di mente fu quella di colui che si immaginò di trovar modo di comunicare i suoi più reconditi pensieri a qualsivoglia altra persona, benché distante per lunghissimo intervallo di luogo e di tempo? Parlare con quelli che sono nelle Indie, parlare a quelli che non sono ancora nati, nè saranno se non di qua a mille e diecimila anni? E con quale facilità? Con i vari accozzamenti di venti caratterizzi su una carta? Sia questo il sigillo di tutte le ammirande invenzioni umane¹.
Siccome quest’”invenzione” è una componente fondamentale del nostro “sistema” cognitivo, è impossibile, per noi esseri umani, immaginare un mondo senza parole, nomi, discorsi. È, pertanto, parimenti impossibile immaginarne l’origine. La nostra conoscenza del mondo è mediata da “parole”, la più parte dei nostri pensieri è costituita da “parole”: la nostra mente è costantemente indaffarata in un incessante soliloquio interiore; con le parole “raccogliamo” e cataloghiamo il mondo visibile e invisibile nella nostra mente.
Secondo Ernst Cassirer:
Prima di poter iniziare il lavoro intellettuale consistente nel concepire e nell’intendere i fenomeni, deve già essere iniziato e progredito fino a un certo punto il lavoro del denominare. Poiché questo è il lavoro che trasforma propriamente il mondo delle impressioni sensibili in un mondo spirituale, in un mondo di rappresentazioni e significazioni. Ogni conoscenza teoretica prende il suo avvio da un mondo formato mediante il linguaggio³.
La “rappresentazione del mondo” senza il potere “formante” della parola è, per noi, semplicemente inconcepibile. Se vediamo una persona a noi nota, essa si identifica nel suo nome che, nel nostro “schedario mentale”, ne identifica l’individualità, la sua differenziazione nell’indistinta “umanità”, ne diviene un attributo “ontologico”.
I nomi sono i simboli di ciò che ci circonda e di ciò che è dentro di noi, delle cose e dei fenomeni del mondo, dei concetti e dei pensieri, degli stati d’animo e delle emozioni, delle sensazioni, delle azioni e delle relazioni.
“Simbolo” origina da, σύν-βάλλω, “gettare, colpire assieme”, da cui si evince il senso di “unire”. Il simbolo è ciò che unisce l’oggetto e il soggetto, il materiale al mentale, il significato al significante, il mondo interiore e quello esterno, una sorta di primaria e imprescindibile adequatio rei et intellectus, necessaria per rendere l’immagine del mondo rappresentabile ed “esprimibile”. La conoscenza è questa rappresentazione del mondo che, tramite il linguaggio, diventa trasmissibile e tramandabile.
I bambini sono convinti che le cose sono funzioni del loro nome. I poeti sanno quale atto profondo e solenne sia l’invenzione d’un nome per un gatto. (…). Quando una cosa si altera, vuole un nuovo nome proprio, che rifletta l’archetipo diverso che ormai la regge. (…) Le cose sono ombre dei loro nomi, i nomi le legano all’archetipo che le informa4.
Sul piano ontologico i nomi erano considerati la natura e l’origine delle cose, i loro archetipi (nomina sunt consequentia rerum): non creazione umana ma esistenti alle “origini”, fondamento della creazione, attributi della teofania come “creazione continua” e, pertanto, punto d’incontro tra la filogenesi e l’ontogenesi, ossia, al contempo, cosmopoietiche e antropopoietiche, come spiega questo passo di Henry Corbin:
Ciascun essere è una forma epifanica (mazhar, majlà) dell’Essere divino che in essa si manifesta rivestito di uno o più d’uno dei suoi Nomi. L’universo è la totalità dei Nomi con cui Egli si nomina quando noi Lo nominiamo attraverso di essi. Ciascun Nome divino manifestato è il signore dell’essere che lo manifesta (cioè il suo mazhar). Ciascun essere è la forma epifanica del suo proprio Signore, cioè non manifesta l’Essenza divina che ogni volta in maniera particolarizzata ed individualizzata con quel Nome
i Nomi divini sono essenzialmente relativi ad esseri che li nominano, e nominandoli li scoprono e li esperiscono nel loro proprio modo di essere. Per questo, i Nomi sono anche designati come Presenze (hadarat), cioè come gli stati in cui la divinità si rivela al suo fedele nella forma di questo o quello dei suoi Nomi infiniti. I Nomi divini, dunque, hanno senso o realtà piena soltanto mediante e per quegli esseri che ne sono le forme epifaniche (mazahir), cioè le forme in cui essi vengono manifestati5.
In questo processo di denominazione i nomi sono l’essenza delle cose che sorgono dalla matrice indifferenziata. Il suono primordiale è lo strumento di cui si serve il demiurgo per creare il cosmo6, il principio di tutto, «la sostanza originaria di tutte le cose»7. I testi sacri furono la testimonianza della parola trasmessa all’uomo, il “programma” della creazione8.
Narrano le scritture Indu:
Al principio Prajapati era solo, possedeva soltanto la Parola. La Parola era il secondo ente. Egli pensò: voglio pronunciare la Parola ed essa pervaderà il tutto. Allora pronunciò la Parola ed essa pervase il tutto […] e creò la Terra, Il cielo e i mondi intermedi9.
Allo stesso modo il Vangelo di Giovanni riconosce la primazia ontologica primigenia del verbo-logos:
In Principio era il verbo.
E il verbo era con Dio
E il verbo era Dio
La Parola era il fondamento stesso del Dio creatore: il primo comandamento che Mosè ricevette sul monte Sinai fu:
Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perchè il Signore non lascerà impunito chi pronuncia il suo nome invano.
Il potere creatore della Parola, la sacralità del nome, è un motivo archetipico che si ritrova reiteratamente nei racconti della creazione, perché la Parola, il logos, il Verbo, è ciò che crea il mondo ed è, al contempo, il mezzo che rende il demiurgo creatore. Dalla Parola-Logos scaturivano i racconti delle origini, i miti che narravano la storia della creazione del cosmo, del tempo primordiale scaturito dall’eternità senza tempo.
Logos deriva da λέγω (lego), “raccogliere”, “radunare”, ed è analogo al latino lego, che ha gli stessi significati11.
Questi termini riconducono alla radice IE leg-, raccogliere12. Da questo termine originano numerosi vocaboli come legio (“legione”) che indica l’adunanza dei soldati, elegans (“elegante”) che denota ciò che è ben scelto o selezionato) e intellegere, che è il “comprendere” inteso come “leggere dentro” i fenomeni, individuarne le loro intime connessioni.
Il logos, il nome, è ciò che raccoglie e seleziona i fenomeni tramite simboli o significanti e li “collega tra loro” per creare un significato, l’atto poietico per eccellenza. È l’opera che, sul piano microcosmico, dipana il caos della manifestazione in un quadro coerente per la mente, così come, su quello macrocosmico, il Demiurgo “raccoglie” il “disordine”, il Caos e lo “ordina”, creando il Cosmo 13.
Nel Poimandres la creazione scaturisce dall’incontro tra il Nous (intelletto) e il Logos14. L’intelligenza divina ordina il caos tramite il Verbo, allo stesso modo in cui l’uomo organizza il mondo nella propria mente tramite i simboli-significanti, e li dispone tramite il discorso.
Il Lògos, come abbiamo detto, è ciò che individua ontologicamente l’uomo, ne fa un individuo unico tra la folla indifferenziata: è dunque responsabile dell’antropogenesi. «L’essenza dell’uomo è la Parola»15 recita la Chandogya Upanishad16. Da questo punto procede idealmente Chuang Tzu, portando il potere cosmogonico del denominare direttamente sul piano ontogenetico nel quale l’uomo e “creatore continuo” dell’antropocosmo:
È camminando che si traccia la via, è nominandole che le cose sono17.
Il potere cosmopoietico della parola opera una sorta di “creazione ininterrotta” nel quale l’”osservatore” costruisce, momento per momento, il proprio mondo, così come la teofania crea continuamente il cosmo. La via diventa “via” solo dal momento in cui viene percorsa (materialmente o in modo “virtuale”) quell’unica via “effettiva” tra le miriadi di vie possibili.
Allo stesso modo, le “cose” visibili e invisibili, sono una congerie indistinta, un caos privo di differenziazione se non viene loro dato un nome che crea un loro “posto” nel mondo della rappresentazione, che è la rappresentazione del mondo.
Un leccio è uno dei tanti alberi indistinti nella verde indistinzione di una foresta se è privo del nome che lo distingue da altre specie. Un essere umano è indistinta massa di carne nella folla, se non conosciamo di lui ciò che ne fa un individuo, una singolarità nel nostro mondo: il nome e la forma, «Nome e forma descrivono le cose, ma primo viene il nome, perché riflette l’archetipo a cui esse appartengono»18.
Il linguaggio è, dunque, uno dei pilastri portanti dell’edificio della conoscenza e, proprio per questo, reca con sé una duplice “patologia”: una, per così dire “benigna” e l’altra, che potremmo definire “maligna” (per usare la metafora oncologica).
Per inquadrare la prima è sufficiente rendersi conto che il nome, come abbiamo poc’anzi enunciato, sottolineandone le caratteristiche “ontologiche”, siccome è simbolo, segno o significante non si identifica esattamente col significato, ovvero, se ci riferiamo al mondo fisico, nel fenomeno o nell’oggetto. La parola è sempre Maya: illusione o simulacro (idolo). Conoscere i nomi delle cose non equivale a sapere/assaporare. Come recita Lao Tze, per quanto in senso più metafisico: «Il Tao che può essere detto, non è l’eterno Tao. Il nome che può essere nominato, non è l’eterno nome»19.
Se è vero che l’uomo “raccoglie” e “raduna”, ovvero organizza il mondo nella propria mente mediante i nomi, le parole, non è altrettanto vero ch’essi ci restituiscano il “sapore” del mondo. Dimenticando questo si rischia di rimanere ammaliati da quella che abbiamo definito la forma benigna tra le patologie che la “magia del nome” reca con sé, ovvero il nominalismo: il confondere il significante col significato e l’immagine-eidolon con i fenomeni e concetti (anche se, è più facile che questi ultimi siano affetti dalla forma maligna, della quale parleremo tra poco).
Cercheremo di spiegare, in parole più semplici, questa che può sembrare un’inutile sottigliezza, e che potrebbe attirarci la critica di nominalismo nel momento stesso nel quale critichiamo quest’attitudine epistemica. [Il fatto è che il nominalismo complica sempre queste questioni: conoscere i “Nomi di Dio” non significa “assaporare” i misteri della teofania].
Troppo spesso, il nostro modo di “spiegare” il mondo si limita alla semplice rappresentazione verbale dei fenomeni20 che scambia la “spiegazione” con la denominazione.
Viene dato un nome a qualunque cosa e, quindi, si crede di conoscere qualunque cosa. Siamo informati che un certo elemento si chiama Manganese, che ha un numero atomico di 25, che significa che è il venticinquesimo elemento sulla tavola periodica. Oppure siamo a conoscenza che l’animale che chiamiamo “elefante”, viene definito secondo tassonomia “scientifica”, Elephas Maximus, se è quello indiano, oppure Loxodonta cyclotis, se è quello africano. Così come il leone e il baobab hanno, nomi scientifici che sono diversi da quelli colloquiali (Panthera leo e Adansonia digitata), e che una certa stella si chiama Alpha Centauri.
Se usiamo come esempio la pratica medica constatiamo che, nel procedimento clinico, vengono “raccolti” (léghein) i fenomeni che si manifestano sotto forma di segni e sintomi. Facendo questo estrapoliamo dal nostro schedario mentale i nomi che li identificano, che vengono radunati (nuovamente léghein) in “costellazioni”. Questo raggruppamento individua il nome di una patologia o una sindrome. Da qui ha origine un’ulteriore sequenza di nomi che definiamo “percorso diagnostico e terapeutico” che, il più delle volte, trascura l’individualità del paziente.
Se quest’opera di classificazione è necessaria per fornire un orientamento nel multiforme universo semeiotico e clinico, l’effetto collaterale di quest’attitudine è dato dal fatto che la conoscenza (specifica, in questo caso) tende ad assumere un aspetto alquanto nominalistico che trascura quella che, sotto la scorta di Michael Polanyi, abbiamo definito “conoscenza personale” (Personal Knowledge)21 che, sola, può rendere davvero conto del “sapore” dei fenomeni e degli oggetti. Se non comprendiamo questa distinzione, non riusciamo ad “immergerci” nella realtà dei fenomeni concepita secondo il “sensus communis” che, ad esempio, è il significato autentico del termine cum patire. Pertanto rinunciamo alla possibilità di “assaporare” aspetti della realtà che sfuggono alla classificazione descritta.
Se si trascurano questi aspetti, la conoscenza assume un aspetto prettamente nominalistico: diviene una sorta di “percorso obbligato” nel quale le percezioni e i dati dell’esperienza vengono dotati di un nome e immediatamente situati in una sorta di «classificatore mentale», che elabora i «dati» di ciò che abbiamo percepito in modo da interpretarli mediante la congerie di nozioni delle quali siamo stati ingozzati (e tanto peggio per i fatti).
Come rileva Jacques Ellul:
Siamo sempre più abituati all’idea che ciò che consideriamo reale (addirittura sensibile) è solo la posizione su una griglia culturale di un reale. Tutto ciò che conosciamo è l’effetto di un apprendimento culturale che ci fa vedere e capire certe cose, senza alcuna oggettività. […] Quando scopro che il legno che tocco è fatto di vuoto e atomi che si muovono a velocità inaudita, quando scopro che tutto l’ambiente solido che mi circonda è in realtà minacciato dall’antimateria, che massa ed energia sono interscambiabili, mi inserisco in un universo astratto, il reale che mi circonda non è più significativo né certo, e colgo come unica certezza il numero, indipendente e autonomo22.
Tuttavia, ripetiamo, il problema della natura nominalistica della conoscenza è il meno grave tra i due che abbiamo elencato. Dal momento che, sin qui, si è cercato di sottolineare l’importanza “ontologica” del “nome”, sarà facile comprendere la natura di quest’ultimo. Nonostante siano ormai trascorsi alcuni secoli dall’impostazione razionalistico-positivista della conoscenza, l’uomo rimane un essere scarsamente riducibile all’esclusivo “principio di ragione”23. Siamo esseri alla continua ricerca di significato per i nostri significanti:
il bisogno di ragione consiste nel rendere conto di tutto ciò che sia o che sia avvenuto. A ciò sospinge non la sete di conoscenza — il bisogno può manifestarsi in connessione con fenomeni ben noti e del tutto familiari — ma la ricerca di significato. Dare un nome alle cose, la pura e semplice creazione di parole, è il modo dell’uomo di far proprio e, per dir così, disalienare un mondo al quale, dopo tutto, ognuno di noi è nato come nuovo venuto e come straniero24.
La definizione di “bisogno di ragione” potrebbe, a tutta prima, sembrare in contraddizione con quanto da noi affermato circa la nostra natura di esseri emotivi. Per chiarire quest’apparente incongruenza è bene fare qualche passo indietro e scrutare un po’ più in profondità i significati del termine “ragione” che, ai tempi nostri, è divenuto un significante assai vago.
L’uomo è stato definito “animal rationale”: l’”animale provvisto di ragione”, trasposizione imprecisa dell’aristotelico zòon lògon èchon25 ovvero, l’essere vivente provvisto di logos (traducendo quindi il termine lògos con “ragione”). Questo chiasma semantico tra “ragione” e “discorso” (usando il termine logos in questo senso) può essere foriero di notevole confusione. Siccome stiamo parlando di linguaggio dovremmo far nostra la massima confuciana che recita: «Nell’uso delle parole il saggio non è mai improprio»26 e fare qualche precisazione in questo senso.
“Ragione” è termine che traduce il latino “ratio”, che significava “calcolo”, computo”. Questo potrebbe farci pensare che il significato possa coincidere puntualmente con quello del sintagma “pensiero calcolante” (così stigmatizzato da Heidegger che vi contrapponeva il concetto di “pensiero meditante”)27.
In realtà le cose sono un po’ più complicate. Se seguiamo il Benveniste28 scopriamo che il termine descriveva l’operazione di calcolo secondo il modo di contare degli antichi, che consisteva nel mettere uno sopra l’altro i “pezzi” da contare fino ad ottenere la summa (la “cifra che sta sopra”). L’espressione usata dai romani per le operazioni di calcolo era “rationem ducere”, che suggerisce l’atto di “radunare” gli oggetti per contarli, e quindi “connetterli” secondo “calcolo” o “proporzione”. Dal punto di vista cognitivo quest’operazione non è solo un banale “contare” ma uno stabilire una vera e propria connessione tra gli oggetti comparandoli. Quest’aspetto riporta all’etimologia del termine “ratio” che, attraverso il paricipio passato “ratus”, deriva dal verbo “reor” (“pensare”)29.
Quest’ultimo è riconducibile alla radice indoeuropea ar-1. re-* che è comune anche al greco àrarìsko (ἀραρίσκω: “aggiustare”, “adattare”, “congiungere”, “connettere”), nonché ai lemmi latini ars (arte), ritus (rito) e artus (arto)30. Secondo il Pokorny, dalla stessa radice deriverebbe anche ἀρετή (àreté: virtù, eccellenza, coraggio)31. In sanscrito troviamo il termine ṛta (l’ordo degli scolastici), ovvero “L’ordine che regola l’andamento dell’universo, i movimenti degli astri, la periodicità delle stagioni, i rapporti tra uomini, e tra uomini e dei”32, ovvero l’ordine immanente al “creato”: ciò che connette in una disposizione “coerente” il disordine del caos operando la “creazione continua” del cosmo. Secondo i Veda ṛta è ciò che mantiene il funzionamento corretto dell’ordine naturale, morale e sociale.
Tenendo conto di queste premesse che speriamo contribuiscano a chiarire i significati del termine “ragione”, possiamo tornare ai rapporti di quest’ultimo col linguaggio/discorso.
La ragione è la “facoltà” (o “strumento”) caratteristica del “discorso”, nel quale le “ragioni” rispettive si confrontano (“soppesano”) vicendevolmente nel processo dia-logico o dia-lettico (da qui le locuzioni “esporre le proprie ragioni” e “aver ragione”). Questo processo (ci si perdoni il paragone dozzinale) è comparabile alle trattative che avvengono al mercato, nelle quali si confrontano diverse stime di valore (ratio) delle merci, per giungere ad una sintesi che si manifesta nella transazione effettiva tra le due parti (compratore e venditore).
Tuttavia, se pensiamo al secondo significato del termine, quello che potremo definire “esoterico”, ossia il “mettere in connessione”, vediamo che è ad esso che allude la frase di Hannah Arendt che abbiamo riportato: il “bisogno di ragione” è il bisogno di credere che il mondo che ci troviamo ad abitare, pensare o immaginare sia informato di significato e coerenza. Come il logos è lo “strumento” che compie l’operazione di “raccolta” delle componenti sparse del cosmo (fisico e concettuale), così la ratio le connette, ed entrambi creano il microcosmo della mente (individuale o collettivo). Logos e ratio creano l’immagine del mondo: sia lo “schema del mondo esterno”33 che, in un dominio più “affettivo/emozionale”, lo “schema delle convinzioni” (o web of belief)34.
Il bisogno di coerenza è caratteristica dell’uomo come ”animale emotivo”: l’”animal rationale” è quella caratteristica umana che, tramite la facoltà di “connettere”, costruisce questa coerenza (e il significato). Abbiamo bisogno di inserire in un quadro, privo di contraddizioni troppo marcate, i fenomeni, le cose, i concetti perché abbiamo bisogno che “il mondo ci sia”, che possa avere una forma che riconosciamo, altrimenti sarebbe un “non mondo”. Un mondo privo di significato non sarebbe cosmo ma caos35.
Queste caratteristiche di significato e coerenza sono componenti fondamentali della nostra visione del mondo, ovvero il mondo come ci appare che, dal nostro punto di osservazione, è il mondo tout court. Ogni nuovo dato, ogni nuovo concetto che entra in questo quadro, necessita di un’operazione di adattamento che, a volte, costringe a modificare profondamente il nostro schema cognitivo, sia dal punto di vista individuale (ontogenesi) che da quello collettivo (filogenesi).
Talora quest’operazione costituisce una discontinuità così forte, col quadro epistemico esistente sino a quel momento, da metterne in discussione l’intera trama. Potremmo definire questo fenomeno “effetto Galileo”, che Thomas Kuhn considerò la base delle “rivoluzioni scientifiche”. È un evento drammatico, sia per la filogenesi che per l’ontogenesi della conoscenza, a tal punto che alcuni autori (hanno parlato di “tragedia del cambiamento”36.
E qui arriviamo alla seconda patologia tra quelle che reca con sé la “magia del nome”.
Il mondo di relazione della polis è sempre stato un mondo di parole. In più, oggi, viviamo in una società nella quale la vita delle persone è sempre più deprivata di esperienza diretta che è quella che ci restituisce, in maniera più immediata, il “sapore” delle cose del mondo, che costituisce lo “strato” primario dello “schema del mondo esterno”, ma anche buona parte dello “schema delle convinzioni”37. La brace è indiscutibilmente bruciante. Basta una singola esperienza di questo fenomeno affinchè questa “verità di fatto” nello “schema del mondo esterno” si imprima indelebilmente nello “schema delle convinzioni” (diventando una “verità di ragione”)38.
Date le circostanze nelle quali si svolge la nostra vita, i due “schemi” citati sono costituiti sempre meno dall’esperienza diretta e sempre più da descrizioni o narrazioni di seconda mano, nelle quali il nostro strumento epistemico diventa la fede in ciò che è affermato secondo sensus communis ovvero secondo la visione del mondo comunemente accettata o propalata.
Il potere “poietico” delle parole («è nominandole che le cose sono») ci rende soggetti al loro incantesimo, la loro forza scaturisce molto più dal loro potere di evocare che da quello di definire. Come ben sapeva Aristotele: «Ora i suoni che sono della voce sono simboli delle affezioni dell’anima»39. Questo evocare, non suscita soltanto un moto soggettivo dell’anima, possiede la proprietà di agire su ciò che è nominato, quasi avesse il potere di influenzarlo o mutarlo. I reati di vilipendio e diffamazione, presenti in tutti i codici penale, sono la dimostrazione di quest’asserzione. Il vilipendio è un atto secondo il quale il potere poietico del nome agisce “ontologicamente” sull’individuo compromettendone la nomèa, l’immagine. L’archetipo che definisce l’individuo così come si ritiene essere e come gli altri lo vedono. «Sinonimo di “nome” è “onore”: ciò che lega l’uomo, l’incantesimo sociale che gli è stato fatto»40.
Inoltre, come ancora scriveva Aristotele:
È come nell’anima talvolta vi è un pensiero indipendente dall’essere vero o falso […] così è anche nella voce […] I nomi, di per sé, non sono né veri né falsi. Infatti, la parola ircocervo significa qualcosa, ma non è né vero né falso se non si aggiunge “esiste” o “non esiste”41.
Nell’esempio aristotelico si evidenzia che il termine “ircocervo” significa qualcosa, ed è il significato che infonde “realtà”, nel nostro pensiero, a ciò che è nominato, realtà che non è dipendente dalla mera esistenza fattuale. Il mondo che ci circonda de facto è il risultato della sovrapposizione della cultura alla natura, è opera dell’attività creatrice dell’essere umano collettivo, sia che questa si manifesti in opere, oggetti, discorsi o istituzioni che, per ciò stesso, “prendono il loro posto nel mondo”42.
Nell’esempio aristotelico si evidenzia che il termine “ircocervo” significa qualcosa, ed è il significato che infonde “realtà”, nel nostro pensiero, a ciò che è nominato, realtà che non è dipendente dalla mera esistenza fattuale. Il mondo che ci circonda de facto è il risultato della sovrapposizione della cultura alla natura, è opera dell’attività creatrice dell’essere umano collettivo, sia che questa si manifesti in opere, oggetti, discorsi o istituzioni che, per ciò stesso, “prendono il loro posto nel mondo”.
Come abbiamo detto, la pòlis si regge sul lògos/discorso; e la moderna polis ha assunto la forma di quel “villaggio globale” nel quale ci troviamo a vivere, la cui struttura è costituita da una trama di parole dal significato vago o distorto. È impresa assai ardua trovare un significato effettivo (o solo minimamente condiviso) nei “grandi concetti”, nelle “parole alate” che informano la trama di questo mondo, nei quali il potere di evocare eclissa quello di significare. Termini come “giustizia”, “democrazia”, “popolo”, ma anche “etica” o “scienza”, sono invocazioni nei riti collettivi attorno ai quali si organizza il consesso umano: segni e significanti che trovano un significato solo attraverso la griglia di una ragione informata dal sensus communis (“senza la guida di un altro”) e, solo a quel punto, manifestano il loro aspetto razionale nel potere delle istituzioni.. Sono le connessioni operate dalla ratio che creano un significato, ordinano il caos dei fenomeni e dei concetti infondendo realtà al mondo.
Le parole che danno forma al sensus communis del moderno “villaggio globale” non devono avere significato ma imporre il proprio incantesimo, che agisce in maniera quasi spontanea per il fatto stesso che fanno il loro ingresso nel mondo e sono riverberate da milioni di voci, e, in tal modo, creano l’immagine di questo mondo, che è il mondo che riteniamo ex-sistere. Non sono più un “dominio descrittivo”43 , ma un fondamento magico della realtà (il fatto di essere soltanto narrata, non la rende meno reale di un dato di fatto). Questo è il reale potere dei mezzi di comunicazione, essi sono il moderno sensus communis, nel quale la percezione è sostituita dalla narrazione che ci fa credere reale ciò che viene semplicemente pronunciato. E questo è il motivo per il quale la propaganda è così efficace: essa crea un codice di significanti coerente all’interno della propria narrazione.
Ciò che è creato entra indelebilmente nel nostro schema del mondo. E dubitare di questo schema comporta il dubitare della coerenza e del significato del mondo, e questo fa crollare la nostra fede in esso, la “fede nel mondo giusto”44.
[2] Pier Paolo Dal Monte, L’incertezza epistemica nella pratica medica. Dall’etica all’organizzazione, Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione, 4/2015.
[3] Ernst Cassirer, Linguaggio e mito, SE, Milano 2006, p.44
[4] Elemire Zolla, Verità segrete esposte in evidenza, Marsilio, Venezia 1990, p.63
[5] Henry Corbin, L’immaginazione creatrice. Le radici del sufismo, Editori Laterza, Bari 2005, p. 106
[6] Andrè Padoux, Vāc, the concept of the word in selected Hindu Tantras, State University of New York Press, Albany 1990.
[7] Marius Schneider, Il significato della musica, SE, Milano 2007, p.17
[8] Cfr. Barbara A. Holdrege, Veda and Torah. : Transcending the Textuality of Scripture, State University of New York Press, Albany 1996.
[9] Willem Caland W. (Editor), Pancavimsa Brahmana. Calcutta: Asian society of Bengal 1931, XX, 14.2.
[10] La Sacra Bibbia della CEI, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2008, Esodo, 20,7.
[11] Cfr. R. Beekes, L. Beek , Etymological Dictionary Of Greek. Brill, Leiden-Boston 2010,
P. Chantraine, Dictionnaire ètimologique de la langue greque, Édition Klincksieck, Paris 1968, M. De Vaan, Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages, Bril,l Leiden-Boston 2008.
[12] Cfr. Julius Pokorny , Proto-Indo-European Etymological Dictionary. A Revised Edition of Julius Pokorny’s Indogermanisches Etymologisches Worterbuch. Indo-European Language Revival Association 2007.
[13] Ricordiamo: da κοσμέω, “ordinare, “adornare”.
[14] Corpus Hermeticum, Bompiani, Milano 2005, p.79
[15] Chandogya Upanishad,with the commentary of S’ankaracarya, Poona Oriental Book Agency, Poona 1942, I,3
[16] uang-zi (Chuang tzu), Adelphi, Milano 1982, p.24.
[17] Zuang-zi, cit.
[18] Elemire Zolla, op. cit, p.63
[19] Tao Tè Ching, in Testi Taoisti, UTET, Torino 1977.
[20] Non stiamo parlando qui di linguaggio matematico, che è un superiore livello di simbolismo, rispetto al linguaggio verbale.
[21] Cfr. Michael Polanyi, Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy,: Routledge and Kegan Paul, London, UK 2005.
[22] Jacques Ellul, Il sistema tecnico, Jaca Book, Milano 2009, p.132
[23] E qui ci sarebbe tanto da dire su quella paccottiglia epistemica che prende il nome di rational choice (Gary Becker).
[24] Hannah Arendt, La vita della mente, Il Mulino, Bologna, 1987, p. 155
[25] Cfr. Aristotele, Politica.
[26] I dialoghi di Confucio, UTET, Torino 2001 (Dialogo 305)
[27] Cfr. Martin Heidegger, L’abbandono, Il Nuovo Melangolo, Genova 2004
[28] Emile Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, Einaudi, Torino 2002, p.114
[29] Deriva dal verbo “reor”: “pensare” tramite il participio passato “ratus” nel quale si conserva il significato originario di “contare” (pro rata pars: secondo proporzione stabilita). Cfr. Michiel De Vaan, Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages. Brill, Leiden-Boston 2008
[30] Cfr. E. Benveniste, op. cit; R. Beekes, op.cit; P. Chantraine, op. cit.; J. Pokorny,op.cit
[31] Cfr. J. Pokorny, op. cit.
[32] Cfr. E. Benveniste, Op. cit. p.359
[33] Cfr. H. Stapp, ,Mind, Matter And Quantum Mechanics. Springer-Verlag, Berlin 2009
[34] Cfr. W.V.O Quine, From a logical point of view, Harper & Row, New York 1963. In seguito useremo queste ultime due locuzioni come sinonimi.
[35] Non stiamo parlando qui di significato teleologico, ma di coerenza secondo il processo di pensiero. Una casa distrutta da un terremoto, è priva di significato in quanto casa, anche se la sua massa si conserva. Non viene solo a mancare la sua “funzione di utilità”, ma viene a cessare “ontologicamente”, come microcosmo “disposto ordinatamente e ornato” secondo la ricerca di “coerenza” (coherere) dei suoi inquilini.
[36] S.O. Funtowicz, J.R. Ravetz,. Emergent complex systems. Futures, 26, 1994,568–582.
[37] Cfr. H. Stapp, op.cit.
[38] Qui, in maniera peraltro coerente con la nostra descrizione di ragione, stiriamo un po’ il concetto leibniziano di “verità di fatto” e “verità di ragione” che Leibniz descriveva in questo senso: « Vi sono anche due tipi di verità, quelle di ragione e quelle di fatto. Le verità di ragione sono necessario e il loro opposto impossibile, e quelle di fatto sono contingenti e il loro opposto possibile. Quando una verità è necessaria si può trovare la ragione attraverso l’analisi, risolvendola in idee e in verità più semplici, sino a che non si è giunti alle primitive».
G.W. Leibniz, La Monadologia, Bari, 1975, p. 128.
[39] Cfr. Aristotele, De interpretazione, 16 a, 4.
[40] E. Zolla, op.cit., p.63
[41] Aristotele, op. cit., 16 a, 10-17.
[42] H. Corbin, op.cit., p. 158
[43] Perché, in realtà, non descrivono nulla in modo preciso.
[44] Cfr. Melvin J. Lerner, The Belief in a Just World: A Fundamental Delusion, , Plenum Press, new York 1980

