La tolleranza non è una virtù
di Roberto Pecchioli - 11/02/2023
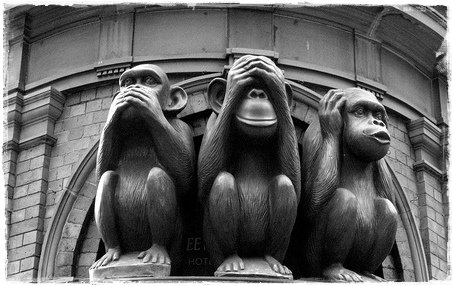
Fonte: EreticaMente
Non sono tollerante: lo rivendico come una medaglia al valore. Ascoltare o leggere la parola tolleranza mi provoca collera per l’ipocrisia di cui si ammanta. Del resto, sono un maschio bianco eterosessuale, cioè normale, con l’aggravante di essere credente cattolico, rigorosamente ateo delle nuove religioni postmoderne: gender, abortismo diritto universale, scientismo, matrimonio omo, cambio climatico, mercato misura di tutte le cose. Non sono liberale, liberista e libertario, come è obbligatorio nella società inclusiva e tollerante. Credo moltissimo nella libertà, poco nella democrazia – eccetto quella partecipativa – e per nulla nell’uguaglianza, se non nella forma dell’isonomia, l’uguaglianza davanti alla legge.
Insomma, sono un pessimo soggetto. Fortunatamente la genia a cui appartengo è destinata a rapida estinzione. In attesa della vittoria finale della luminosa tolleranza universale, faccio parte di un’esigua tribù di esuli in patria, stranieri al proprio tempo, estranei alle magnifiche sorti e progressive. Non tollero questo tempo invertito e se nessuno mi ascolta, pazienza. Anche la voce di chi predicava nel deserto fu solitaria, eppure annunciava l’avvento di chi avrebbe cambiato il mondo. E non era tollerante l’uomo di Nazareth, che scacciò i mercanti dal tempio ed invocò una macina appesa al collo e gli abissi del mare per “chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me”.
La tolleranza non è una virtù, ma la conseguenza del relativismo morale. Unica verità è l’assenza di verità: la tolleranza si volge nel suo contrario, pensiero debole che diventa fortissimo di negazione in negazione. Nei nostri tempi ultimi, poi, corre la cosiddetta cultura della cancellazione, il cui nucleo è negare tutto ciò che è stato perché frutto di idee malsane propalate per millenni da esseri orribili, i maschi bianchi eterosessuali. Perché, dicono i risvegliati – a cui farebbe bene un sonno ristoratore – dovremmo credere a una civiltà formata da “storie di maschi bianchi morti”? Non lo tollero.
Come posso essere tollerante davanti a un medico che ha ucciso nove anziani malati, condannato dalla “giustizia” italiana a una pena mite per agito in nome di “valori morali”? Togliere la vita diventa merito etico, nel mondo invertito. L’indisponibilità della vita sembrava la più elevata delle conquiste. Non è più così: può essere soppressa agevolmente l’esistenza di non nati, malati, anziani, sofferenti, depressi, nel civilissimo Canada perfino di poveri. Civilissimo? Ma mi faccia il piacere, avrebbe riso il principe Antonio De Curtis in arte Totò. Nel paese di Justin Trudeau, campione del progressismo made in Davos, una giovane disabile si è vista offrire l’eutanasia per aver chiesto di rimuovere le barriere architettoniche davanti casa. Se tolleriamo senza battere ciglio una società così, buon pro ci faccia, sino a quando la campana suonerà proprio per noi.
Alle nuove generazioni – sparute poiché l’aborto è un’esigente religione secolare – viene offerta un’educazione obbligatoria alla fluidità esistenziale, una vita da nomadi precari, mascherata da edulcorate menzogne, tipo diventare imprenditori di se stessi. Il pacchetto è completato dalla possibilità di cambiare sesso anche se minorenni e dalla negazione della realtà biologica in nome di una fumosa, provvisoria, autopercezione. Devo tollerarlo, considerarlo un progresso? Me lo impediscono la coscienza e il principio di realtà: continuo a credere ai miei occhi, non all’insopportabile grancassa della propaganda.
Strana condizione della tollerante modernità: istruita, sapiente, ma pronta a credere ogni bestialità senza dubitare, purché sia una novità con il marchio del sistema. Nel tempo che ha rinunciato ad ogni appartenenza e filiazione, pretendono che io accetti la discriminazione a favore di minoranze assortite con il bollino di vittime storiche, per la colpa di essere erede di una specifica civiltà e di avere alcune caratteristiche filogenetiche assegnate dalla natura. Sempre quelle: maschio, bianco, eterosessuale. La Gran Bretagna, potenza imperiale in disarmo – morale e materiale – è in difficoltà a reclutare piloti militari in quanto non li vuole maschi e bianchi. Il ministero della difesa – di un governo conservatore! – esige che i top gun siano soprattutto donne o di colore.
L’imperativo categorico è applaudire e tollerare, cioè sopportare tacendo. Poiché tutto diventa farsa, Massimo Gramellini, eminente gazzettiere mainstream, ha scritto un pistolotto in cui confessa le colpe storiche della categoria a cui anch’egli involontariamente appartiene (maschio, bianco, presumiamo cisgenere, ossia etero) e applaude la scelta britannica. Gramellini è prossimo alla vecchiaia (non tollero l’espressione terza età!) titolare indubbiamente di una cospicua pensione. Dia l’esempio: lasci le sue ben retribuite collaborazioni a una donna di colore o a un/una trans, pretendendo che le/gli venga corrisposta la stessa cifra da lui percepita.
Sciocchezze evidenti devono essere tollerate perché diffuse da organismi considerati autorevoli. La definizione di donna del dizionario di Cambridge è la seguente: persona adulta che vive e si identifica come femmina anche se alla nascita è stata definita di sesso diverso. Un insulto alla verità e all’evidenza. Strana distorsione del principio di Berkeley: essere è percepirsi, non essere percepiti.
La tolleranza – oltreché finta virtù dei conformisti – gli ignavi di Dante – è l’atteggiamento ideale liberal in quanto nega il conflitto. Il sistema vuole che crediamo di far parte di un’umanità pacificata nel consumo, nell’indifferenza morale, nell’equivalenza di ogni scelta o condotta, nel divieto cauteloso di esprimere giudizi e lottare per delle convinzioni. La stessa democrazia è una procedura per legalizzare il conflitto tra principi e interessi contrastanti, un ragionevole sistema di regole, la cornice per espellere la violenza bruta. Per il greco Eraclito, “pòlemos è padre di tutte le cose, di tutti i re; e gli uni disvela come dèi e gli altri come uomini, gli uni fa schiavi gli altri liberi.” Il tollerante moderno è lo schiavo di una sconcertante proibizione del conflitto, che sfocia nell’abolizione del pensiero, per natura giudicante.
Lo sfondo della tolleranza è un’immensa contraddizione, poiché il modello vigente è la guerra di tutti contro tutti per il profitto e l’interesse individuale, in nome dei quali è tollerata, addirittura prescritta, l’ingiustizia sociale e la sopraffazione. Un’ ulteriore contraddizione è nota come paradosso della tolleranza. Proviene dal pensiero di Karl Popper, teorico della “società aperta”, che deve però essere sbarrata ai suoi nemici: “una collettività caratterizzata da tolleranza indiscriminata è inevitabilmente destinata ad essere stravolta e poi dominata dagli intolleranti presenti al suo interno.” Vero, ma la soluzione consiste nello stabilire l’intolleranza nei confronti dell’intolleranza come condizione per la preservazione della società aperta. Il principio è assai sfuggente: l’idea di una società aperta ma chiusa ai suoi nemici (definiti intolleranti) è pericolosa in quanto consente di escludere ogni idea, valore, credenza, principio alternativo su base arbitraria. Chi stabilisce il tasso di tolleranza? E la tolleranza, assurta a valore assoluto, in che cosa consiste, concretamente? La prassi progressista tende a escludere perché intolleranti tutti coloro che non condividono il suo modello sociale.
La tolleranza è la virtù per eccellenza al tempo del politicamente corretto. Ne serve davvero tanta, unita alla pazienza di Giobbe, per accettare, ovvero tollerare tutte le cose che non piacciono, l’atteggiamento teorico e pratico di chi acconsente senza eccepire a comportamenti difformi o contrastanti con i suoi principî, esigenze, desideri. Questa è l’accezione originaria della parola. Il cambio di significato è un capolavoro della correttezza politica, che obbliga alla tolleranza come equivalenza. Tollerante è chi non giudica, lascia fare, lascia correre, ossia non distingue nelle condotte, nelle idee, nei fatti, il bene e il male. Un certo grado di tolleranza è indispensabile, segno di equilibrio. Non si può tuttavia tollerare – ovvero accettare – l’intollerabile, per paura, quieto vivere, conformismo. Intimare tolleranza significa avvolgere in una nuvola rosa di buoni sentimenti generici e liquidi la negazione a definire, affrontare e sconfiggere il male.
Per Aristotele, tolleranza e apatia sono le ultime virtù di una società morente. Tolleriamo per debolezza, incapacità di affermare i nostri principi. Chi si ribella allo stato di cose che considera ingiusto è chiamato intollerante. Un cortocircuito che blocca, inibisce e lascia campo libero all’ingiustizia, alla prepotenza, alla legge del più forte. Dopo la cosiddetta “gloriosa rivoluzione “inglese di fine XVII secolo, John Locke, primo teorico del liberalismo mercantile, scrisse un Trattato sulla Tolleranza, aulico panegirico che rivendicava con forza la libertà religiosa. Peccato che escludesse atei e cattolici.
La tolleranza postmoderna è un rifiuto di responsabilità, una neutralità disarmata e programmatica. Il bene e il male non sono equivalenti e non ci si può astenere dal giudizio di valore. In più, il concetto non sfugge alla retorica di pompose banalità vuote di significato. Una è la dichiarazione dell’Unesco: “la tolleranza è la chiave di volta dei diritti umani, del pluralismo, della democrazia e dello Stato di diritto. “. Non manca nulla, tranne il significato. Parole vuote, buone per tutti gli usi.
Il filosofo spagnolo Jorge Freire è esplicito: la gente si tollera come si tollerano i fastidi e gli acciacchi. E la tolleranza, eretta a valore morale, non è altro che una modalità per evitare il conflitto. Nella vita come dal medico, tollerare assomiglia a ingerire un farmaco senza reazioni avverse; inghiottire una pozione o una persona, turandosi il naso se necessario. La retorica sulla tolleranza tende a considerarla un atteggiamento aperto, che apprezza le differenze tra persone e gruppi come fonte di ricchezza, piuttosto che di problemi. Al contrario, il concetto presuppone un giudizio di disapprovazione verso ciò che è tollerato, giudicato in varia misura negativo, dannoso, scorretto o spiacevole. Senza questa condizione, non si può parlare di tolleranza, che non è sopportare ciò su cui non possiamo intervenire, ma permettere ciò che potremmo cambiare, proibire o cercare di impedire. Questa è la premessa di una corretta definizione di tolleranza, mentre è adesso comunemente intesa come l’atteggiamento permissivo che lascia le cose come stanno, buone o cattive che siano. Che cosa c’è di buono nel permettere ciò che ci sembra male anziché impedirlo? Solo rispondendo a questa domanda possiamo decidere se la tolleranza ha un valore morale, se è una virtù o un comodo espediente per eludere i problemi. Per evitare la reazione a qualcosa di negativo, occorre una ragione forte, quindi un vero atteggiamento tollerante implica l’individuazione delle ragioni per cui è sbagliato l’oggetto della tolleranza, ma anche dei motivi per cui decidiamo di non intervenire. Senza questa riflessione, non c’è alcuna virtù.
L’elogio della tolleranza non può essere indiscriminato, pregiudiziale. L’ espressione “tolleranza zero” riconosce che in taluni casi non può esservi indulgenza. E’ l’ammissione che esistono cose che non dovrebbero essere consentite o che lo sono per ragioni sbagliate. La tolleranza, infine, non è prova di atteggiamento aperto o curioso, poiché chi tollera si astiene dal giudizio, il contrario del pensiero critico, oppure mette in pratica ciò che scrisse il poeta inglese Samuel T. Coleridge: ho visto dimostrare una grande intolleranza per difendere la tolleranza.

