La verità è e resta la questione ineludibile e decisiva
di Francesco Lamendola - 14/01/2021
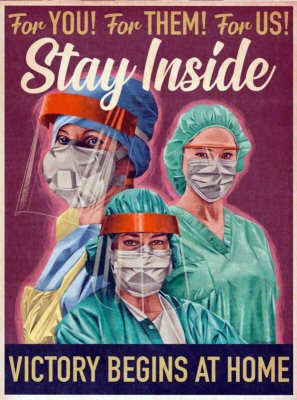
Fonte: Accademia nuova Italia
Il mondo moderno, la cosiddetta cultura moderna e, purtroppo, anche la filosofia moderna, sono il mondo, la cultura e la filosofia della chiacchiera, della dòxa, dell’opinione, non dell’epistéme, della certezza e perciò della conoscenza certa e sicura. La grande vittima della civiltà moderna, se civiltà si può chiamare la distruzione di ogni tradizione, di ogni principio gerarchico ed ogni trascendenza, è stata prima di ogni cosa l’alétheia, la verità. Si usa dire che la prima vittima della guerra è la verità, nel senso che la guerra richiede che ciascuna delle parti combattenti costruisca una narrazione degli eventi che risponde ai fini della propaganda, il che significa automaticamente sacrificare, in parte o del tutto, e non casualmente ma intenzionalmente e sistematicamente, i diritti della verità. Ebbene, la stessa cosa si può dire per la civiltà moderna, che è il frutto di una guerra permanente dell’uomo contro se stesso, dell’uomo contro Dio e di una classe contro l’altra. Non ci si lasci ingannare dal carattere apparentemente pacifico e dalle declamazioni retoriche degli intellettuali moderni: fin dall’inizio il loro scopo è stato quello di condurre a fondo, ossia fino alla distruzione del loro nemico, la triplice guerra di cui abbiamo detto. Si prenda in mano un qualsiasi volume, si legga una qualsiasi voce della Encyclopédie, il testo fondativo della visione moderna del mondo, opera della massoneria illuminista, ovvero dell’illuminismo massonico (le due cose sono inseparabili): non vi si troverà, se non in apparenza, un’esposizione oggettiva dei fatti, ma una narrazione estremamente partigiana e faziosa, profondamente intollerante a dispetto dello sbandierato principio di tolleranza. Vi si troverà invece un livore, un astio, un odio patologico per il passato, per la storia, per la tradizione, per lo spirito, per tutto ciò che non è di natura materiale, né è spiegabile e dimostrabile scientificamente, e per tutto ciò che non è immanente e non si presta alla costruzione di quel Mondo Nuovo che già filosofi come Francis Bacon avevano immaginato, e che scienziati come Galilei avevano auspicato (si pensi alla sua formula di rifare ‘e cervelli), il mondo della Fratellanza Universale e dell’umanesimo col grembiulino. È penoso e indigesto leggere voci come quelle dedicate alla religione, a ciò che è spirituale o soprannaturale: vi si trova una totale incomprensione, una totale ignoranza, un totale rifiuto, atteggiamenti che hanno messo radici e fatto scuola, visto che ancora oggi il tipico intellettuale progressista è del tipo di Piergiorgio Odifreddi, il quale pare uscito, pari, pari, dallo stampino della Encyclopédie.
Ora, se si vuole uscire dalla palude malsana della modernità; se si vuole riconquistare una vita a misura d’uomo; se si vogliono affilare le armi con le quali difendersi dalle continue aggressioni provenienti dal potere, sempre più spietato e sempre più intenzionato a derubare gli uomini non solo delle cose materiali, ma anche dei beni spirituali e della loro stessa anima; in breve, se si vuole conservare il proprio statuto ontologico di esseri umani e non rassegnarsi a regredire ad una condizione sub-antropologica, è assolutamente indispensabile recuperare la nozione della verità e la fiducia di poterla ragionevolmente riconoscere, almeno nei termini e nei limiti che sono connaturati alla condizione di creatura. Ora, filosoficamente parlando, il concetto della verità si avvicina molto al realismo gnoseologico, anche se non coincide del tutto con esso, nel senso che bisogna essere sempre consapevoli del fatto che la verità è un’approssimazione, non un possesso pieno e incondizionato, e che le cose potrebbero non essere come sembrano, anche se è sbagliato presupporre che non lo siano affatto, mai o quasi mai, secondo la suggestiva immagine del diavoletto di Cartesio, il quale si divertirebbe ad ingannarci, facendoci cadere nella trappola delle false apparenze. E questo per la buona ragione che l’esperienza, maestra tra di vita, ci mostra che la totale discordanza fra la cosa come appare e la cosa come è, rappresenta piuttosto l’eccezione che la regola. La regola è che se vediamo del fumo, deve esserci un fuoco; se l’acqua ghiaccia nelle pozzanghere, deve aver fatto molto freddo; e se una persona lavora seriamente e realisticamente, riesce a portare a termine il compito che si era prefissato.
Certo, a questo punto sarebbe necessario fare una distinzione: perché dire la cosa come è implica una certa quale forzatura logica, anche se, nella sfera della vita pratica, del tutto naturale e necessaria: la cosa in se stessa, infatti, a rigore non la conosce nessuno, se non Dio, che ne è il creatore, e nella cui mente era presente ancor prima che il mondo cominciasse ad esistere. Perciò quando diciamo, sulla scia della buona filosofia classica, di Aristotele e di san Tommaso d’Aquino - buona filosofia che, guarda caso, è d’impianto solidamente realistico, ossia ammette che le cose sono stanzialmente quello che concretamente noi esperiamo e quello che per noi è intelligibile -, quando diciamo che di regola vi è una concordanza fra la cosa come è e la cosa come appare, non intendiamo altro che questo: che la cosa appare così come a noi appare, non già tuttavia in maniera arbitraria e soggettivistica (o addirittura solipsistica), bensì secondo delle costanti che sono:
a) logiche: essenzialmente il principio di non contraddizione;
b) fisiche: l’alta improbabilità teorica, ossia l’impossibilità pratica, che le cose smentiscano la propria natura;
c) storiche: la coscienza che le cose mutano nel tempo, perché la realtà è movimento, il che non toglie che siano sempre le stesse, anche se assumono apparenze mutevoli nell’arco degli anni, dei secoli o dei millenni.
Tra i filosofi contemporanei, quello che si è maggiormente impegnato per ristabilire il concetto della verità nei termini del realismo (aristotelico e tomistico) è stato monsignor Antonio Livi (Prato, 25 agosto 1938-Roma, 2 aprile 2020), già decano della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Lateranense, la cui scomparsa, durante il lockdown per il Covid-19, è passata pressoché inosservata, al di fuori della cerchia ristretta dei suoi amici ed estimatori, così come inosservata era stata la persecuzione da lui subita, in silenzio e con estrema dignità, ad opera del clero bergogliano, a causa delle sue nette e coraggiose prese di posizione contro la sistematica adulterazione della dottrina cattolica. Basti dire che i giornali che per anni e anni erano stati fieri di ospitare i suoi splendidi articoli, come L’Avvenire, lo avevano completamente scaricato, ospitando al contrario degli articoli nei quali veniva attaccato in maniera vergognosa; che gli era stato tolto lo stipendio di presbitero; che i suoi lavori accademici venivano ignorati o rifiutati dalla librerie cattoliche, le stesse che tanto volentieri espongo i libri di eretici come Enzo Bianchi o di teologi insignificanti come Vito Mancuso; mentre il mondo delle scuole superiori e delle università ha sostanzialmente ignorato il suo eccellente manuale in tre volumi La filosofia e la sua storia, sul quale migliaia di giovani avrebbero potuto entrare nel mondo degli studi filosofici da una prospettiva autenticamente cristiana e al tempo stesso apprendere l’amore per il pensiero razionale attraverso una metodologia speculativa rigorosa, chiara, impeccabile. Ma lasciando da parte, in questa sede, il triste capitolo del silenzio voluto, con il quale si è voluto punire il sacerdote coerente e il filosofo indisponibile ai compromessi, proprio come era già accaduto all’ottimo Cornelio Fabro, dobbiamo ricordare che ad Antonio Livi spetta il vanto, in questi tempi di relativismo e pensiero debole, d’aver rimesso in auge il fondamento stesso del “pensare forte”, vale a dire quella che è conosciuta come la filosofia del senso comune, della quale è stato uno dei massimi esponenti (come il suo maestro Étienne Gilson).
Secondo Livi, ciascuno possiede delle certezze intime, naturali e incontestabili, anteriormente a qualsiasi ragionamento; certezze che derivano dall’esperienza immediata e che, essendo universali e necessarie, sono a loro volta la base di ogni ulteriore conoscenza. Le certezze fondamentali sono:
a) l’esistenza del mondo, formato da un insieme di enti in movimento;
b) l’esistenza dell’io, che si coglie nell’atto di conoscere il mondo (cosa ben diversa dal cogito cartesiano, che è il risultato di una riflessione ad exludendum e non di un dato immediato della coscienza);
c) la certezza di altri soggetti, riconosciuti come simili a sé;
d) la certezza di una legge morale che regola i rapporti di libertà e responsabilità fra l’io e gli altri;
e) la certezza di Dio quale causa prima e causa finale di tutto ciò che esiste.
Ciascuna di queste certezze costituisce, di per sé; un’evidenza: non il risultato di una speculazione, ma un dato della coscienza che si pone come fondamento di ogni altro dato di realtà e di ogni atto del pensare, del volere e dell’agire. Monsignor Livi ha dedicato gran parte della sua attività di ricerca all’analisi di queste evidenze ed è arrivato a dimostrare che esse, in effetti, sono il telaio sul quale si fonda e si sviluppa ogni altra conoscenza, e senza il quale nessun conoscere sarebbe possibile. Gli uomini, pertanto, se non disponessero di tali evidenze, vagherebbero a tentoni nel buio, come ciechi o ubriachi: e il dramma della civiltà moderna è appunto quello di aver dapprima posto in dubbio (il dubbio sistematico delle filosofie razionaliste, Cartesio in primis), e poi demolito e abbandonato, ogni fede nella possibilità di una conoscenza immediata e naturale, come quella descritta e studiata da Antonio Livi. Il metodo da questi utilizzato è stato quello della presupposizione e della logica aletica: possiamo considerare la conoscenza umana da qualsiasi lato, ma non riusciremo mai ad ammettere che l’uomo effettivamente conosce qualcosa, e che questo suo conoscere gli permette di agire razionalmente nel mondo, se non ammettiamo che è reso possibile da un substrato di evidenze naturali, che sono la base di partenza per tutti i movimenti ulteriori della sua mente, da quelli del bambino che arriva a toccare gli oggetti visti per la prima volta, a quelli del matematico o del filosofo che spingono i loro ragionamenti sino alle soglie del concetto d’infinito. La logica aletica, poi, ha permesso a Livi di indagare non solo la possibilità di conoscere veracemente, ma anche di stabilire in che modo una determinata affermazione deve considerarsi vera o non vera. Infatti ci sono molti casi nei quali una proposizione non è, di per se stessa, né vera né falsa, ma diviene vera o falsa a seconda del sistema olistico nel quale è inserita, e che ha a che fare con la categoria della possibilità, una tipica categoria esistenziale (che ci permette di stabilire un ponte ideale fra il pensiero di Livi, quello del suo collaboratore Cornelio Fabro e quello del filosofo più amato e studiato da Fabro stesso, Kierkegaard). Nella realtà fattuale dell’esistenza, i fatti, le cose, non si pongono come veri o falsi in senso astratto, ma acquistano verità o falsità in base a come vengono declinati nella categoria del possibile. Dal punto di vista della logica aletica, per esempio, bisogna prima stabilire se la vetta di una certa montagna, in un certo momento, è materialmente accessibile, o no; se non lo è, poniamo per un’eruzione vulcanica che ha provocato una colata di lava bollente, l’affermazione che Mario l’ha conquistata percorrendo proprio quel versante assume immediatamente un connotato di non verità. Ricordiamo che la verità di una cosa consiste nella concordanza fra il giudizio e la cosa stessa: e se è vero che i fatti si impongono alle teorie, è altrettanto vero che i fatti logicamente impossibili devono essere esclusi dal panorama della conoscenza, perché servono solo ad ingombrarlo di materiali inutili.
Citiamo dalla Enciclopedia della Matematica della Treccani, edizione 2013:
[La] logica aletica (dal greco alétheia, “verità”) particolare una logica modale, che non si limita, come la logica classica, a determinare se una proposizione è vera o falsa, ma si spinge a indagare le modalità con cui una proposizione può essere vera o falsa. Per esempio, una frase come «Marco potrebbe perdere il posto di lavoro» non rientra nei canoni della logica classica perché, contenendo un’idea di possibilità, non è definitivamente vera o falsa. Il modo in cui una proposizione è vera (NECESSARIAMENTE o POSSIBILMENTE vera) è chiamato “aletica” ed è stato oggetto di studio di logici e filosofi a partire da Aristotele. I concetti di POSSIBILITÀ e di NECESSITÀ sono formalizzati per mezzo dei cosiddetti OPERATORI ALETICI: gli operatori del POSSIBILE («è possibile che…» e del NECESSARIO («non è possibile che non…»).
In definitiva, monsignor Livi ha avuto l’immenso merito di rimettere il senso comune, inteso non come banale buon senso (che è una cosa completamente diversa) ma il senso comune della normale esistenza umana, a fondamento di ogni sistema gnoseologico. Inutile dire che la sua posizione è stata criticata tanto dai sostenitori del pensiero debole, come Gianni Vattimo, quanto dai fautori di una concezione di tipo parmenideo, come Emanuele Severino; gli uni e gli altri, da versanti opposti, hanno lanciato contro la filosofia del senso comune l’accusa di semplicismo e di non tener conto dell’effettiva complessità e problematicità del fenomeno del conoscere. Ma sono parole che abbiamo già sentito tante, troppe volte: il reale è complesso, il reale è problematico; dunque bisogna negare ogni valore di certezza al conoscere e contentarsi dell’opinione. Ma se davvero il pensiero deve ridursi ad opinione, tanto vale gettare nel cestino la filosofia, e dedicarsi a passatempi più utili.



