Perché la scienza non può essere un dogma
di Pier Paolo Dal Monte - 23/01/2019
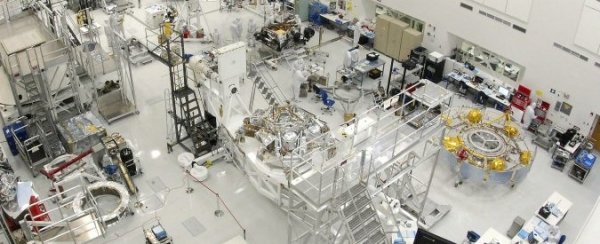
Fonte: Il Fatto Quotidiano.
Cosa potrebbe accadere se la scienza diventasse ideologia e venisse canonizzata in guisa di articolo di fede, se ogni critica fosse stigmatizzata come eresia e su di essa si avventasse il Malleus Maleficarum del potere e del suo clero opportunista? Questo mi pare l’obiettivo del malaccorto “Patto trasversale per la scienza” promosso da Burioni e firmato, tra gli altri, dai noti epistemologi Matteo Renzi e Beppe Grillo.
Come già evidenziato da Ivan Cavicchi, questo cosiddetto patto appare come un rabberciato coacervo di tautologie, tenuto assieme da una concezione di scienza ottocentesca, pedissequamente informata da un meccanicismo riduzionista. Una visione apodittica e fideistica che vorrebbe delimitare la sfera del concepibile definendo de jure, le categorie di ciò che può essere chiamato “scienza”, bandendo qualsiasi critica, anche fondata, dal consesso del lecito e, per ciò stesso, dell’esprimibile.
La scienza diventa così un potente metodo “governamentale”, perché, allo stesso modo delle notizie propalate dai mezzi di comunicazione di massa, crea l’immagine della realtà determinando l’“orizzonte del possibile”, ovvero i confini entro i quali devono essere delimitati il pensiero e la conoscenza. In questo modo si limita il campo delle possibili scelte, rendendole tutte impossibili poiché, secondo postulato, questo campo è definito da principi assoluti e ineludibili che, quindi, non possono costituire oggetto di discussione o, tanto meno, di scelta democratica.
Qui si può notare una sinistra concordanza con un’altra corbelleria che, in questi tempi, viene spacciata con una certa insistenza, e che recita: “La scienza (ma quale?) non è democratica”. Questa sonora scempiaggine è minata da una doppia fallacia:
1. la prima è logica, ovvero compara due “concetti incommensurabili”; la scienza è attinente al dominio cognitivo, mentre la democrazia – che è definizione di una modalità di governo – a quello politico. Per dirlo coi greci, la prima attiene all’epistème, la seconda alla praxis.
2. La seconda, invece, è una fallacia epistemologica: il metodo sperimentale fa sì che la scienza sia, da questo punto di vista, pienamente democratica. Essa ricusa il principium auctoritatis e si perché è basata sulle prove sperimentali. L’esperimento può essere considerato alla stregua di un “bene comune”, al quale (per statuto teorico) tutti possono attingere e concorrere, se non dal punto di vista pratico, senza meno da quello “veritativo”, visto prevede che sia possibile verificare ogni specifica asserzione “scientifica”.
La conoscenza del mondo, è data da un complesso di strumenti epistemici con i quali si studiano e apprendono (in senso etimologico) i fenomeni che, attraverso il metodo scientifico, vengono strutturati e inquadrati in sistemi di metafore utili a descrivere le “leggi generali” con le quali si costruisce la griglia del “sapere”. Questo sapere è sempre diveniente e sempre perfettibile; pertanto, almeno dal punto di vista teoretico, nulla è più lontano dal metodo scientifico dell’atteggiamento dogmatico del “manifesto” di cui sopra.
L’organizzazione della conoscenza si manifesta attraverso un processo di astrazione della realtà, che avviene mediante la descrizione del mondo con un sistema di metafore: rappresentazioni mentali dei fenomeni che, per loro natura, possono descrivere solo alcuni aspetti della realtà percepita, ossia quelli che sono considerati importanti dall’osservatore (scelta preanalitica), che fungono da paradigmi e modelli dei fenomeni naturali
Ogni modello, in quanto descrizione parziale della realtà, riflette soltanto una parte delle possibili interazioni tra l’osservatore e gli enti osservati. È doveroso ricordare che questa scelta preanalitica dipende sempre dalla visione del mondo dell’osservatore e, come tale, non è mai “neutrale” o “oggettiva” ma è sempre informata da una determinata visione del mondo. Si può quindi comprendere che “il discorso sul metodo”, per ciò che concerne la definizione di “scienza”, è un “poco” più complesso della visione semplicistica che traspare dal “manifesto” citato.
Inoltre, se parliamo delle relazioni tra politica e scienza, la prima non è – e non può essere – mera applicazione di postulati tecnici o “scientifici”. Il suo ambito non è quello dei postulati o delle “evidenze” ma quello dell’agire collettivo, che è basato sulla mediazione e il compromesso tra i vari interessi e le varie istanze in gioco. Pertanto, quando lo scopo è quello di convogliare ciò che è frutto di conoscenza scientifica nell’ambito delle scelte politiche, è necessario un accurato lavoro di negoziazione semantica per riuscire a giungere a un significato che sia condiviso da tutte le parti interessate, cioè a dire: un “perché”, che è la condizione necessaria per arrivare ad un “come”, ossia l’applicazione, nel mondo realmente esistente, di quella scienza che scaturisce dagli “esperti”.
Fatte queste premesse, ritengo quanto mai opportuna la proposta di Ivan Cavicchi di promuovere un patto sul modo di intendere la scienza. Essa diviene addirittura indispensabile, di fronte alle derive ideologiche circa il concetto di “scienza” alle quali stiamo assistendo, che sono sintomi di un pericoloso predominio del “pensiero calcolante” al quale è resistere tramite l’esercizio del “pensiero meditante” (per usare le definizioni di Heidegger).



