L'eterna lotta fra impulso di morte e capacità di amare nella riflessione di Gabriel Marcel
di Francesco Lamendola - 02/06/2008
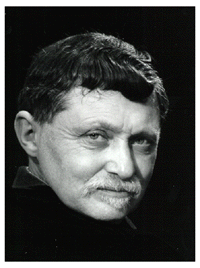 Il passare degli anni non ha rimpiccolito la figura e l'opera del filosofo Gabriel Marcel (1889-1973), massimo esponente del cosiddetto esistenzialismo cristiano del Novecento (lui, personalmente, preferiva però definirsi un "neo-socratico").
Il passare degli anni non ha rimpiccolito la figura e l'opera del filosofo Gabriel Marcel (1889-1973), massimo esponente del cosiddetto esistenzialismo cristiano del Novecento (lui, personalmente, preferiva però definirsi un "neo-socratico").
Già all'epoca in cui scriveva il suo Diario (pubblicato poi, nel 1927, con il titolo Diario metafisico), egli aveva formulato il principio ontologico fondamentale, al quale sarebbe rimasto fedele per tutta la sua vita di pensatore, scrittore e drammaturgo. La riflessione, per lui, non nasce con l'autocoscienza dell'io mediante il cogito cartesiano; la quale, infatti, mentre si pone come pensiero, pone contemporaneamente, di fronte a sé, un oggetto che non potrà mai raggiungere: donde il dualismo insuperabile di res cogitans e res extensa. Per Marcel, l'atto di nascita della riflessione è dato dalla percezione di un io anteriore al "me", ossia anteriore alla dualità di soggetto pensante e di oggetto pensato.
L'io, pertanto, non si può definire nella sua splendida solitudine, ma soltanto nella sua continua tensione verso l'essere, grazie al quale noi esistiamo. Come allude il prefisso ex della parola existere, le cose tendono verso l'essere, e il varco per realizzare un tale passaggio si trova all'interno del moto centrifugo per cui ogni fenomeno muove da sé per dirigersi verso qualche cosa che è oltre se stesso. E la meta dei fenomeni, così come la loro origine, è l'essere: che non va pensato come se fosse una cosa, o una super-cosa, ossia in senso passivo e quantitativo, bensì come la condizione e la ragion sufficiente per l'esistere degli enti.
Di conseguenza, l'essere si rivela alla coscienza ben prima che essa, mediante l'autocoscienza, produca una distinzione di soggetto e oggetto; il pensiero partecipa dell'essere in una unità originaria che è misteriosa, in quanto non oggettivabile e non verificabile. E ciò per la buona ragione che la riflessione non può avere per oggetto l'essere, dato che essa è interna all'essere. Pertanto, l'essere ha un primato nei confronti del conoscere, perché è l'essere che si afferma in me, ben prima che io affermi l'essere.
Una sintesi efficace di questo passaggio fondamentale del pensiero di Gabriel Marcel è stata tratteggiato da padre Ernesto Balducci, nella sua eccellente, ma purtroppo poco nota e poco usata nelle scuole, Storia del pensiero umano (Edizioni Cremonese, 1986, vol. 3, pp. 294-297), di cui riportiamo uno stralcio:
…La vera questione filosofica non è dunque: «Che cosa è l'essere?», ma «che cosa sono io che mi pongo questa domanda?». C'è una filosofia come indagine ( come enquête) e una filosofia come ricerca (come quête):la prima è inconcludente, perché si svia nella oggettivazione dell'essere, nel farne un tema attorno a cui indagare; solo la seconda è fedele alla verità dell'essere. Ma il suo modo di procedere non sarà il porre problemi, il mettere dinanzi a me i termini di una indagine dai quali io, come indagatore, mi tengo fuori, mentre di fato ne sono immediatamente coinvolto, se è vero che il luogo dell'essere attorno cui pongo problemi è la mia stessa esistenza. Il modo di procedere della ricerca sarà dunque la partecipazione, e cioè il riconoscimento, per via immediata, che l'essere è nel mio esistere, e fuori del mio esistere diventa una 'cosa', perde le sue prerogative. In un processo del genere, il problema trabocca dai propri dati razionalmente posti e, traboccando, investe anche me, mi si approssima come un mistero che fa appello non alla mia intelligenza, ma alla mia totalità e immediatamente ala mia libertà di consenso o di rifiuto. «In questo modo il problema si nega (o si trascende) in quanto problema e si trasforma in mistero». (…)
…La sfera dell'oggettivo è la sfera dell'avere, che si contrappone a quella dell'essere. La ragione problematica è omogenea al mondo delle cose: perché io possa avere una cosa, essa deve stare dinanzi a me, esistere indipendentemente da me. Questa reificazione può investire anche la mia interiorità, come quando dico che io ho una sofferenza, ho un desiderio: allora io scindo dal mio essere un suo momento particolare e lo tratto come oggetto.
Lo scivolamento dall'autenticità dell'essere alla inautenticità dell'avere accade alle radici stesse del processo conoscitivo, là dove la sensazione si inscrive nel sentimento della mia corporeità. Infatti, prima di essere un effetto in me prodotto da uno stimolo esterno, la sensazione è il puro fatto del sentire, al di là di tutte le possibili determinazioni. Il sentire puro è il mistero della mia partecipazione a un universo che, impressionandomi, mi crea. Ecco perché il dato centrale della metafisica è, per Marcel, il sentimento del mio corpo, l'incarnazione. Quando dico che io ho un corpo, mi sono già posto fuori dell'asse ontologico: la verità prima è che io sono il mio corpo, o meglio, io sono in quanto incarnato in questo corpo.(…)
Tra il mio corpo e me non c'è dunque né separazione né fusione e nemmeno relazione, c'è partecipazione: l'esistenzialità è la partecipazione, in quanto essa non è oggettivabile. Nel momento in cui il mio corpo è considerato come oggetto di scienza, io esulo infinitamente da esso.
Quello che si è detto del corpo, vale per l'universo intero. Come il mio corpo, nemmeno l'universo può diventare un oggetto per me, né io posso comprendere, per via di ragione, quale sia il legame che mi unisce ad esso. (…)
Ma la scissione, introdotta nell'essere dalla identificazione cartesiana tra la mia essenza e la coscienza che io ho di me, si rivela in tutta la sua ambiguità al livello delle relazioni interpersonali. Quella identificazione traccia intorno a me ujn cerchio da cui non posso più uscire, condannato a un perpetuo monologo sugli altri. Infatti, l'altro sarà sempre per me un lui, termine di una relazione in cui a decidere tutto è il fato e la misura del mio interesse. Nello stesso momento in cui tratto l'altro come oggetto, io vengo meno alla mia esistenza concreta: «più il mio interlocutore è esterno a me e più io sono, nello stesso momento e nella stessa misura, esterno a me stesso».
Solo nel dialogo fra due tu l'uomo si scopre e si afferma come persona. La vita autenticamente personale è una "con-presenza".
Il problema di Dio si pone a Marcel in questa stessa linea, come epilogo coerente della sua analisi dell'essere. Anche Dio può essere pensato come verità impersonale, e allora egli è «la più povera, la più morta delle finzioni», è il punto limite del processo di oggettivazione. Che cosa è il Dio cartesiano, se non un fabbricatore del mondo? Dio reale, invece, è personale, è il Tu assoluto. Proprio per questo non ci sono verità su Dio, anzi non c'è nemmeno il problema di Dio…
Abbiamo voluto riassumere i punti-chiave del pensiero filosofico di Gabriel Marcel, servendoci dell'aiuto di Ernesto Balducci, per evidenziare l'importanza di questo filosofo - cui più volte ci siamo riferiti in scritti precedenti (ad es., Si entra nell'Essere con un atto di fedeltà e di amore, sempre consultabile sul sto di Arianna Editrice) - come una delle non molte voci positive e delle possibili risposte alla crisi spirituale della modernità.
Proprio in ragione della comune radice esistenzialistica, potremmo definire Marcel come l'anti-Sartre. Tanto quest'ultimo ha sparso a piene mani il seme della nausea, del nulla, dell'isolamento (l'Inferno sono gli altri, diceva), quanto il primo si è sforzato di tracciare una via per uscire dalla palude e, sulle orme di Kierkegaard, ha mostrato come solo l'apertura verso l'essere, ossia - in concreto - verso il tu, possa consentirci di gettare un ponte fra noi stessi e il mondo, riempiendo di senso la nostra vita e facendoci collaboratori di una società fondata sull'amore.
Se, invece degli scritti nichilisti e disperati di Sartre e di tanti altri cattivi maestri, i giovani di una o due generazioni fa avessero letto e mediato un po' di più autori come Gabiel Marcel, oggi forse non ci troveremmo sospinti sull'ultima spiaggia, a un passo ormai dalla crisi irrimediabile e definitiva della nostra civiltà. Forse, avremmo avuto il tempo e i mezzi per elaborare delle strategie di risposta e, invece di contare i passi che ci separano dal precipizio, potremmo guardare con un certo grado di serenità e di speranza al nostro futuro e a quello dei nostri figli.
Intervistato da Vintila Horia nella sua casa del Quartiere Latino, a Parigi, a un anno di distanza dal maggio del 1968 e pochi anni prima della morte, Gabriel Marcel si era soffermato su alcuni aspetti cruciali dell'inquietudine contemporanea, esponendo con franchezza il suo punto di vista sulla necessità che i filosofi tornino a svolgere una funzione critica e chiarificatrice, sulle tendenze autodistruttive della cultura occidentale, sulla negatività del massaggio sartriano, sull'importanza di una società dell'amore e della carità.
Con un linguaggio semplice e piano, perfettamente comprensibile anche ai non specialisti, Marce, stimolato dallo scrittore romeno e autore del fortunato Dio è nato in esilio, in quella occasione aveva delineato una panoramica su alcuni dei più scottanti problemi dell'umanità di oggi e di sempre.
Magari i nostri filosofi fossero capaci di altrettanta chiarezza e di altrettanta modestia! Si pensi a un Massimo Cacciari, per fare solo un esempio: intellettuali costituzionalmente incapaci di rivolgersi a un pubblico ampio, specializzati nell'arte di rendere aggrovigliato e inestricabile anche il concetto più semplice; e talmente viziati dalla critica che, ormai, hanno scambiato l'oscurità concettuale per un attributo necessario della profondità. Essi non sarebbero più capaci, nemmeno volendolo, di rinunciare a quello stile pretenzioso e incomprensibile che tanto piace ai lettori o agli ascoltatori afflitti da una tale mancanza di autostima, da pensare che non valga la pena di prendere sul serio un filosofo che sappia farsi capire veramente.
Dunque, nel libro di Vintila Horia Viaggio ai centri della Terra (titolo originale: Viajea los centros de la Tierra, Plaza & Janés, Madrid, 1971; traduzione italiana di Luciano Arcella, Edizioni Mediterranee, Roma, 1972, pp. 17-31), Gabriel Marcel, a una serie di precise domande, rispondeva nel seguente tenore:
…In una società in cui lo sviluppo delle tecniche ci ha fatto perdere di vista la meta della civiltà a beneficio dei mezzi, il ruolo del filosofo può essere importante. Perché questa sostituzione dei fini con i mezzi è una perversione. E il ruolo del filosofi è, precisamente, la denuncia di ciò che minaccia la rettitudine e l'integrità umana (…)
L'uomo oggi è capace di atomizzare e fare sparire per sempre il luogo in cui vive da millenni, l'ambiente medesimo della vita. Non si tratta di elucubrazioni degne di un racconto fantascientifico. No. Da quando Nietzsche ha detto: «Dio è morto», è possibile che l'uomo cessi anche di esistere. E con questo tornerei ad una famosa frase di Dostojevsky, che predicava: «Se Dio non esiste, tutto è permesso». Il momento Nietzsche coincide con il trionfo delle tecniche. Si tratta di mettere a fuoco nella scala umana l'idea del suicidio, dal momento che l'uomo e tutto quel che lo concerne, ossia il nostro stesso mondo, è capace oggi di liquidare ciò che finora ci siamo abituati a venerare. La persona capace di sciogliere questo fine ultimo sarà qualcuno che ha perduto il rispetto delle ultime essenze che costituiscono la nostra ragione d'essere e la nostra speranza. La missione del filosofo consisterebbe, dunque, nell'insegnare alla gente i principi base, senza i quali l'umano è impossibile, ed anche la vita. (…)
…Un male tipicamente occidentale [è] quello di tentare di sostituire il concreto all'astratto, il che costituisce la base stessa della tecnica o della tecnologia contemporanea. In questo senso si potrebbe dire che la tecnica, ponendosi come fine, nella sua ansia di confondere i valori che essa rappresenta con dei valori eterni e di distruggere quelli veramente eterni, sarebbe una specie di erede dell'idealismo filosofico. Non voglio dire con questo che i grandi rappresentanti dell'idealismo filosofico, Platone, Kant ed Hegel, siano direttamente responsabili di tale situazione. Però tutto sembra indicare che questi geni sono stati convertiti a una religione che non fu mai loro, che si trovarono come compromessi i un'azione che in fondo essi stessi paventarono. Un esempio? Il destino dell'hegelismo che prese corpo in un regime che non ha nulla a che vedere con l'universalismo hegeliano, e che negò tutti i valori che Hegel esaltava nelle sue lezioni e nei suoi libri Come è incominciato ciò, in che momento del diciannovesimo secolo o ai principi del ventesimo, sarebbe troppo lungo da trattare. Credo, in poche parole e seguendo qui il corso della mia conversazione e del mio pensiero, che l'idealismo abbia ormai iniziato ad essere, per opera di alcuni prosecutori o discepoli di Hegel, quello che io definii "malefico" nello stesso momento in cui venne separato dalla Rivelazione e cominciò a orientarsi verso una divinizzazione dell'uomo per l'uomo. Da quella rottura germogliarono varie metafisiche che ci condussero ai totalitarismi che lei conosce e che non è male menzionare qui. Ci fu la degradazione, la corruzione dell'idealismo. Si veda la differenza tra la società concepita da Platone nella sua Repubblica e ciò che di questa hanno fatto coloro i quali hanno provocato la rottura o la separazione di cui le parlavo. Si sono create nel mondo astrazioni inumane e false mitologie, in grande o in piccolo, terribilmente pericolose e antisociali. Passiamo all'aspetto individuale, per meglio comprendere le sfumature di questo pericolo in cui tutti ci troviamo. Si giunge, ad esempio, a creare intorno a una persona un'atmosfera di "fascista". Allora tutti gli sono contro, nessuno s'interessa alle verità di quest'uomo, e finiscono per liquidarlo solo per averlo situato in un'astrazione. Lo stesso può accadere con i libri, eccetera. O al contrario arriviamo ad adorare nell'astrazione di una falsa mitologia, uomini o libri che sono ignominie umane. È evidente che seguendo un simile cammino, l'idealismo sfocia nel totalitarismo, politico, ideologico, letterario, filosofico. (…)
…C'è una maniera d'essere irresponsabile nell'ambito culturale, che porta alle peggiori conseguenze. È difficile, per esempio, pensare alle origini del totalitarismo senza considerare il ruolo che ebbero in esso gli intellettuali del ventesimo secolo. (…)
[La ribellione dei giovani è] una ribellione istintiva. E non contro l'autorità paterna, come dicono, ma contro genitori senza autorità Una degradazione dell'autorità paterna è tanto poderosa, nel senso cattivo della parola, quanto la degradazione dell'intellettuale. I giovani non possono vivere senza autorità o al di fuori di essa. È come nei fenomeni rivoluzionari: alcuni si ribellano contro lo Stato considerato come oppressore, e poi elaborano essi stessi un altro Stato più oppressore di quello distrutto. I giovani d'oggi rifuggono l'autorità paterna, non perché sia troppo dura, ma perché non viene più esercitata, e si inventano da loro stessi autorità assai più rigide e feroci all'interno delle bande di giovani in cui il capo è più duro di un padre Si tratta di una nuova organizzazione dell'autorità paterna. (…)
È il pensiero di Sartre che è stato malefico e corruttore. Non l'esistenzialismo. L'idea stessa di considerare "l'altro" come un minaccia, in Huis clos per esempio, significa portare gli uomini a combattersi perennemente. In questo senso il sartrismo ha qualcosa a che vedere con le ribellioni attuali in quanto lotta assurda tra le generazioni. "L'altro", in questo caso, sarebbero quelli di sopra o di sotto, quelli che precedono o che seguono, quelli che stanno con noi nello stesso inferno. Ma come ignorare l'amore e la carità che sta oltre quest'odio? L'«altro», per il cristianesimo, è qualcosa da amare. La società senza amore e carità non è possibile…
Parole serie, ponderate, ristoratrici. Parole che scaturiscono da una apertura e da una benevolenza che rifugge dalle orgogliose solitudini di un Io chiuso in se stesso, pago della propria ragione calcolante, inebriato dalla propria potenza e infastidito dalla presenza dell'altro, specie quando esso si presenta nelle vesti del debole, del sofferente e del bisognoso (cfr. il nostro precedente articolo Mitologia maschile della forza e psicopatia nel « Peer Gynt » di Henrik Ibsen, sempre sul sito di Arianna Editrice).
Quanti giovani (e meno giovani), oggi, vivono la propria vita in forme distruttive e disperate, perché vedono negli altri "un inferno", un ostacolo da aggirare o eliminare, al fine di affermare la propria assoluta, incondizionata libertà?
E quante volte il conformismo e il consumismo culturali, ormai dominanti a ogni livello, ci hanno fatto credere che una persona colta deve aver letto le opere di Sarte, e possibilmente anche di Sade, ma può benissimo ignorare il nome di autori come Gabriel Marcel?
Forse perché, come ammonisce Maurizio Blondet, gli Adelphi della dissoluzione sono alacremente all'opera, e tale opera consiste nel farci allontanare, quanto più possibile, da tutto ciò che costituisce motivo di speranza, di carità e di amore?
Bisognerebbe porsi, qualche volta, domande del genere, anche se sono politicamente molto, molto scorrette.
C'è forse qualcosa, qualcuno che - travestendosi con la maschera orgogliosa della ragione - ha un interesse a che trionfino le filosofie del nulla e della disperazione, e rimangano ignorate o inascoltate, invece, quelle del bene e della buona volontà?
.




