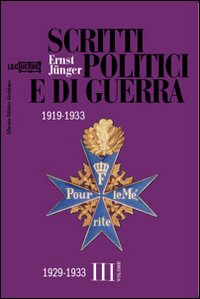Ernst Jünger. La civiltà come maschera
di Marco Iacona - 23/11/2010

Ernst Jünger nel 1916 in divisa da tenente.
La prima figura in ordine cronologico estrapolabile dai lavori giovanili di Ernst Jünger, (ma probabilmente prima anche per importanza) è quella del soldato. Il combattente nella terra di nessuno, il giovane che in solitudine affronta con invidiabile coraggio le truppe e che osserva con lungimiranza l’affermarsi della guerra dei materiali, è già in grado di assumere una propria posizione ideologica che influenzerà parte della cultura tedesca negli anni a venire. Le azioni e le idee del giovane Ernst (qualunque significato assumano) costituiscono, in questi primi anni, un esempio che verrà trasmesso per mezzo delle opere scritte, alla gioventù tedesca e in particolare alle migliaia di reduci insoddisfatti. Tuttavia nello stesso periodo, agli scritti di guerra Jünger alternerà opere di carattere più marcatamente psicologico, e ciò fino agli inizi degli anni ‘30 quando dando alle stampe Der Arbeiter, concluderà oltre un decennio di studi e riflessioni. Nei paragrafi che seguono ci occuperemo di approfondire l’attività del grande scrittore negli anni del primo dopoguerra.
A diciannove anni i sogni africani di Ernst Jünger sono arrivati dinanzi ad un bivio. «Il tempo dell’infanzia era finito» afferma il giovane Berger, alla fine dell’avventura nella Legione Straniera, si può rimanere, cominciare una vita borghese, fatta di agi, piccole e vecchie corruzioni, o si può continuare non fuggendo ma agendo, per soddisfare una incancellabile voglia di protagonismo e scacciare l’horror vacui della crisi. Forte di queste convinzioni, soltanto un cuore avventuroso avrà il coraggio di raggiungere il fronte, poiché è alla ricerca di uno stile di vita maledettamente non-borghese, di un antidoto alla insoddisfazione, di un ideale per cui battersi fino all’estinzione. Accadrà che nel corso della guerra, il fuoco causerà quattordici ferite al corpo del giovane Ernst, ma il pericolo stesso finirà col correggere l’acerba vitalità della recluta: la Grande guerra trasformerà il giovane tenente in un uomo, ne scolpirà il carattere, permetterà lo sviluppo di un pensiero audace.
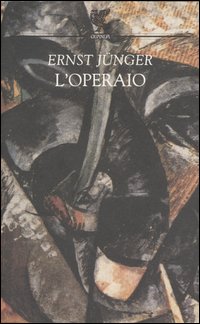
In tutto il primo periodo, Jünger dimostra di poter abbracciare, grazie ad una scrittura facile e dal contenuto sempre «a fuoco», vari temi: è passato, via via, dai resoconti di guerra, alle riflessioni psicologiche e biografiche per approdare infine, negli anni ‘30, al saggio teorico «impersonale». È agevole notare una natura di scrittore «poco regolata», desiderosa di espressione continua per mezzo di forme diverse e in grado di soddisfare una varietà di esigenze mai fissate a priori. Se la guerra lo ha costruito come uomo, il dopoguerra lo costruisce come scrittore, la scrittura viene utilizzata (secondo alcuni critici, in modo assolutamente inconscio) per superare le crisi del combattente e del reduce e le conseguenze psicologiche ad esse legate. Tuttavia se volessimo tentare una lettura organica degli scritti di cui si è detto, si rende opportuna la ricerca di un leitmotiv che percorra tutta l’opera jüngeriana, costituendone, per così dire, una spina dorsale ideale. Date le premesse, questo tentativo facilita la costruzione di basi idonee a liberare il pensiero di Ernst Jünger da quell’indeterminatezza che alcuni hanno evidenziato, accostandolo ad un tempo ad un ben individuato filone intellettuale e politico.
Per Marcel Decombis la ricerca di un solido punto di vista ha, in Ernst Jünger (malgrado la mancanza di uno specifico metodo) «principi assolutamente fissi», postulati da una forza eminentemente rivoluzionaria; vale a dire lo scrittore manifesta nelle proprie opere una volontà di rottura dello status quo coerentemente sostenuta da un atteggiamento negazionista. D’altro canto, Jünger non può essere annoverato tra i pensatori nihilisti: egli manterrebbe infatti un atteggiamento perennemente (anche se simbolicamente) positivo. Affrontando ogni difficoltà ma mai certo della propria sopravvivenza egli ha dimostrato di intendere l’esistenza, descritta prevalentemente nelle forme del diario-romanzo, nei termini di una vita che nasce dalla morte. Questo capovolgimento dottrinario della natura, già utilizzato da Hölderlin ma presente anche in Wagner e Nietzsche, rappresenta un omaggio sia alla viva forza come sostantivo imperituro, sia alla mortalità generatrice come presupposto di un’idea di immortalità. «Penetrato da questa convinzione, Jünger, chiede [...]che si faccia tabula rasa del passato, prima di porre le basi del futuro». Pertanto le durissime, tragiche prove contenute in ogni esistenza, servono soltanto da prologo al compiersi di uno spirito rigeneratore: guerra, caos, anarchia, non possono che rafforzare la volontà di ciò che è già forte, «la distruzione [non può che avere] un effetto creativo». Riassumendo: le crisi degli anni ‘20 conducono all’elaborazione di opere distruttive, prima di crudo realismo, poi di opposizione interiore, la rigenerazione si rivela nell’opera politica degli anni ‘30, quando tutte le difficoltà precedenti assumono la forma di una nuova dottrina.

Sebbene di diari di guerra, dotati di crudo e visibile realismo, la letteratura del primo dopoguerra abbondi, l’opera di Jünger «è unica nel suo spirito». Decombis individua in essa uno spirito ricco di certezze; i diari jüngeriani sono memorie «spogliate di ogni carattere soggettivo al punto da apparire come dei semplici documenti». In Stahlgewittern è un libro contenente un’elencazione di fatti, spesso identici, che si susseguono nella loro concreta monotonia, è un’opera senza censure, o convenienti omissioni che presenta pagina dopo pagina, un freddo spettacolo di estinzione ed un dietro le quinte fatto di snervante attesa. È il libro che riassume quattro anni di guerra. Das Wäldchen 125 mostra invece un particolare essenziale della lunga esperienza del fronte: la difesa di una postazione di prima linea, è un episodio che in sé riassume la violenza degli attacchi e dei contrattacchi. Feuer und Blut è la narrazione di un giorno al fronte: la controffensiva tedesca del 21 marzo 1918 (evento che Jünger non dimenticherà mai); il soggetto è, dunque, ancora una volta la Grande guerra.
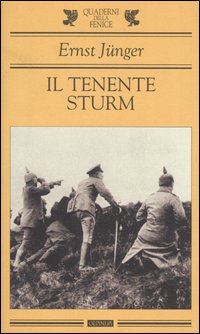
Dunque, a ben vedere, la scelta dello scrittore è di non cantare le lodi della guerra in modo dissennato, bensì di rappresentarla con totalizzante realismo, tentando di ricercarne «un’anima» che possa superare l’emergere delle contraddizioni che la ragione stenta a spiegare. Così egli ha registrato la Materialschlacht, ha convissuto per anni con l’assoluta impotenza del soldato in trincea, ed andando alla ricerca di un proprio «ruolo da protagonista», ha inteso dare alla materialità proprie regole e confini. Jünger accetta la guerra tecnologica («il regno della macchina dinnanzi alla quale il soldato deve annullarsi [...]»), non c’è rimpianto per un passato fatto di eroismi, non c’è insoddisfazione per un presente ove le virtù eroiche non trovano posto; egli ricerca un ordine, un equilibrio tra uomo e macchina, consapevole del ruolo di assoluta importanza che la tecnica occupa, anzi rivolgendo la massima attenzione a quest’ultima, prevedendo già che nuovi comportamenti e nuove mansioni attenderanno l’uomo «prigioniero» della tecnica. Scopriamo cosi uno Jünger materialista che si «sforza di respingere tutte le illusioni dello spirito al fine di ritrovare il linguaggio dei fatti». Tuttavia l’uomo vuole restare «superiore» alla forza potenzialmente distruttiva della tecnica, egli può allora utilizzare quest’ultima come medium per «riaffermare la potenza dell’essere»; così il materialismo, che allontana dalla volontà dello scrittore qualunque superstizione idealista, diviene materia per operare personalissimi adattamenti: la realtà bellica si tramuta in evento estetico ove l’eroismo del singolo convive, in una continua ricerca d’armonia, con lo «strapotere» delle macchine. E poiché Die Maschine ist die in Stahl gegossene Intelligenz eines Volkes, le diverse forze della modernità amano procedere parallelamente.

-L’immagine dei corpi straziati, vale a dire la cruda realtà dei morti giacenti sulla superficie delle campagne.
Ovvero uno spirito-guida:
-Il respiro della battaglia che aleggia intorno alle truppe.
In proposito, scrive Jünger:
«Cresciuti in tempi di sicurezza e tranquillità tutti sentivamo l’irresistibile attrattiva dell’incognito, il fascino dei grandi pericoli [...] la guerra ci avrebbe offerto grandezza, forza, dignità. Essa ci appariva azione da veri uomini [...]» Accenti forti, espressi anni prima in terra francese anche da F.T. Marinetti, accenti forti ma così poco inusuali nella storia delle moderne nazioni. Pertanto In Stahlgewittern, concesse al lettore poche battute iniziali, mostra senza perifrasi, le vere conseguenze dei conflitti moderni: primo inverno di guerra, Champagne, villaggio di Orainville, un bombardamento, tredici vittime, una strada arrossata da larghe chiazze di sangue e la morte violenta che rimescola i colori della natura. Segue il terribile resoconto di una forzata convivenza con la morte e con le azioni di belliche, ove «l’orrore della guerra viene estetizzato in incantesimo demonico e trasfigurato in veicolo estetico di accesso ad una sfera superiore [...]».
La vita comincia al crepuscolo in trincea e continua nelle buche scavate nel calcare e coperte di sterco. Si combatte una guerra di posizione che richiede un davvero difficile eroismo tanto da lasciare poco spazio alle illusioni: l’importante non è la potenza o la solidità delle trincee, ma il coraggio e l’efficienza degli uomini che le occupano. Bohrer sostiene che la rappresentazione dell’orrore in Ernst Jünger, serve a fornire della guerra una «immagine critica», vale a dire l’estetizzazione della stessa sarebbe il solo metodo in grado di darne un’idea reale. D’altro canto, la realtà medesima della guerra diviene realtà «superiore» poiché ogni valore e modello tradizionale è stato da lungo tempo dimenticato.

In tutto il resoconto c’è un’impronta magico-fiabesca, una coincidenza degli opposti, che unisce all’esplosione di forze elementari una continua ricerca della quiete cosmica: la battaglia viene sovente destorizzata e calata in una superficie mitica, al di sotto della quale la scrittura jüngeriana edifica possenti colonne, così si legge infatti: «La guerra aveva dato a questo paesaggio [davanti al canale di Saint Quentin] un’impronta eroica e malinconica». In mezzo ai colori della natura «anche un’anima semplice sente che la sua vita assume una profonda sicurezza e che la sua morte non è la fine».
Il tentativo di esorcizzare la guerra, minimizzando gli eventi tragici e costruendo a propria difesa un mondo magico, condurrebbe in tal modo Jünger alla creazione di figure irreali, è questo il caso dell’immagine classica dell’eroe immortale, immerso nella contemplazione di una natura amica. D’altra parte anche l’amatissima letteratura apparirebbe, e non di rado, come incredibile via di fuga. Scrive Jünger, durante un assalto:
«L’elmetto calato sulla fronte, mordevo il cannello della pipa, fissando la strada, dove le pietre lanciavano scintille all’urto con le schegge di ferro; tentai con successo di farmi filosoficamente coraggio. Stranissimi pensieri mi venivano alla mente. Mi preoccupai di un romanzo francese da quattro soldi, Le vautour de la Sierra, che mi era capitato fra le mani a Cambrai. Mormorai più volte una frase dell’Ariosto: “Una grande anima non ha timore della morte, in qualunque istante arrivi, purché sia gloriosa!” Ciò mi dava una specie di gradevole ebbrezza, simile a quella che si prova volando sull’altalena al luna park. Quando gli scoppi lasciarono un po’ in pace i nostri orecchi, udii accanto a me risuonare le note di una bella canzone: la Balena nera ad Ascalona; pensai tra me che il mio amico Kius era impazzito. A ciascuno il suo spleen».
La guerra diventa strumento di intima e eterna vittoria, epifania dell’arte. L’uomo Jünger, traghetta il guerriero in un kunstwald: i pensieri fanno da sfondo ad una tragedia che conosce un’eroica, ma mai sinistra, tristezza. Repentinamente lo sguardo indagatore si affaccia a scrutare gli abissi della guerra ove la passione umana trascolora all’urto di invincibili forze ctonie, leggiamo: «È una sensazione terribile quella che vi si insinua nell’animo quando vi trovate ad attraversare, in piena notte, una posizione sconosciuta, anche se il fuoco non è particolarmente nutrito; l’occhio e l’orecchio del soldato tra le pareti minacciose della trincea sono messe in allarme dai fatti più insignificanti: tutto è freddo e repellente come in un mondo maledetto». Il mondo maledetto è forse soltanto l’arena della tecnica e delle tecniche di guerra? Osservato dalla trincea, il Welt jüngeriano assume i contorni della fabbrica. Compiuto da schiavi-stregoni, l’apprendistato diventa giorno dopo giorno, utilizzo produttivo della paura: la fusione dei materiali in forze onnipotenti.