Il «De reditu» di Rutilio Namaziano è lo specchio di una classe dirigente ormai allo sbando
di Francesco Lamendola - 19/12/2011
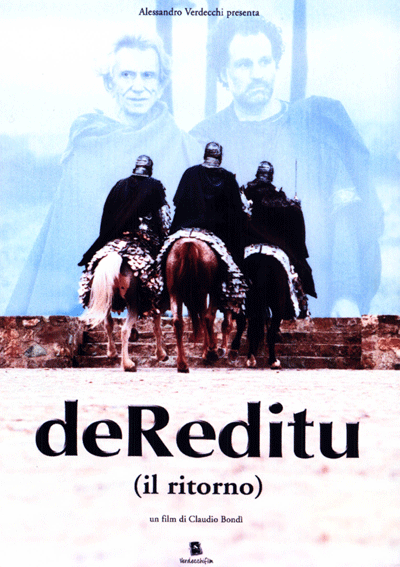
Nel 415 dopo Cristo, il nobile Claudio Rutilio Namaziano lascia Roma, di cui era stato, l’anno prima, Praefectus Urbi, per fare ritorno nei suoi possedimenti in Gallia e verificare i danni arrecativi dai barbari; e tale viaggi di ritorno è occasione per la stesura di un poemetto in distici elegiaci, «De Reditu suo», velato di una intensa, struggente malinconia, che è anche l’ultima perla della letteratura romana pagana.
Nel 410 la stessa Roma era stata messa a sacco dai Visigoti di Alarico: evento sconvolgente, che a molti era sembrato preannunciare la fine del mondo, dato che l’Impero di Roma era associato all’ecumene, secondo la formula mirabilmente espressa nei versi stessi di Rutilio: «Urbem fecisti, quod prius orbis erat»: «di ciò che era soltanto un mondo, hai fatto una città».
Poiché il transito lungo le strade consolari è divenuto insicuro per le scorrerie dei barbari e per la presenza dei briganti, ma soprattutto a causa del crollo dei ponti, che le ha rese di fatto intransitabili, Rutilio è costretto a servirsi di una imbarcazione che, dal Porto di Augusto, ossia Ostia, risale lungo le coste della Tuscia e della Liguria, per poi proseguire fino in Gallia.
Il poemetto, scoperto solo verso la fine del quindicesimo secolo nel monastero di Bobbio, ci è giunto incompleto, perché il manoscritto sopravvissuto si ferma al sessantottesimo verso del secondo libro; recentemente, nel 1973, sono stati rinvenuti da Mirella Ferrari altri trentanove versi, che narrano la navigazione fino ad Albenga e che lasciano pensare come l’opera comprendesse l’intero itinerario da Ostia fino alla meta finale, Tolosa, presunta città natale di Rutilio; o, almeno, fino all’arrivo nella Provincia transalpina, la Provenza odierna.
Con un vivo e fresco senso della natura, e con un senso ancor più vivo dell’amicizia, di cui l’Autore ha un vero e proprio culto, il poemetto descrive dettagliatamente le tappe del viaggio e i principali eventi che lo caratterizzano; ma su tutto domina la tristezza di un mondo agonizzante, con le campagne incolte, le città abbandonate, gli edifici in rovina («Semirutarum urbium cadavera», «cadaveri di città semidistrutte», aveva detto, con cupo ma efficace realismo, qualche anno prima, il vescovo di Milano, Ambrogio).
Dal punto di vista spirituale, la posizione di Rutilio è quella di un aristocratico pagano che non capisce i tempi nuovi, che non accetta il cristianesimo e che ha orrore dei barbari invasori; non si scaglia apertamente contro la nuova religione, né lo potrebbe (fin dal 380 l’editto di Teodosio ha messo fuori legge i culti pagani e l’imperatore regnante al suo tempo, Onorio, ha ulteriormente rafforzato la legislazione antipagana), ma lo fa indirettamente, scagliandosi contro i monaci delle isole dell’Arcipelago toscano, che hanno scelto una vita di solitudine e di preghiera.
Lo scrittore li chiama, con disprezzo misto a compassione, «uomini che fuggono la luce» e lamenta la follia che li porta a isolarsi dal genere umano, per coltivare un genere di esistenza che gli riesce assurdo e incomprensibile; e di fatto esso rappresenta tutto ciò che Rutilio detesta: la negazione della vita terrena, del culto degli dei, della sacralità della natura; ma quello che più lo fa infuriare è il disprezzo della socialità, identificata con la “humanitas”.
Quei monaci che fuggono la luce e vanno a rintanarsi nelle grotte, come animali selvatici, rappresentano una umanità degenerata, innaturale, un rifiuto della vita stessa e delle sue responsabilità; sono, quindi, indirettamente - anche se non lo dice - responsabili, o corresponsabili, del declino del’Impero, dacché a questo sono venute a mancare le forze migliori, quelle dei giovani del ceto senatorio, la classe dirigente che aveva fatto la grandezza di Roma.
Rutilio vive in un mondo chiuso: nel suo poemetto parla un po’ di tutto, ma sembra che non si sia reso conto che le basi economiche e sociali dello Stato sono irreparabilmente rovinate, per non parlare di quelle morali e religiose; rimpiange il passato e detesta il presente, ma non sa proporre alcun progetto alternativo, tutto quel che sa fare è chiudersi in una sterile nostalgia della passata grandezza e levare un canto di amore commovente alla grandezza di Roma, ferita a morte dal sacco di Alarico, «regina bellissima di un mondo già tuo».
Egli è il classico rappresentante di un ceto sociale, la nobiltà senatoria, proprietaria di immensi latifondi in Italia e soprattutto in Gallia e Spagna, la quale non riesce a confrontarsi realisticamente e costruttivamente con le forze sociali e culturali emergenti: quelle forze che lo storico Arnold J. Toynbee chiama efficacemente il proletariato interno, rappresentato dai contadini poveri e semiliberi, e il proletariato esterno, ossia le popolazioni germaniche le quali, dai confini dell’Impero, premono e dilagano al suo interno, specialmente dopo la decisiva battaglia di Adrianopoli del 378 e il passaggio del Reno, nel Natale del 406.
Del cristianesimo si è già detto: Rutilio non vede in esso che gli aspetti negativi, l’intolleranza dei nuovi vincitori (si veda la vicenda della famosa disputa per l’Altare della Vittoria fra Simmaco e sant’Ambrogio, oppure la distruzione del Serapeo di Alessandria d’Egitto), il fanatismo dei monaci, il senso cupo e angoscioso del peccato, il tutto contrapposto alla bellezza e alla luminosità degli dei olimpici, del modo di vivere proprio dei nobili pagani, esteti raffinati le cui ville somigliano sempre di più a delle incongrue oasi fuori dalla storia - e, dal punto di vista economico-sociale, a delle “curtis” del Medioevo feudale.
Scriveva il grande latinista Italo Lana a proposito di Rutilio Namaziano e della sua opera (in: I. Lana, «Storia della civiltà letteraria di Roma e del mondo romano», , Casa Editrice G. D’Anna, Firenze, 1984, pp. 406-407):
«Nel poemetto in distici elegiaci “De reditu suo” Rutilio narra il suo viaggio per mare verso la Gallia: imbarcatosi al Porto di Augusto (Ostia) e costeggiate le rive del Tirreno sino a Luni, qui la narrazione si interrompe, all’inizio del secondo libro. Ma una fortunata scoperta ci ha restituito, nel 1973, mutili, 39 versi del secondo libro, da cui apprendiamo che nel seguito del viaggio Rutilio toccava poi Genova e Albingaunum (Albenga); per cui è ora lecito supporre che il poemetto narrasse per intero il viaggio di ritorno da Roma alla Gallia.
La descrizione delle varie tappe di questa singolare navigazione di questa singolare navigazione di piccolo cabotaggio offre occasione al Poeta di rievocare e celebrare amici suoi, tutti appartenenti all’aristocrazia senatoria (vivissima è nel poemetto la coscienza di gruppo - se così la si po’ chiamare -: Rutilio e i suoi amici sono convinti di appartenere ad una categoria di persone superiori): in mezzo ad un mondo fumante di rovine, essi, superbamente appartati, trascorrono il loro tempo in cerimoniosi incontri e colloqui, in vacanze prolungate, passando dall’una all’altra villa. Quale stridente contrasto con le miserande condizioni delle città! Rutilio si sofferma a descrivere le rovine di Castro Nuovo; le poche misere case di campagna di Alsio e Pirgi (tutto quel che resta di due già fiorenti cittadine); Gravisce spopolata, Cosa ridotta a rovine, Populonia distrutta dal tempo. Rutilio nota tutte queste rovine, con malinconia; ma il suo spirito non s’arrende: nonostante tutto egli ha fede in Roma, alla quale innalza un inno fervoroso che è una vera professione di fede, e nello stesso tempo può considerarsi come il manifesto dell’intellettualità pagana, che non accetta l’impero cristiano e, non sapendo proporre un concreto programma politico da contrapporre ed eventualmente sostituire a quello dell’impero cristiano, si rifugia nel culto della grandezza passata di Roma, di cui esalta le autentiche glorie: e in primo luogo la diffusione, da lei operata, della civiltà nel mondo. A Roma, dea genitrice degli dèi e degli uomini, si rivolge con infiammate parole:
“fecisti patriam diversis gentibus unam […] urbem fecisti quod prious orbis erat”.
Alle rovine e ai disastri contrappone la fede nell’immortalità della dea Roma. Rifiuta il colloquio con le forze nuove che ormai si impongono: il Cristianesimo ed i barbari. Egli continua a parlare il suo linguaggio, che è quello delle passate età, ma il distacco dalla realtà è ormai irrimediabilmente segnato. Il medesimo distacco era già in Simmaco, in Macrobio, e negli altri letterati della rinascita pagana, ma lo si avvertiva meno, perché quelli non affrontavano, nelle loro opere, temi attuali. Rutilio, invece, si scaglia contro i monaci, che nelle isole dell’arcipelago toscano vivevano vita ascetica; li condanna per la loro fuga dal mondo e mostra di aver capito, la pacifica sostanza della rivoluzione che il cristianesimo stava attuando, quando dei monaci, ch’egli vedeva trasformati in esuli volontari, i quali nulla più avevano di umano, quasi per effetto di un livello beveraggio di Circe, scrive:
“tunc mutabantur corpora, nunc animi” (“allora venivano trasformati i corpi, ora le anime”).
Circe trasformava i corpi, il Cristianesimo trasforma le anime. Poiché questa trasformazione si compie, il mondo antico finisce. E con Rutilio finisce nell’esaltazione dei benefizi da Roma distribuiti a tutta l’umanità: lo sguardo rivolto a passato, in reverente contemplazione. Ma intanto il mondo cammina: e Rutili e gli attardantisi pagani poiché si arrestano immobili in questa contemplazione, sono inesorabilmente travolti dal moto della storia.»
Nel 2003 il regista Claudio Bondi ha tratto dal poemetto di Rutilio Namaziano un interessante film, intitolato «De Reditu» e interpretato da Elia Schilton nel ruolo del protagonista, ma che, purtroppo, è passato quasi inosservato, forse perché il pubblico italiano è troppo preso dai kolossal miliardari prodotti a Hollywood e pieni di attori superstar, per accorgersi di un film nostrano, realizzato con mezzi modestissimi ma con gusto, intelligenza e bravura professionale.
La tesi del film, che forza alquanto l’opera di Rutilio facendone l’itinerario di un senatore pagano che cerca addirittura di organizzare in Gallia una reazione conto l’Impero cristiano, per deporre l’imperatore Onorio e sostituirlo con un suo correligionario, è scopertamente ideologica e non poco astratta, in quanto contrappone schematicamente un Rutilio idealista e commovente nel suo anacronismo, ad un mondo nuovo dominato da grettezza, conformismo e oppressione.
Infatti, anche se non vengono nascosti i lati più discutibili dell’aristocrazia senatoria pagana, a cominciare dalla passività, dal conservatorismo sterile e dal feroce egoismo sociale, nel complesso il regista non si sottrae ai soliti luoghi comuni anticristiani, che, sulla scorta dello storico settecentesco Edward Gibbon, rappresentano la caduta dell’Impero Romano come «il trionfo della barbarie e della religione», ossia non mostrano altro, nel cristianesimo stesso, che un fattore di indebolimento e, alla fine, di dissoluzione della compagnie statale, e questo proprio nel momento del massimo pericolo.
Un giudizio più spassionato dovrebbe, invece, riconoscere che fu proprio ad opera del cristianesimo che poté essere salvata l’eredità della cultura classica: se gli imperatori dopo Costantino non avessero aderito alla nuova religione (con la breve eccezione di Giuliano, nel 361-63), e se le frontiere non avessero retto fino al principio del V secolo, dando così tempo al cristianesimo di penetrare fra i popoli germanici, e sia pure nella forma dell’eresia ariana, è estremamente dubbio se sarebbe mai rimasto qualcosa della civiltà di Grecia e di Roma e, quindi, se la cultura occidentale sarebbe riuscita a metabolizzare un trauma come la perdita delle proprie radici.
Non possiamo dimenticare, infatti, che, se le opere di Platone e Aristotele, di Omero e Virgilio, di Tito Livio e di Tacito sono giunte fino a noi, alimentando la cultura europea ben prima della “rinascita” umanistica (basti pensare a Dante e alla «Commedia»), lo si deve proprio a quel cristianesimo che Rutilio tanto detestava e, con lui, i raffinati intellettuali pagani della tarda romanità, particolarmente quelli dei circoli neoplatonici.
Se furono dei monaci cristiani a sobillare la folla crudele che assassinò Ipazia, la filosofa pagana, per le vie di Alessandria, furono pure dei monaci cristiani a copiare con pazienza infinita, salvandoli dalla distruzione, i grandi testi della cultura antica, e perfino quelli che poco o nulla si accordavano con la nuova religione - si pensi solo al «De rerum natura» dell’epicureo Lucrezio.
Quanto ai barbari, la cui presenza invadente tanto irritava quelli come Rutilio (tanto che furono essi a istigare l’assassinio del generale vandalo Stilicone, nel 408, l’unico che avrebbe potuto salvare Roma), vale lo stesso ragionamento: dove il ricco e colto pagano non sa fare altro che chiudere gli occhi davanti ad una realtà sgradita, i cristiani riuscirono a dialogare con i “barbari”, trasformandoli in coloro che avrebbero difeso, di lì a poco - contro gli Unni di Attila, per esempio - quella stessa eredità culturale che, in un primo tempo, sembravano intenzionati a distruggere.
Opera di difesa della civiltà europea che continuò nel corso dei secoli, e che - sia pure anche attraverso episodi atroci, come lo sterminio dei Sassoni pagani da parte di Carlo Magno - permise all’Europa medesima di salvarsi da nuove e più tremende ondate provenienti dall’esterno: quelle dei Vichinghi, degli Ungari e dei Saraceni, in pieno decimo secolo.
Bisogna tener conto di tutto questo, prima di dare una valutazione complessiva circa la posta in gioco nel conflitto fra cristianesimo e paganesimo, durante gli ultimi decenni di vita dell’Impero romano.
Se la vecchia classe dirigente pagana, preoccupata solo dei propri interessi particolari e incapace di dialogare con le forze nuove esterne ed interne, fosse rimasta alla guida dello Stato, che cosa ne sarebbe stato della civiltà greco-romana, che cosa ne sarebbe stato dell’Europa futura?

