L’11 settembre e l’Arabia Saudita
di Michele Paris - 22/05/2016

Fonte: Altrenotizie
Il dibattito in corso negli Stati Uniti sul possibile coinvolgimento di esponenti della monarchia saudita nell’organizzazione degli attentati dell’11 settembre 2001 si è infiammato questa settimana dopo l’approvazione di una legge cruciale da parte del Senato di Washington. Il provvedimento in questione prevede che i parenti delle vittime di attentati terroristici sul suolo americano possano denunciare in un’aula di tribunale governi stranieri che hanno avuto una qualche responsabilità in questi stessi fatti.
La questione è da collegare alle ipotesi che circolano da oltre un decennio sul finanziamento e l’assistenza logistica fornita da membri del regime di Riyadh ad alcuni degli attentatori, dei quali 15 su 19 erano appunto di nazionalità saudita. Secondo i famigliari delle vittime, e molti anche all’interno del governo americano, le prove della responsabilità del principale alleato degli USA in Medio Oriente - dopo Israele - sarebbero contenute in una sezione di 28 pagine del rapporto del Congresso sui fatti dell’11 settembre finora mai resa pubblica.
La legge approvata martedì all’unanimità dal Senato è chiamata “Justice Against Sponsors of Terrorism Act” e fissa delle eccezioni al dettato di un’altra legge del 1976 che, in larga misura, garantisce ai governi stranieri l’immunità dalle cause legali nei tribunali americani.
Il provvedimento in discussione deve essere ancora approvato dalla Camera dei Rappresentanti, ma il presidente Obama ha già annunciato di voler ricorrere al potere di veto per bloccarlo. Visto il sostegno ottenuto dalla legge al Senato, però, al momento sembrano esserci al Congresso i numeri per neutralizzare il veto della Casa Bianca.
Il presidente si è detto contrario alla legge ufficialmente perché l’eventuale incriminazione di un governo straniero negli Stati Uniti aprirebbe la strada a ritorsioni legali in molti paesi, i quali a loro volta potrebbero revocare accordi di immunità in caso di reati commessi da cittadini americani.
Se ciò è indubbiamente vero, e Obama ha tra l’altro ammesso involontariamente che il suo governo è responsabile di crimini all’estero, la prudenza della Casa Bianca nei confronti dell’Arabia Saudita sembra essere dovuta a considerazioni di natura principalmente strategica.
Per comprendere l’atteggiamento di Obama è necessario interrogarsi sulle motivazioni che hanno spinto il Congresso soltanto ora a sostenere, nientemeno che all’unanimità, una misura che viene richiesta da più parti nella società civile USA da parecchi anni.
La classe politica di Washington aveva finora sostanzialmente coperto possibili complicità dell’Arabia Saudita nei fatti dell’11 settembre, bloccando sul nascere qualsiasi iniziativa legale dei parenti americani delle vittime. Di recente, invece, sembra essersi formata una coalizione di forze ad altissimo livello che intende spazzare via l’immunità di cui gode l’alleato.
Indubbiamente, le scosse e il rimescolamento che hanno riguardato negli ultimi anni il mercato petrolifero hanno reso meno determinante il ruolo dell’Arabia Saudita per gli Stati Uniti. Tuttavia, messaggi come quello rivolto questa settimana da Washington a Riyadh implicano una volontà, piuttosto insolita nel quadro delle relazioni bilaterali, di richiamare all’ordine l’alleato, se non addirittura di punirlo, per ragioni ben precise.
Se non è semplice decifrare le sfumature di un rapporto privilegiato che dura da molti decenni, da tempo sono evidenti le frizioni tra i due paesi, quanto meno dalla rivoluzione in Egitto nel 2011 che aveva visto l’amministrazione Obama voltare le spalle al presidente Mubarak sull’onda delle proteste di piazza e in seguito al sostegno, sia pure di breve durata, al governo dei Fratelli Musulmani.
I rapporti si sono ulteriormente incrinati dopo la marcia indietro di Obama sui bombardamenti contro il regime di Assad in Siria nel 2013 e la firma dell’accordo sul nucleare iraniano lo scorso anno, che ha posto le basi per il ritorno da protagonista sullo scacchiere regionale della Repubblica Islamica, vale a dire il principale rivale della monarchia saudita. Malgrado Washington e Riyadh condividano lo stesso obiettivo in Siria – il rovesciamento del regime alauita – l’appoggio militare e finanziario ai gruppi fondamentalisti dell’opposizione da parte saudita e le posizioni irremovibili nei confronti di Damasco devono avere inoltre suscitato le preoccupazione di molti all’interno del governo e dell’apparato militare americano.
Malgrado Washington e Riyadh condividano lo stesso obiettivo in Siria – il rovesciamento del regime alauita – l’appoggio militare e finanziario ai gruppi fondamentalisti dell’opposizione da parte saudita e le posizioni irremovibili nei confronti di Damasco devono avere inoltre suscitato le preoccupazione di molti all’interno del governo e dell’apparato militare americano.
Più in generale, gli sconvolgimenti che stanno attraversando il Medio Oriente, assieme alla necessità da parte degli Stati Uniti di orientare il proprio impegno diplomatico e militare verso Russia e Cina, cioè le reali minacce percepite al loro dominio su scala globale, hanno spinto l’amministrazione Obama a ricercare soluzioni almeno temporaneamente di relativo compromesso in questa regione.
Ciò ha inevitabilmente mandato in crisi il regime saudita che si è visto in qualche modo messo da parte dal proprio principale alleato. Riyadh ha così iniziato a percorrere strade parzialmente divergenti dagli USA, come è evidente in Siria o in Yemen, ma anche dalle aperture diplomatiche e commerciali verso Mosca e Pechino.
Nonostante tutto, l’amministrazione Obama appare molto cauta nel trattare con i sauditi, anche se l’opposizione alla legge da parte del presidente potrebbe anche essere una sorta di gioco delle parti per esercitare pressioni sugli alleati in maniera indiretta. Sezioni della classe dirigente americana sono comunque in qualche modo schierate per la protezione dei rapporti con l’Arabia Saudita, come quelle che fanno capo al direttore della CIA, John Brennan, tradizionalmente molto vicino alla monarchia del Golfo Persico.
Sul fronte legislativo a Washington, i senatori che si sono fatti promotori della recente iniziativa contro l’Arabia Saudita hanno sostenuto di avere inserito nel provvedimento una clausola che consentirebbe al dipartimento di Giustizia di sospendere i procedimenti legali contro paesi stranieri nel caso il governo dimostri di essere in grado di negoziare con questi ultimi una soluzione extragiudiziaria.
La reazione da Riyadh non si è fatta però attendere. Il ministro degli Esteri, Adel Al-Jubeir, ha affermato che la misura in discussione, se approvata, trasformerebbe “il diritto internazionale nella legge della giungla”. In precedenza, lo stesso diplomatico saudita aveva minacciato la vendita di 750 miliardi di dollari di titoli del Tesoro USA e di altri beni detenuti in America dal suo paese per evitare eventuali confische derivanti da future cause giudiziarie.
L’entrata in vigore della legge votata al Senato questa settimana potrebbe dunque portare alla declassificazione delle 28 pagine mai pubblicate del rapporto del Congresso sull’11 settembre. Per alcuni, in questa sezione non vi sarebbero prove incriminanti contro membri della casa regnante o del governo dell’Arabia Saudita, mentre altri sostengono il contrario.
Anche personalità politiche che hanno potuto leggere le famose 28 pagine indicano come in esse vi siano informazioni sul coinvolgimento di esponenti di spicco del regime nel sostenere gli attentatori. Tra di essi vi sono ex membri della commissione d’inchiesta sull’11 settembre, come l’ex senatore Democratico della Florida, Robert Graham, e l’ex segretario della Marina americana, il Repubblicano John Lehman.
Quest’ultimo, in una recente intervista al britannico Guardian, ha garantito l’esistenza di “una valanga di prove circostanziali dell’assistenza fornita da cittadini sauditi agli attentatori e alcuni di essi lavoravano per il governo di Riyadh”.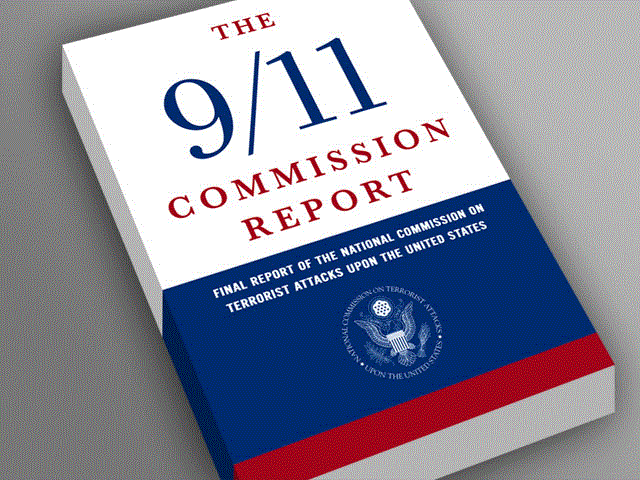 Le 28 pagine del rapporto sull’11 settembre potrebbero essere però solo una minima parte della documentazione esistente circa le responsabilità saudite, peraltro già emerse in parte da indagini giornalistiche seguite ai fatti del 2001.
Le 28 pagine del rapporto sull’11 settembre potrebbero essere però solo una minima parte della documentazione esistente circa le responsabilità saudite, peraltro già emerse in parte da indagini giornalistiche seguite ai fatti del 2001.
La testata on-line The Daily Beast, ad esempio, settimana scorsa ha scritto che l’FBI possiede più di 80 mila documenti segreti che riguarderebbero possibili legami tra membri della famiglia reale saudita e gli attentatori. Questo materiale sarebbe all’attenzione di un giudice federale in Florida nell’ambito di un procedimento intentato da tre reporter in base alla legge sulla libertà d’informazione.
La lettura delle carte starebbe avvenendo però in maniera molto lenta a causa dell’atteggiamento dei vertici dell’FBI che stanno cercando di restringere il più possibile l’accesso ai documenti dal contenuto potenzialmente esplosivo.

