Per farla finita con la paura della morte tra libro tibetano e Heidegger
di Giovanni Balducci - 21/08/2016

Fonte: Barbadillo
Nel corso della storia umana, la morteha costituito uno fra gli argomenti di maggior interesse, se non l’argomento principe, sul quale si sono esercitate le menti di uomini comuni, filosofi e maestri spirituali, se non altro perché la morte rappresenta nell’economia dell’esistenza forse l’aspetto più ignoto, consistendo in un momento di passaggio dalla condizione quotidiana a quella che si presenta come un definitivo cambiamento di stato, sia esso inteso come totale annullamento di vita e coscienza che come passaggio ad un altro ordine di esistenza in una dimensione oltremondana.
C’è da dire però – e ciò è di fondamentale rilevanza – come nella vita dell’uomo contemporaneo il tema morte sia stato quasi totalmente rimosso o occultato con una serie di finti problemi e strumenti di distrazione (l’accumulazione di ricchezze, il fenomeno del consumismo, i bisogni artificiali indotti dalla pubblicità, l’abuso della tecnologia), che fanno vivere l’uomo dei nostri giorni in una sorta di alienazione dalla vera realtà delle cose, quasi come se la morte non fosse e si dovesse vivere in eterno. Invero, la fuga dalla morte, il vedere una cerimonia funebre come qualcosa che riguarda gli altri ma non noi, è la strada di quella “possibilità inautentica” di cui parlava Heidegger.
È pur vero, tuttavia, che proprio questa sorta di ottundimento delle coscienze dinanzi al fatto reale, inderogabile e per molti versi spaventoso della morte, costituisce in molti casi una sorta di provvidenziale protezione da ‘risvegli’ improvvisi, che non sorretti dalla fede e da una adeguata conoscenza del mondo spirituale, sempre più carenti nell’uomo dei giorni nostri, possono condurre ad esiti catastrofici, a vere e proprie situazioni di spettralità dell’esistenza. Celebre in ambito letterario è il caso dello scrittore e filosofo del secolo scorso Emil Cioran, il quale ebbe a vivere una sorta di risveglio o presa di coscienza molto forte inerente la problematicità dell’esserci e della morte che lo spinse ad elaborare una filosofia pessimista, conducendolo nella condizione di chi, come il biblico Giobbe, giunge a maledire il giorno in cui è nato.
«Pensare all’improvviso che si ha un cranio – e non impazzire!», affermerà proprio Cioran in un suo noto aforisma. Propria del medioevo è, invece, la figura del monaco che vede nella contemplazione della morte uno strumento di liberazione dalle angustie della vita ed il riconoscimento e la ricerca di una più alta libertà, celebri sono le immagini di fraticelli intenti nell’osservazione di un teschio che l’arte cristiana ci ha tramandato. Allo stesso modo unacontemplatio mortis positiva la si è avuta in altri contesti e tradizioni religiosi, basti pensare ai riti compiuti in ambito induista e buddhista da asceti nei luoghi di cremazione dei cadaveri. Si pensi in particolar modo alle figure degli Aghori.
Gli stessi riti d’iniziazione delle società tradizionali hanno come sfondo il superamento della paura della morte. Funzione di preparazione alla morte ebbe la stessa filosofia, com’ebbe già a ravvisare Platone in un celebre passo del Fedone. Si ricordi come in quel romanzo iniziatico che è ilSatiricon di Petronio uno scheletro d’argento dalle articolazioni mobili faccia la sua apparizione in un banchetto, quale simbolo della morte e della brevità della vita, spingendo i convitati a godere appieno del banchetto, e dunque della fugace esistenza. Del resto, lo scheletro che faceva la sua comparsa nel corso delle àgapi non fu una rarità nell’antichità, basti menzionare le stesse danze macabre dell’arte medievale.
Invero, proprio dell’iniziato, di “colui che sa”, è il sentire d’essere un pellegrino su questa terra, egli come Mosè e il suo popolo in procinto di fuggire dalla terra d’Egitto, si cinge i fianchi, mangia in piedi e tiene in mano il bastone, stando nel mondo con una coscienza diversa rispetto a quella dell’uomo comune. «Voi siete nel mondo, ma non del mondo!» affermerà il Cristo. Corbin in molte sue opere definirà questo stare dell’individuo accompagnato dalla consapevolezza di una sua precisa altra appartenenza come ‘sentimento gnostico’ della vita.
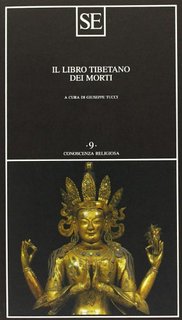 Si può ricordare, inoltre, come nella civiltà egizia e in quella tibetana esistettero i cosiddetti Libri dei Morti, che costituivano oggetto di meditazione da parte dalle élites sacerdotali al fine di prepararsi alle prove dell’aldilà. L’antichità concepì la fine della vita come ancora facente parte della vita, e il modo di morire come qualcosa che rappresentava il carattere, l’essenza della persona. Il mondo tradizionale conobbe l’idea della mors triunphalis, come nel caso della morte in guerra, una ‘morte immortalante’: è l’idea islamica, secondo la quale i guerrieri uccisi nella ‘guerra santa’ – jihād – non sarebbero mai veramente morti. «Non dite morti coloro che furono uccisi nella via di Dio; no, anzi sono vivi, però voi non ve ne avvedete» (Corano, II, 149); allo stesso modo la nostra classicità affermava con Platone (Platone, Repubblica, 468 e), «alcuni morti in guerra vanno a far corpo con la razza aurea che, secondo Esiodo, non è mai morta, ma sussiste e veglia, invisibile».
Si può ricordare, inoltre, come nella civiltà egizia e in quella tibetana esistettero i cosiddetti Libri dei Morti, che costituivano oggetto di meditazione da parte dalle élites sacerdotali al fine di prepararsi alle prove dell’aldilà. L’antichità concepì la fine della vita come ancora facente parte della vita, e il modo di morire come qualcosa che rappresentava il carattere, l’essenza della persona. Il mondo tradizionale conobbe l’idea della mors triunphalis, come nel caso della morte in guerra, una ‘morte immortalante’: è l’idea islamica, secondo la quale i guerrieri uccisi nella ‘guerra santa’ – jihād – non sarebbero mai veramente morti. «Non dite morti coloro che furono uccisi nella via di Dio; no, anzi sono vivi, però voi non ve ne avvedete» (Corano, II, 149); allo stesso modo la nostra classicità affermava con Platone (Platone, Repubblica, 468 e), «alcuni morti in guerra vanno a far corpo con la razza aurea che, secondo Esiodo, non è mai morta, ma sussiste e veglia, invisibile».
In ultimo, si può dire che da che mondo e mondo il valore di un uomo si è sempre misurato con la sua resilienza dinanzi alle perdite, alla sconfitta, alla nientificazione. Insegnava Mishima, che perciò seppe darsi la morte:
«La vita umana è strutturata in modo tale che soltanto guardando in faccia la morte possiamo comprendere la nostra autentica forza e il grado del nostro attaccamento alla vita. […] Una vita a cui basti trovarsi faccia a faccia con la morte per esserne sfregiata e spezzata, forse non è altro che un fragile vetro».
E poi, a quanto pare, non è detto che la morte porti alla nientificazione, stando a quanto afferma perentoriamente la Bhagavadgītā: «Ciò che esiste non può cessare d’esistere» (Bhagavadgītā, II,16), del pari Sant’Agostino ci rammenta che: «Non si perdono mai coloro che amiamo perché li possiamo amare in Colui che non si perde mai»: è a questa certezza infatti, che, nel pensare alla morte, l’uomo tradizionale fu fortemente ancorato, è la verità dell’Essere imperituro in cui tutti «viviamo, ci muoviamo e siamo», che sovrasta, rendendolo impossibile, il nulla, e dunque la nullificazione degli esseri. Perciò gli antichi furono saggi (sia chiaro, non tutti), poiché seppero fissare l’abisso della morte, scoprendone l’illusorietà, ma al contempo in base a ciò seppero prendere le misure alla vita.
i

