La rivolta che (forse) verrà
di Roberto Pecchioli - 27/02/2019
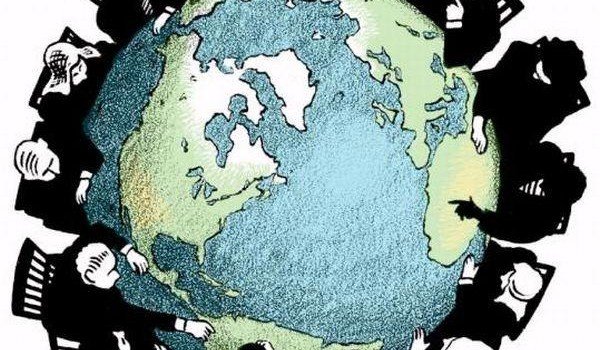
Fonte: Ereticamente
Warren Buffet, uno degli uomini più facoltosi del mondo, ha ammesso che nell’ultimo trentennio si è combattuta una guerra di classe e l’hanno vinta i ricchi. E’ così, ma Buffet omette di citare altri vincitori, i fiancheggiatori della classe dominante, i gruppi intellettuali accademici, culturali, dell’intrattenimento e dello spettacolo che hanno organizzato la società dei consumi, dei diritti e dei desideri, le sedicenti élite ritratte spietatamente da Christopher Lasch. Al loro seguito, sono vincitrici parziali, strumentali, una serie di minoranze divenute centrali nello schema ideologico e di potere che ci pervade. Dall’altro lato, la trascurabile maggioranza degli esseri umani, per utilizzare una felice espressione di Ennio Flaiano.
Trascurabile e trascurata sino a rendersene conto e diventare la spina nel fianco delle oligarchie, che per osteggiarla e combatterla hanno dovuto gettare la maschera, rivelando profondo disprezzo per i popoli e per la stessa democrazia. Ricordiamo i Peanuts, le celebri strisce a fumetti americane di Charles Schulz, le quali, attraverso le storie di un gruppo di bambini, rappresentano assai bene il sistema di valori, le idiosincrasie, i tic intellettuali del progressismo borghese occidentale. Charlie Brown sbotta: io amo l’umanità! E’ la gente che non sopporto. In un’altra striscia ammette di soffrire di claustrofobia del mondo. Serge Latouche lo definì furore universalistico. In un altro fumetto toccò a Linus, il ragazzino con la coperta, cordone ombelicale eternamente al collo, emettere un’altra imbarazzante sentenza: il mondo si divide in buoni e cattivi. I buoni stabiliscono chi sono i cattivi.
I buoni, costituiti in tribunale permanente con diritto di sentenza inappellabile e immediata esecuzione della pena, sono loro, l’oligarchia, i vincenti, gli hipster, finti, ridicoli anticonformisti della classe ricca, odiatori del popolo. Non possono più celarlo, né aspettarsi di orientarne le idee senza reazioni come nel recente passato. Con toni sprezzanti di fatale irritazione Hillary Clinton scagliò in campagna elettorale contro le classi popolari la spregiativa definizione di “spazzatura”, i poveri di razza bianca. Analogo giudizio era sfuggito al presidente francese Hollande, che chiamò “sdentati” i suoi oppositori di basso reddito che, guarda un po’, si permettevano di non votare a sinistra. Buon ultimo, il presidente emerito della nostra sgangherata repubblica Giorgio Napolitano, indispettito per l’insuccesso nel referendum del 2016 che segnò l’inizio della parabola discendente di Matteo Renzi, prodotto di laboratorio dell’iperclasse, attaccò la sovranità popolare che da presidente aveva giurato di custodire.
Adesso questa umanità spazzatura invisa alle élite sembra destarsi. Ha riempito i comizi di Trump nella provincia americana, è in prima fila nella rivolta dei gilet gialli francesi repressa con furibonda violenza dalla République della libertà e della fraternità, vota Salvini in Italia, Orban in Ungheria – ma è giustamente contraria alla sua riforma del lavoro – contesta Angela Merkel e l’ordoliberismo a spese dei ceti bassi, attraversa la Spagna ultra progressista con l’auge di Vox a difesa dello Stato nazionale e all’attacco felle follie del politicamente corretto. In Inghilterra ha imposto la Brexit, in Polonia e in altri stati dell’Europa centrale è al governo.
Esiste, finalmente, un ritorno di fiamma di milioni di persone la cui identità è essere persone normali, condividere la civiltà e la tradizione nazionale, etica e spirituale in cui sono nati. Molti neppure sono consapevoli di quell’identità, introiettata e vissuta come si succhia il latte materno. Sanno però che ciò che sono non ha alcun diritto sociale, né vogliono pentirsi o vergognarsi di se stessi. Dicevamo che negli Usa li chiamano “spazzatura bianca”. Pur tra grandi differenze, alcuni tratti accomunano i due lati dell’Atlantico. Il loro auto riconoscimento, come spesso accade, è in negativo. Sono esclusi dalle politiche identitarie condotte a favore di certe minoranze (LGBT, stranieri, gruppi etnici) vengono accusati di ignoranza e violenza. Sono – siamo – un gruppo sociale dai grandi numeri e modesta influenza. Non godiamo del favore degli attivisti dei diritti umani, non si fanno ricerche sociologiche su di noi, siamo disprezzati e serviamo unicamente al momento di pagare il conto: il nostro e quello di troppi altri.
Siamo accusati ogni giorno per lo schiavismo di ieri degli anglosassoni e dei francesi, per il colonialismo dei bisnonni (quello di oggi è nelle mani dei “buoni” del Fondo Monetario, dell’Onu e dell’Organizzazione Mondiale del Commercio), siamo responsabili per le diseguaglianze contro cui si invoca la “discriminazione positiva”. Fantastica formula, virtuoso ossimoro che giustifica quote obbligate di sussidi, posti di lavoro, funzioni dirigenziali, cariche politiche e altre misure a favore di gruppi definiti “sfavoriti” per sesso, razza, nazionalità, con l’evidente conseguenza di discriminare in negativo e concretamente tutti gli altri, la trascurabile maggioranza.
Tra i collettivi degni di ottenere sussidi, vantaggi sociali, posti di lavoro, esenzioni fiscali, la gente comune non c’è mai. Non è difficile verificare chi paga il biglietto sui mezzi pubblici e chi no, chi subisce le conseguenze di un’infrazione e chi resta immune. Basta partecipare a una coda presso un ufficio burocratico o una struttura sanitaria per rendersi conto che un numero crescente di “sfavoriti” ha diritti negati a troppi altri, la spazzatura della società che però sgobba e mette mano al portafogli per tutti. In più è circondata dal disprezzo, ed è questa evidente disistima delle classi alte e dei loro buffoni di corte intellettuali, giunta allo scherno a far scattare la reazione.
Si preoccupano delle derive razziste e xenofobe di alcuni e non hanno torto, ma non pensano mai, loro, i razionali, i riflessivi, di averle provocate con i comportamenti quotidiani e più ancora di utilizzarle, anzi invocarle come pretesto per eludere il dibattito, chiudere la bocca a ogni dissidenza. I totem del tempo, zeitgeist dell’Occidente terminale, sono il razzismo (male assoluto esteso a qualsiasi distinzione, ribattezzata discriminazione) e un’uguaglianza occhiuta e francamente ridicola, silenziosa sulla disparità più clamorosa, quella di reddito e risorse schizzata alle stelle a vantaggio della classe di Warren Buffet.
Assomigliano, le classi alte e gli intellettuali semicolti, al Conte Zio di manzoniana memoria: troncare, sopire. Ci accusano di tutto: non capiamo come funziona il mondo, quanto siano complesse le cose e quanto siamo fortunati di vivere la globalizzazione. Semplifichiamo troppo, concludono stizziti, ma fingono di non vedere la precarietà esistenziale e professionale, il rinchiudersi degli orizzonti di vita. Ci incolpano di avere paura – tutte le nostre miserabili idee sarebbero frutto di paura – ma non fanno nulla contro il timore di perdere quel che abbiamo e smarrire ciò che siamo.
Poco importa all’oligarchia se è necessario fare due o tre lavori instabili per guadagnarsi un reddito degno, lo stesso che avevamo 20 anni fa con un’occupazione stabile. Meno ancora interessa che non ci si sposi per mancanza di reddito o, se si fa il grande passo, si debba obbligatoriamente lavorare in due per mantenere un unico figlio e sperare di ottenere un mutuo. Sono perfettamente indifferenti alle ore di trasferimenti per raggiungere, dalle periferie dove ci hanno confinati, i luoghi di lavoro. Colpa nostra, la reazione alla rivolta dei gilè gialli ne è una prova. Nel frattempo dobbiamo condividere, noi, tanti poco felici, la metropolitana, il bus e il treno pendolare con altri precarizzati che non possono entrare nel centro delle città con le loro “obsolete” automobili e non hanno i soldi per cambiarle con quelle à la page, più “ecologiche”. Utilizziamo per necessità servizi pubblici, ma vediamo come gran parte delle nostre tasse è dedicata a sovvenzionare gruppi o comunità di cui non facciamo parte. Poi ci accusano di chiusura identitaria se ci lamentiamo di quelle che ci appaiono iniquità.
Il combustibile dello scontento è la proletarizzazione della classe media che ha tanto faticato per migliorare la sua condizione, l’impossibilità di vivere nei centri delle città, lasciate ai turisti e ai ricchi nelle zone pregiate, mentre i quartieri più vecchi sono occupati da mascalzoni di ogni nazionalità. Intanto si spopolano le aree interne e quelle in cui vengono meno i servizi privatizzati. L’economia “uberizzata” delle piattaforme informatiche straniere ci invade e il vecchio proletariato precipita alle soglie della povertà, ma non abbastanza da essere raggiunto da quel che resta del welfare, destinato agli ultimi arrivati e agli ex emarginati. In compenso, grava sulle spalle del “popolo basso”, della ex classe media, della piccola e media impresa e di crescenti settori delle professioni, il peso di una spesa pubblica burocratica, ingiusta, asfissiante, para mafiosa che pretende molto e non restituisce nulla.
Negli Usa, Amazon, l’impresa commerciale più grande del mondo, il cui proprietario, Jeff Bezos, è il più ricco del pianeta, non pagherà quest’anno un dollaro di tasse. Merito delle nuove leggi fiscali, ma soprattutto del vergognoso sistema di abbattimenti, deduzioni e caroselli aziendali che intossica i sistemi tributari dell’occidente. L’alternativa, dicono, sono i paradisi fiscali, ovvero gli inferni ove si ricicla il denaro provento dalle attività più indicibili. In Europa, i giganti tecnologici pagano meno di una piccola impresa. Un impiegato con reddito netto di duemila euro – un privilegiato – versa novecento euro mensili al fisco statale e locale, oltre ad altre centinaia per la chimerica pensione e l’assistenza sanitaria.
Pure, non siamo ancora spariti. Ci hanno respinti in una immensa periferia esistenziale, dalla quale dobbiamo ripartire per tornare in centro, riconquistare quel che è nostro. Siamo sopravvissuti al fuoco del disprezzo, del ridicolo con cui siamo trattati. Siamo l’unico gruppo etnico, noi spazzatura bianca, a cui non è permesso avere una storia. L’ Europa è piena di gente che si sente esclusa nella sua terra, dimenticata nella narrazione collettiva dominante, invisibile benché maggioranza, ridotta al silenzio, all’impotenza politica e alla nullità culturale a colpi di accuse di razzismo, xenofobia, discriminazioni e delitti veri e presunti del trapassato da espiare come colpa collettiva e personale.
Da vittime, ci hanno trasformato in carnefici con obbligo di solidarizzare con chi ci disprezza. Sindrome di Stoccolma come salvezza: uscire da noi stessi, alienazione più estraneazione. Incredibile è anche la schizofrenia del libertarismo postmoderno: drogarsi è lecito, proibire non si può, ma i fumatori di sigarette vivono in un apartheid ostile. Il moralismo spurio permette ogni sconcezza nell’ambito sessuale, assolve qualsiasi oscenità, ma porta dodicimila abitanti della liberale, tollerante, colta New York, capitale del Paradiso invertito, a chiedere al Metropolitan Museum di ritirare un famoso dipinto di Balthus, Therese che sogna, perché osceno e cripticamente pedofilo. Nessuno chiede di nascondere l’incomprensibile pseudo arte astratta o di nascondere la pubblicità sessualizzata di migliaia di prodotti.
La sindrome di Stoccolma deve essere sepolta insieme alla minorità culturale che ci attribuiscono senza possibilità di replica. C’è una speranza, forse stiamo tornando, con la bandiera della nazione, della tradizione e dell’identità, alleate della giustizia sociale e distributiva. Intanto, dobbiamo costringere il potere politico a recuperare dignità, non rimanere inerme dinanzi all’economia dei colossi tecnologici, delle piattaforme di falsa disintermediazione dei servizi, Deliveroo, Uber, Airbnb e simili, nonché della finanza di carta, l’imbroglio massimo. Non basta, bisogna rivendicare la legittimità delle culture popolari ridicolizzate dalle sedicenti élites. Circa vent’anni fa, usciva negli Usa Redneck Manifesto, il libro manifesto dei “colli rossi” di Jim Goad, che rappresentava le ragioni e la rabbia degli esclusi del classismo delle oligarchie e accusava la sinistra politica di mantenere un discorso che escludeva i ceti popolari e operai bianchi.
L’arma più potente del nemico è il nostro disarmo morale. Agli albori della crisi dell’Impero romano, Giovenale scriveva che due sole cose ansiosamente il popolo desidera: il pane e i giochi. Panem et circenses. Più intenso è il desiderio (la nostra è l’era dei desideri) nelle epoche di crisi; lo comprese dal rifugio di Port Royal Blaise Pascal. L’unica cosa che ci consola delle nostre miserie è il divertimento (divertissement), e intanto questa è la maggiore delle nostre miserie “(Pensieri, 171). Il sistema è specialista nell’organizzare la fuga di fronte ai problemi, ed è il più grande dei pericoli di un’azione eticamente orientata. Il rischio è quello di offrire risposte vecchie o escogitare scorciatoie valide solo per minoranze dotate di senso morale.
Le risposte anacronistiche sono il comodo rifugio in un neo collettivismo mortuario, ma va condannato il ricorrente istinto di chi finisce per servire, convinto di opporsi alla cosiddetta sinistra, l’unico a priori del liberismo, la concentrazione di mezzi, denaro e potere in poche mani private. Il sistema dell’accumulazione non vuole e non tollera alcun limite, morale, territoriale, religioso, culturale. Il liberismo è una spaventosa tabula rasa. Da questo deve partire la rivolta, o verrà divorata dal ventre immenso del Leviatano globale. Comunità più dimensione pubblica più socialità significa popolo in cammino. Il resto è la vittoria nemica, lo spettacolo che deve continuare, tra frizzi, lazzi, nani, ballerine e tanto sangue, il nostro. Business, as usual: affari, come sempre.



